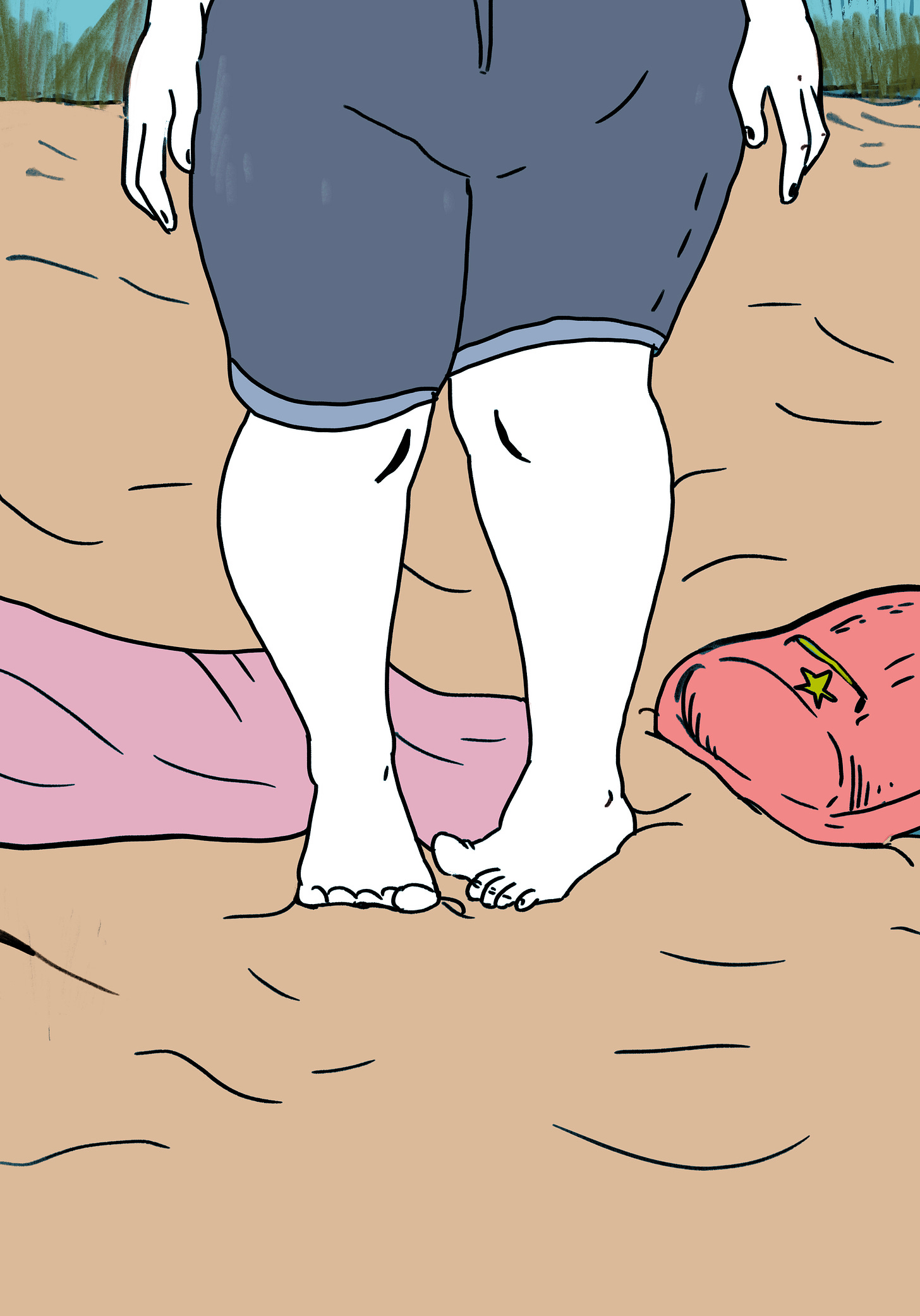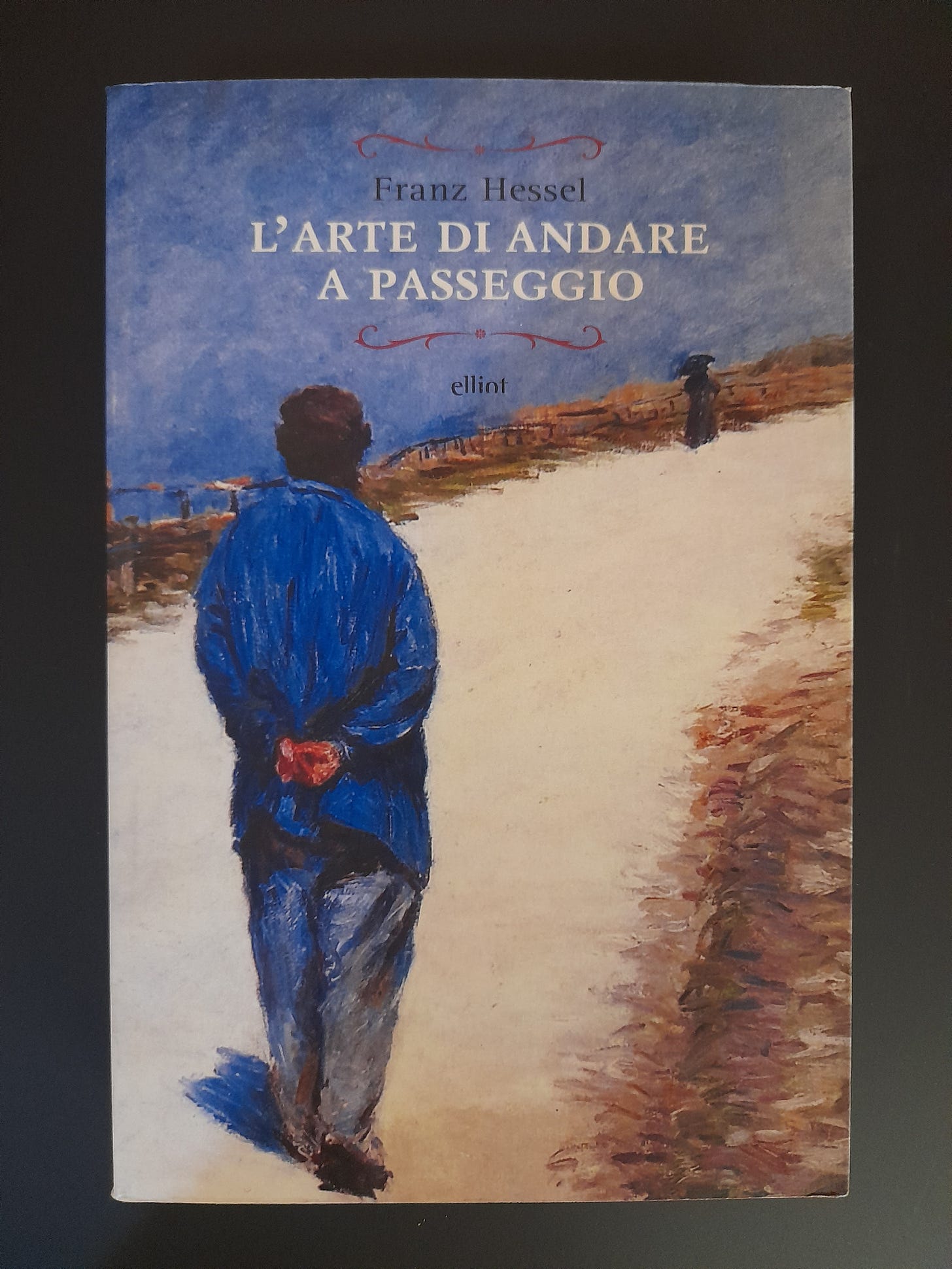MARE
di Luana Belsito
FLÂNEUR
di Davide Bregola
Mi capita giornalmente di camminare per la città e di guardarmi attorno con un certo tipo di sguardo. E’ lo sguardo di chi vorrebbe vedere tutto, ascoltare tutto, toccare tutto. E’ uno sguardo dei sensi, che ne accorpa tanti, non solo la vista. Mentre passeggio ho inscritte nella testa due o tre guide narrative che possono essere utili a tutti e s’intitolano “La passeggiata” di Robert Walser, “Nei sentieri di ghiaccio” di Herzog, “L’arte di andare a passeggio” di Hessel. Sono tre libri che insegnano come guardare il mondo e a me sono sempre serviti libri che insegnano perché non sono interessato all’intrattenimento. Se devo essere intrattenuto vado al circo, o al cinema, o a teatro o a vedere burattini o ascoltare musica o a vedere un mago prestigiatore. Intanto la differenza tra camminare e passeggiare è una differenza sostanziale. Si cammina per andare da un posto all’altro, perché si ha una meta. Si passeggia per gironzolare e vedere cosa accade senza aspettarsi nulla. Herzog nel libro citato cammina, perché sta andando a trovare a piedi un’amica malata. Deve portarle un paio di comodi calzari. Hessel compie scorribande, è un flaneur e come tale passeggia. Walser passeggia con questo suo sguardo unico in cui tutto appare fresco e nuovo. Ogni tragedia sembra si possa risolvere col suo sguardo. Quando vado in giro a piedi mi capitano avventure esemplari e mi sento un po’ il protagonista di un racconto di Walser, o di Hessel o di Herzog. Oggi per esempio sono uscito di casa perché dovevo gonfiare le gomme della mia bici, poi dovevo andare a fare aggiustare il telecomando del portone di casa e infine sarei andato a bere un caffè. Prima tappa meccanico di biciclette. Ho chiesto di gonfiare le ruote. “Faccia lei” mi ha detto il meccanico. Ho gonfiato, avrei dovuto pagare 2 euro e invece il tipo mi ha detto: “Vada vada…” Come non pago nulla? “Vada, oggi omaggio!” Così, bello felice, me ne sono tornato a casa per mettere giù la due ruote. E’ una bici da corse gialla, vecchia di almeno trent’anni, dalla sella scomodissima. Ma mi piace e la uso. L’elettricista del negozio vicino a casa ha aperto il piccolo telecomando nero e mi ha detto che si è staccato un pezzo che collega la batteria al tasto per aprire. Bisognava saldare. Ha portato il pezzo in laboratorio e dopo 3 minuti è tornato dicendo che adesso funzionava. Ho chiesto quanto gli dovevo ma mi ha detto che non sapeva dare un valore al lavoro fatto, così mi ha detto che non avrebbe voluto denaro. Bello felice e soddisfatto sono andato nel piccolo bar vicino alla chiesa dell’Alberti. Ero particolarmente sorridente perché mi sembrava che tutto il mondo fosse lì a gioire per qualcosa di non ben definito. Fosse anche la tragedia dell’esistenza, ma affrontata con la leggerezza di chi ha deciso di non credere al male. E io lì al bar non ci credevo affatto al male e alla signora Veruska sfoderavo un’ elegante presenza ottimista condita da un tono allegro. Le stavo dicendo che quel giorno sembrava andare tutto bene. “Mi faccia un buon caffè!” le ho detto con la voce squillante che so fare al momento giusto. Lei mi ha detto che sta cercando un cameriere o una cameriera garbati e di classe. “Proprio uno come lei…” mi ha detto rivolgendosi a me e guardandomi negli occhi. Ma io non ho mai fatto il cameriere in vita mia e soprattutto ho un’età che non mi permette di essere a mio agio tra cocktails e apericena. Però ho apprezzato e alla signora Veruska ho detto che avrei chiamato una mia bellissima e brava amica che ha esperienza nel settore. Ho tirato fuori moneta per pagare, ma anche lì era offerto. Uscito dal bar mi sono aggiustato il colletto della camicia blu e ho pensato quanto è bello guardarsi attorno per vedere tutto e niente. Due rondoni sfrecciavano sotto al portico per poi entrare nel loro nido. Ho guardato le vecchie pietre della Rotonda di San Lorenzo pensando a quali -di quelle che vedevo- potessero essere dell’anno mille e quali, invece, erano state messe recentemente con le ristrutturazioni. Avevo fatto tre cose per le quali avrei dovuto pagare e invece non mi sono costate nulla. Iniziavo quasi ad avere un senso di colpa, ma fortunatamente mi si è avvicinato un ragazzo alto e biondo col cellulare in mano dicendomi : “Ucraina, Ucraina”. Ho capito al volo, mentre due bellissimi bimbi e una ragazza si avvicinavano, che avevano bisogno di qualcosa. Cercavano il municipio perché, mi è parso di capire, avevano un appuntamento per la casa. Ho spiegato loro con chiarezza, in inglese, la strada da percorrere e si sono incamminati verso il municipio con una certa soddisfazione. Pure io avevo il cuore contento perché avevo fatto una buona azione e perché la mattinata era piena di azzurro, sole, rondoni, nidi e pietre antiche. Ho deciso così di andare nella gastronomia di fiducia perché volevo qualcosa di buono da mangiare. M’incammino verso via XX Settembre e costeggio una meravigliosa chiesetta barocca inscritta tra le case. Auto parcheggiate restringono la carraia. Fosse per me toglierei tutta questa ferraglia brutta da vedere, ma oggi accetto pure loro. Le famigerate autovetture. Davanti a me un signore con la camicia bianca a maniche corte cammina lento nel mio stesso senso di marcia. Anche se di spalle lo riconosco: è il signore con cui qualche tempo fa ho parlato di oro nel Po e di cercatori d’oro sul fiume. Gli passo a fianco prendendola larga. Alza una gamba e scorreggia due volte. Prrrot. Proott. Una mitragliata dietro l’altra. Cerco di non farmi notare superandolo di nascosto dietro un’auto grigia. Guizzo dall’altra parte della strada e due distinte signore con cagnolino stanno parlando di malattie e ospedali. Sento chiaramente una delle due: “Prossima volta che va in calore la faccio coprire e poi la faccio operare…” Spero stesse parlando del suo cane e allo stesso tempo ero dispiaciuto per quella specie di barboncino arruffato di cui si stava emettendo la sentenza. Ma tant’è, se fondassero il partito per la liberazione dei barboncini con guinzaglio sarei il primo sostenitore.
Tra un furgone bianco, e il rombo fastidioso di uno scooter, alcune persone ferme in prossimità di negozi parlano di malattie, malati, gente appena uscita dall’ospedale o in procinto d’andarci. Mi verrebbe voglia di fare come Walser che, incontrando le persone durante la sua passeggiata, prende il cappello e lo alza in segno di saluto galante. Secondo me oggi nel mondo manca questo, manca la galanteria.
Arrivo alla gastronomia e, pur essendo estate, prendo una meravigliosa porzione di lasagne al forno. “E’ solo da scaldare cinque minuti ed è pronta” mi dice la signora del negozio. Poi, pensando anche al valore della numerologia, prendo sedici meravigliose polpette. Il 16 nella smorfia è il culo ma è associato anche alla fortuna. E fortuna sia! Esco fischiettando un motivetto che mi ronza in testa: “La nostra casa è grande è come vuota sente molto la tua assenza…non riesco più a dormire solaaa…” Nessuno la ricorda. Sicuro. Tornando indietro incrocio di nuovo il signore che poco prima ha mollato due mitragliate a freddo. Lo saluto facendo finta di alzarmi la bombetta e gli dico: “Signore, si giochi il 16 sulla ruota di Venezia e brindi alla mia salute!”. Mi guarda stranito. Chissà se ha capito cosa intendo. Me ne vado col mio sacchetto in mano, mentre tutto gira nel verso giusto, le guerre sono lontane, le ziette coi cani operati sono andate via. L’economia è bloccata. Inflazione come negli anni ‘80 dello scorso secolo. Ma io ho Walser in testa. Ho Hessel e Herzog nella testa. Banjamin parla di “esperienza dello shock” e si riferisce ai continui urti in cui vengo catapultato dalla commedia al dramma. Bonne journée à tout le monde et va te faire foutre!
IL PRIMO DIAVOLO
di Jacopo Masini
Opera di Daniel Johnston
Una mattina di maggio Gianni Gaibazzi si è svegliato con gli occhi appiccicosi e la bocca impastata e ha sentito subito dentro di sé qualcosa di diverso, come un cambiamento repentino nei pensieri e nell'umore, tanto che, dopo essersi stiracchiato e alzato da letto scostando le coperte prima e infilando le ciabatte dopo, una volta giunto davanti al grande specchio verticale accanto alla porta della camera da letto ha detto tra sé: "Ecco qua, mi sono svegliato e son diventato il Diavolo".
Gianni Gaibazzi non si riferiva a un malumore, oppure a un vago e passeggero desiderio di distruzione – come ne capitano a ciascuno, ogni giorno, sebbene alla fine ognuno di noi rientri dopo poco sulla via del buon senso – no no, lui riteneva a ragione di essere diventato effettivamente il Diavolo, altrimenti detto Demonio, Belzebù o Satana, a seconda delle epoche o delle circostanze e fra sé, infatti, aveva aggiunto, avvicinandosi allo specchio:
"Vè che faccia da demonio che ho già messo su, da satanasso" e poi aveva urlato "BU!", di colpo, come a voler spaventare qualcuno, e infatti aveva spaventato se stesso, prova inequivocabile della propria trasformazione diabolica.
È caduto all'indietro per terra, atterrando col culo sul pavimento, per lo spavento, poi si è alzato, è andato in cucina a prepararsi la colazione, rimuginando tra sé sui cambiamenti che avrebbe comportato la sua natura demoniaca e ha iniziato fin da subito a progettare e strolgare dei modi per rompere i coglioni al prossimo, dissipare tutto sebbene non navigasse nell’oro, seminare zizzania, indurre in tentazione e tutte quelle cose che, come è evidente, sono prerogativa di un diavolo.
Mentre prendeva il barattolo del caffè e poi col cucchiaino riempiva di polvere di caffè la Moka ha iniziato a guardarsi le mani, a rigirarle, rimanendo molto sorpreso del fatto che fossero identiche a prima e non fossero diventate simili ad artigli, così come i piedi che, una volta sfilati dalle ciabatte, gli sembravano sempre uguali, non certo somiglianti a quelli di un caprone, o a degli zoccoli di altro tipo, o comunque a temibili piedi diabolici, quindi gli è venuto un dubbio.
Anzi, gli è venuto il dubbio di aver preso un abbaglio, magari, di essersi solamente illuso di quella trasformazione diabolica che non era mica avvenuta, in realtà, poi è tornato davanti allo specchio, ha abbassato la palpebra inferiore, si è fissato nella pupilla e ha indagato bene dentro la propria interiorità, che nello specchio coincideva con la pupilla, visto che le Sacre Scritture dicono che gli occhi sono lo specchio dell’anima, quindi uno specchio specchiato in uno specchio doveva certamente moltiplicare e rifrangere la natura di quell’anima, e Gianni Gaibazzi è giunto alla conclusione che quegli occhi lì erano certamente diabolici.
“Dio d’una madonna se son diabolici” aveva detto allontanandosi dallo specchio per fissarsi a figura intera, “guarda che pezzo di diavolo che sono” e subito dopo gli è venuto in mente di fare la prova del nove, cioè di verificare se magari la sua voce era diventata più profonda e mefistofelica, che lui non poteva accorgersene, visto che nessuno di noi, come sapeva bene Gaibazzi, riconosce la propria voce, ma solo gli altri la sentono per davvero.
Così è andato nell’ingresso, ha sollevato la cornetta del suo telefono grigio, ha girato la rotella per comporre il numero del suo amico Renato Robuschi, ha aspettato, uno squillo, due squilli, tre squilli, Renato Robuschi ha tirato su.
‘Pronto’ ha detto Robuschi.
‘Pronto, Renato, sono Gianni, ma probabilmente non mi riconosci e la mia voce spaventosa ti sta terrorizzando, ma sono io’, ha detto Gaibazzi.
‘Ben, Gianni’ ha detto Robuschi, ‘mi prendi per il culo o ti sei completamente rincoglionito?’.
Allora, Gaibazzi, preso alla sprovvista, è rimasto con la cornetta in mano, mentre Robuschi diceva ‘Gianni, ci sei? Dai là, rispondi’ e poi ha buttato giù.
È tornato davanti allo specchio, ha scrutato ancora nelle pupille e dopo aver visto che il suo aspetto indubbiamente diabolico era ancora lì, ha pensato che forse la voce ci metteva più tempo a demonizzarsi e ha deciso che non era mica il caso di star lì a farsi tante domande sulla propria identità, su chi era o non era. Non doveva mica star lì a farsi delle pippe con dei pensieri inutili, in altre parole, che la sua natura demoniaca era incontrovertibile, se la sentiva scorrere nelle vene. No, l’unica cosa da fare era entrare in azione, andare per il mondo e compiere delle azioni diaboliche e così si è vestito, si è messo la camicia, i pantaloni, poi la giacca, anche le scarpe ed è andato al bar a fare colazione.
Ha sceso le scale, è uscito dal condominio guardandosi intorno con aria mefistofelica, ma non ha incontrato nessuno, a parte la signora Mendogni del secondo piano, che non ci vedeva niente, farle delle facce mefistofeliche non serviva mica a niente.
Quando è stato davanti al bar ha scrutato dentro, ha visto che c’erano due persone appoggiate al bancone, Mario Ravanetti che leggeva la Gazzetta sol solito tavolo, ha esitato sulla soglia, ha stretto i pugni per farsi forza, come a raccogliere tutte le energie diaboliche che sentiva scorrere nelle vene, ed è entrato.
Ha sentito come un’onda di male e di caos e zizzania che si spandeva attorno a lui, appena dentro. Si è fermato, a ruotato la testa leggermente e sentiva di nuovo quelle energie maligne andare dal bancone a Ravanetti, da Ravanetti al bancone, in un andirivieni di forze incontrollabili e potenzialmente distruttive.
‘Gianni, cosa fai fermo lì, il pistolero dei film western?’ gli aveva detto Sergio Gavazzoli, il titolare del bar, indicandolo con la mano nella quale teneva una spugnetta gialla, mentre i due clienti al bancone si giravano e si mettevano a ridere e Ravanetti alzava la testa dalla Gazzetta per dire ‘È vero, vè, sembra John Vaine’ e si metteva a ridere anche lui.
“È il terrore che li fa parlare” pensava Gianni Gaibazzi, avanzando truce verso il bancone, serio, gli occhi iniettati di fuoco infernale, “ma adesso gli faccio vedere io”.
È arrivato al bancone ‘Un caffé’ ha detto, rimanendo serio, impassibile.
‘Un caffé a John Vaine’ ha detto il barista Sergio, voltandosi verso la macchina e mettendosi a preparare il caffé. ‘Eccolo qui’ ha detto poi, posando prima il piattino col cucchiaino e poi la tazzina sul piattino, ‘il caffé più buono dell’uest’.
Gaibazzi ha preso la tazzina, ha bevuto, ha stretto gli occhi a fessura, ha posato la tazzina vuota, poi si è girato e è andato verso la porta, senza pagare.
‘Gaibazzi, sono cinquecento lire’ ha detto la voce di Sergio Gavazzoli.
E lui, Gaibazzi, senza voltarsi, un passo già sul marciapiede, ha detto ‘Il diavolo non paga’ e ha fatto due passi per allontanarsi. Poi, dopo cinque o sei metri, ha sentito due sberloni nel coppino, che erano di Sergio il barista.
Questa è l’avventura del primo diavolo del quartiere Montanara, a Parma, il temibile Gianni Gaibazzi svegliatosi demonio un giorno di maggio. È andata così così, ma valeva la pena raccontarla.
SON TUTTE TRAPPOLE
di Elisa Baldini
Il mio babbo non vuole essere su Facebook, non vuole far parte del mondo dei social, perché dice che “son tutte trappole”. E ha ragione. Mi mà, però, ha ceduto qualche anno fa: s’è fatta Facebook, ma ci va solo con il PAD, come lo chiama lei. Con il PAD mia mamma fa anche delle fotografie, e, se sono rilevanti, le mette su Facebook, devo dire con didascalie sintetiche e bellissime. In queste diapositive di boschi, cigli e montagne sbuca, ogni tanto, nel mucchio, buttato lì nel mezzo nella speranza che passi come nota di colore o parte dell’ambiente, mi pà, che, comunque, in linea di massima non lo verrà a sapere. Poi succede che magari arriva al bar di Montemurlo, e qualcuno dei suoi amici gli fa: “Ieri sei stato a Gavinana?” Oppure: “Madonna quante ginestre c’erano alle Cavallaie!” E io me lo immagino, almeno le prime volte, che ci rimane di stucco, pensando a come fa questa gente a sapere cosa ha fatto lui ieri, chi ha spifferato, ci sono davvero orecchie senza ritegno proprio ovunque, anche tra i rovi, in questo mondo pieno di trappole! A volte io ho insistito per poter mettere, non so nemmeno io per quale motivo, poveromo, una sua foto o video nei miei, di socials, cercando di spiegargli che comunque nessuno lo avrebbe intrappolato in modo irrimediabile (falsissima) e dicendo anche cose per lui totalmente senza senso del tipo: “Tanto non ti taggo mica!” Brava Elisa: avrebbe un senso infinito taggare una persona che sui social non c’è. E lui, di spalle, mentre attizza il fuoco nel caminetto con la sua camicia a quadretti di flanella mi risponde: “Sarebbe a dire?” E io, con fare saputo, mi industrio a spiegare il significato del concetto taggare mentre mi sbuccio una bruciata via l’altra, e lui fissa dritto nel vuoto davanti a se, come se fosse stato risucchiato da un vortice spazio-temporale. Finito il mio discorsetto, si gira verso di me che intanto ho la bocca e le mani nere da quante castagne ho trangugiato, mi fissa negli occhi con una violenza che convincerebbe anche Zuckerberg in persona e mi intima minacciosissimo: “IO NON LA VOGLIO LA TAGGA!” Ok, la tagga non la vuole, e, in un primo momento, non vuole assolutamente che, in quel dell’internet, vengano sparse le prove tangibili della sua grande capacità e fama di fungaiolo. Ma lì si scontra contro la fierezza testarda di mi mà, che dopo aver affrontato vento, ghiaccio, paura dei cinghiali e anco dei lupi e delle vipere, dopo averlo magari aspettato per dei bei quarti d’ora nei cigli più battuti mentre lui, con il suo ginocchio che, parole sue: “Non va” si arrampica come una capra per portare a casa l’agognato bottino, non ce la fa a non far vedere al mondo di cosa sono stati capaci. E allora, zitta zitta, dopo che a casa hanno pesato la “merce” e prima di iniziare le operazioni che contribuiranno a farci venire a tutti un fegato grande come un pallone, fa una bella foto al canestro enfio di porcini, piglia il PAD e la schianta su Facebook condividendola con i suoi tipo 56 amici con la didascalia: “Non è andata male oggi” e poi va a cucinare funghi come non ci fosse un domani. A quel punto il bar di Montemurlo è in subbuglio: Marcellino è andato a funghi e li ha trovati, allora vuol dire che fanno, te l’avevo detto io! Ora se li è insaccati tutti lui, stai a vedi, e noi si rimane a bocca asciutta. Quindi un giorno che ero lì forse a farmi venire gioiosamente un fegato come un pallone mentre degustavo un fungo fritto, si palesa mi pà nero come un cappello che, ritirando fuori quello sguardo indiavolato della tagga, si rivolge a mia madre: “Non le devi mettere le foto su internet dei funghi, che mi smaldocchiano le gambe!” Io sputo il fungo dalle risate. Chiedo spiegazioni più accurate, ma ho già capito. L’invidia del fungo trovato porterà il maldocchio (noi toscani bisogna sempre far così, o si leva qualcosa alle parole, tipo, LO SO LO SO, la consistenza della C, oppure si aggiunge roba, ma lo si fa solo per essere più precisi o confondere a spregio un po’ le acque, che magari uno pensa si parli di cose apotropaiche ed invece si sta solo parlando di oftalmologia). Ed il malocchio farà andare ancora meno quelle ginocchia così macagnate, che però diventano zampe di capretto se c’è nell’aria l’idea di un porcino fresco. E allora mi mà, per amore del quieto vivere, i funghi non li mette più su Facebbok, finché non li mette, che ne so, la Renza o la Patrizia, quelli di su marito, che praticamente sono una bigoncia. E quando è sul PAD la mi mamma li vede, ed esclama: “Madonna quanti ne ha trovati Maurino!” “Dicché?” “Di porcini, bada là” E allora le orbite di mi pà non ce la possono fare, entrano in Facebook, vedono il bottino altrui, e subentra la GARA, la PERFORMANCE, e da quel momento in poi, pur continuando a rimanere valido il VETO del suo volto, quando tornano da funghi, se il raccolto è andato bene, la foto di rito con la foglia di felce alla pagina Facebook di mi mà non gliela leva nessuno. Anzi, si inscena proprio un set dove viene dato maggior rilievo agli esemplari più sani e di maggior dimensioni, ci si scervella per capire con quale luce la foto non verrà sfocata o troppo “lucente”, e niente, la battaglia oramai è aperta. E lo smaldocchio delle gambe e di cosa altro non si sa è stato messo in secondo piano, perché niente può contro la forza purificatrice della verità, che deve sancire chi è il miglior fungaiolo di Montemurlo. E poi sui funghi non c’è mica la sua faccia, al massimo smaldocchieranno loro. Forse. Tutto questo lungo preambolo per introdurre così, velocemente direi, il tema del malocchio: tema quanto mai attuale, nel mondo che mio padre vorrebbe rifuggire, dove tutto quello che si fa in realtà non si è fatto se non s’è messo su Facebook e/o su Instagram. Dove tutti possono vedere, e, quindi, e lo si mette in conto, assumendoci i dovuti rischi del caso, smaldocchiare ed essere smaldocchiati. In queste settimane ho fatto un po’ di ricerche tra conoscenti ed amici, e penso che il signor Wikipedia che ho consultato stamattina si sbagli: il 40% delle persone al mondo che crede nel malocchio mi sembra un dato inesatto. Alla luce dell’incredibile quantità di campionario umano consultato ( direi circa 30 persone) posso senza dubbio affermare che abbiamo un 80% che ci crede, un 18% possibilista, ed un 2% che ha detto NO senza alcun dubbio, sono cose tribali etc etc.. Io, cresciuta in una famiglia di origini contadine, ne ho sempre sentito parlare, ed ho assistito spesso, anzi, sono stata anche sottoposta, a quelle buffe pratiche dell’acqua nell’olio con il piatto sopra il capo, che, mi hanno detto i partecipanti al sondaggio, esistono ancora, anche se trovare uno fidato, sicuro, a cui hanno insegnato BENE (perché i detentori più adulti del sapere oramai sono, per la gran parte, belle tutti iti) è veramente difficile. Quindi siamo qui, soli, impauriti, a dubitare che una foto di noi a gambe ritte al mare con uno spritz sbrilluccichente in mano, oppure di noi che ADDIRITTURA ci beiamo pubblicamente di un buon risultato ottenuto nelle nostre esistenze così bisognose di traguardi e certezze possa incorrere in quello sguardo lì, in quell’occhio marugano che non sappiamo bene cosa ci porterà, in che modo devierà il corso degli eventi, senza avere un vaccino sicuro, un metodo esatto riconosciuto dalla scienza o validato da chi ha tramandato il sapere, perché le nostre madri erano sicuramente distratte dai nuovi acquisti fatti alla Standa quando le nonne stavano insegnando loro a tutelarsi dagli sguardi di sbieco altrui. E quindi grazie a questa pressappochezza di chi doveva imparare, noi ci si rimette. Noi chi? Chi ci crede. Io no. O meglio, io non ci voglio credere. Perché comunque, nella mia testa maniaca di controllo, io non posso accettare tutto questo dubbio, tutte queste domande senza risposta. Chi mi dovrebbe smaldocchiare? E perché? Su Wikipedia si legge che le cause principali per cui si dovrebbe smaldocchiare la gente sono: invidia e gelosia. Quindi potenzialmente tutti possono essere invidiosi di qualcosa, anche in maniera inconscia, anche delle cose più deficienti, tipo il fatto che io posseggo una palla di Natale a forma di Ringo Star unica al mondo perché ha due mani sinistre. E allora, io come posso fare a proteggermi? E via con gli amuleti: la croce in una mano, il cornetto nell’altra. Tocco ferro, tocco legno, il sale se mi casca oltre a smadonnare perché ho fatto un casino dell’80, devo pure durare fatica, chinarmi e tiramelo dietro le spalle, se mi casca l’olio poeramme, un trincio per la casa e pure l’angoscia per la sfiga che mi sono attirata, se la Maison du Monde mi fa arrivare a casa uno specchio che per me costa quanto un rene ROTTO allora io devo allertare la NATO perché mi portino in un bunker. E queste sono cose tangibili, che succedono: se uno è un poco meno disadatto di me o dei corrieri della Maison du Monde magari ti salvi, e dormi sogni tranquilli. Ma lo sguardo delle genti, spesso pure che non conosci bene, che si trovano di fronte il tuo viso allegro davanti ad un pino marittimo tutto storto di Baratti, che cazzo mi potranno fare? Quando le variabili sono così impazzite, io devo mettere un FERMO, come al Phantom negli anni 90: fine delle trasmissioni. Io non ci credo, fate voi. Però io questo terrore panico che mi spinge a rigettare la fede nello smaldocchiamento generale lo voglio teorizzare, e allora lo teorizzo. Io credo solo nel caso e nella volontà. Il caso crea OCCASIONI, buone, cattive, potenzialmente buone, potenzialmente cattive, e io lì allora non vado a cercare uno che mi risucchi con delle ventose, che poi mi fanno venire le piaghe, la negatività di dosso, ma mi adopero per fare qualcosa. Se posso farlo. Se non posso farlo alzo le mani, e mi metto ad aspettare. Qualcosa di buono, prima o poi, anche solo per una questione di statistica, succederà.
Il caso ha voluto che due delle serie le cui nuove stagioni erano fra le più attese del momento abbiano entrambe delle implicazioni in questo senso (ed io non farò SPOILER, qui lo dico e qui lo nego) Stranger Things 4 e Peaky Blinders 6. Non ho mai sentito così tante volte il termine CURSED come durante gli 11 giorni di reclusione da COVID che mi sono sciroppata allietandomi con le disavventure di Hawkins e gli smaldocchii che s’è preso nel capo Thomas Shelby (ancora non ho finito la stagione, ma ad oggi, di preciso il perché non l'ho capito. Credo c’entri uno zaffiro, anch’esso maledetto, una sorta di maledizione gitana. È uno spoiler questo? Mi sa di sì). Stranger Things 4, che mi è piaciuto abbastanza nella sua deriva un po’ da Esorcista in salsa teen, si basa proprio su questo assunto: sei per un attimo attraversato da un pensiero maligno anche inconscio, flebile? Le tue azioni anche involontariamente hanno avuto una piccola parte nella disgrazia altrui? Ciao ciccio, tu sei maledetto te ora, cazzi tua, tu vai di là, dove è tutto nero, tuona sempre senza piovere quasi mai, e se piove, non piovono polpette, ma pipistrelli con la faccia a pianta carnivora indemoniata. Certo è che, questa storia della maledizione che crea macello nelle vite ne produce di script che funzionano al 100% anche oggi nel 2022. Altro sintomo di quanto sia attuale questo tema così incontrovertibile per la generazione della mia nonna Ottavina. In fin dei conti la conversazione più illuminante sul tema l’ho avuta l’altra sera con una mia amica, durante la mia prima uscita dopo il Covid o la maledizione del Covid da cui ero stata afflitta (e che ancora del tutto via non è andata, perché mi pizzica ancora la gola). Lei al maldocchio ci ha creduto per tanto tempo, ha pensato che le sfighe che le erano capitate per ben 7 anni dipendessero di sicuro da qualche maleficio lanciatole. Ha quindi messo in campo tutti i mezzi che ha trovato e che le hanno suggerito per liberarsi da queste disdette. Poi ad un certo punto s’è rotta le scatole, non ha fatto più niente: e le cose, mi ha detto, sono cominciate ad andarle meglio. Segno che forse il suo karma si era finalmente ripulito. Io, che avevo bevuto uno Spritz dopo 2 settimane che non toccavo alcol, e già dopo la terza sorsata avevo fatto 2 o 3 figure di merda, mi sono sentita affermare con la saggezza di Socrate: “Quanto potere diamo alle nostre menti. Pur di non accettare che il mondo è dominato solo dal caso, e di cosa succede a me, a te o a quello là, non gliene può fregare di meno!” Lei è stata due minuti in silenzio e mi ha detto: “Forse hai ragione. Però come è banale pensarla così. Pensare che abbiamo questo potere rende tutto più magico, meno noioso.” “Quindi in sostanza noi ci creiamo queste soap opera intricate tutte mentali per romperci meno le palle?” “Forse sì.” “Ma il caso non è banale, ne fa succedere di tutti i colori.” E poi giù con la mia teoria oramai rodata: “Io credo nel caso e nella volontà.” Poi mi è andato di traverso lo Spritz e ho tossito mezz’ora. Questo aprirebbe altre ipotesi sulla possibilità di uno smaldocchiamento instantaneo da parte del concetto di malocchio, che si è ribellato e mi ha dimostrato che dovrei fare meno Seneca e temere un po’ di più questi poteri del mondo e ragionare meno di volontà come se fossi Antonio Gramsci. Oppure no. Mi sono semplicemente quasi strozzata con uno Spritz, e per caso mi sono salvata. Questo mi ha dato occasione di vivere ancora un po’, e di scrivere questa incredibile trattazione scientifica che non dimostra niente se non una cosa: il mi babbo è duro come il legno, ha idee tutte sue su tutto, spesso mi fa così incavolare che devo prendermi ferie dal vederlo per qualche giorno sennò ci litigo a morte, però talvolta ha incredibilmente ragione. Sono veramente tutte trappole, e alla fine, smaldocchiamento o no, ciò che conta è che i funghi sono lì, nel congelatore, son diventato sugo da cucinare o prugnolo frozen da usare alla bisogna sulla pizza. L’evidenza della conquista, la forza della volontà dei suoi ginocchi sbilenchi, ci hanno dato l’occasione di rovinarci il fegato anche quest’anno. E basta.
SCRIVERE
di Marco Ghizzoni
Capita, a volte, che non abbia voglia di scrivere. Mi sento stanco, pigro, fatico al solo pensiero di creare personaggi e imbastire storie, tessere trame e orditi, così mi prendo delle pause, faccio altro. Con la lettura, invece, non mi capita mai, soffro di una sorta di bulimia letteraria che mi porta a leggere tre, quattro libri contemporaneamente a causa dell'impazienza di iniziarne di nuovi il prima possibile. Me ne capitano di mediocri, di buoni, di straordinari, di strani; alcuni li dimentico, altri si incistano nella mia mente e non se vanno più, altri ancora tornano dopo mesi o addirittura anni, ma ciò che conta, per me, è l'atto della lettura, la meraviglia delle parole immobili sulla carta, pertanto non me ne preoccupo. Nel momento in cui scrivo, per esempio, me ne vengono in mente almeno una ventina, ma siccome lo spazio è quello che è, faccio una cernita istintiva e il primo che salta fuori è lo splendido “Nessuno è come qualcun altro. Storie americane”, raccolta di racconti della scrittrice Amy Hempel di cui Sem sta pubblicando l'intero catalogo. Allieva di Gordon Lish, leggendario editor di Raymond Carver, ha fatto sua la lezione del saper raccontare i momenti prima della battaglia della vita, o quelli tra una battaglia e l'altra. Si muove con maestria nella quotidianità, nell'immobilità, sa rendere speciale l'ordinario attraverso una scrittura senza effetti speciali, dove a contare sono la sintassi, le parole, il passo. Nei quindici racconti che compongono la raccolta – quattordici brevi o brevissimi, l'ultimo lungo cinquanta pagine, quasi a fare da contraltare, a creare un equilibrio alfabetico – la Hempel ci presenta personaggi alla deriva che ce l'hanno fatta, che stavano per farcela o che hanno fallito, com'è nella natura delle umane cose. Non ci sono eroi, solo persone comuni e ferite che non sempre si rimarginano, rimpianti e rimorsi, come se volesse suggerirci, attraverso una scrittura ironica e compassionevole, che vale la pena saper perdonare e perdonarsi, accettare la sconfitta. Sceglie la storia molto breve, brevissima, il racconto a più voci, il narratore esterno, i dialoghi, il monologo, tante voci, una voce. Il luogo a volte è solo evocato, altre è nominato. L’ambientazione è sempre funzionale allo stato d’animo dei personaggi, le paure e i desideri sono quelli di sempre. La Hempel arriva dritta al punto, non tergiversa, non usa mai lo stesso registro: la sua scrittura è pura meraviglia, abbacinante bellezza.
Scarto mentalmente Céline, Soldati, Bontempelli, Busi, Hempel, Hogg e Lermontov e faccio la scelta più ovvia e scontata: un libro che parla di libri e che si intitola appunto “Libri. Non danno la felicità (tanto meno a chi non li legge) del critico letterario Luigi Mascheroni, pubblicato da Oligo editore. Un pamphlet che in neanche 50 pagine smonta la stucchevole retorica sui libri e rivendica il diritto di non finire un libro, quando addiritttura di non cominciarlo nemmeno – e di preferirgli, se è il caso, una serie tv, un film o persino un videogame. Nessuna missione salvifica, insomma, niente librerie definite “farmacie dello spirito” (ricordate? si era in pieno lockdown da pandemia). I libri non rendono le persone migliori: non c’è casta come quella degli intellettuali più percorsa da invidie, gelosie, rivalità, egoismi, ipocrisia. I più efferati dittatori si circondavano di libri. Luigi Mascheroni è un fuoriclasse, il libello caustico e dissacrante come pochi altri. Adesso vi saluto: come dicevo all'inizio, scrivere mi stanca, ho bisogno di sdraiarmi a leggere.
IL PICCOLO EROE. L’UOMO CHE TI DÀ APPUNTAMENTI VERI.
di Elisa Rovesta
“Quanti ce ne sono di “non so”, “vediamo”, “se mi libero presto te lo dico” ecc…E non importa se sei carina, intelligente e simpatica, importa che non c’è quel piccolo eroe che “lotta” per te.”
Queste sono le parole di Lara, o Giulia o di tanti altri nomi. E lei, Lara, o Giulia o chiunque sia come loro, queste parole non le pronuncia con rammarico, ma solo con una presa d’atto.
Certo, ne ha incontrati tanti di uomini che avrebbero voluto uscire con lei, oh se ne ha incontrati.
Infatti, è carina appunto, si prende cura del suo aspetto e del suo intelletto. Sorride quando parla con le persone, è gentile, dice sempre grazie e le piace parlare. Solo che nonostante riceva tante proposte per bere, ad esempio, un aperitivo con un ragazzo, o per andare a mangiare qualcosa in un ristorante, queste proposte non le paiono mai reali. Le riceve innanzi tutto solo via messaggio ad esempio tramite whatssapp, o messenger, e questo un po' le dispiace perché lei, di telefonate da qualcuno che voglia sentire la sua voce, non le riceve più.
E allora si adatta e quando conosce qualcuno via con i messaggi e via con il tunnel carpale che si infiamma. E via con le parole scritte sbagliate, anche perché si sa con il gel sulle unghie è un casino scrivere bene tutti i caratteri, e via ancora a dare la colpa per i propri sbagli al t9, e via a parlare in differita attraverso messaggi vocali.
Si i messaggi vocali, che qualche volta sono lunghi e durano “addirittura 3 minuti”, e quando Lara o Giulia o chiunque, se ne accorge lo cancella subito e lo fa di fretta schiacciando con il ditino quel piccolo microfonino che si vede sulla tastiera, che se per caso stai facendo qualcosa non è nemmeno facile da tenere premuto. “Tre minuti di messaggio vocale a un tipo” dice tra sé Lara o Giulia “tre minuti sono tanti, troppi, cosa pensi provi o vuoi, va concentrato in meno tempo cazzo, meno.” E poi continua, sempre da sola: “non ho imparato proprio niente dalle storie di Instagram”.
Esatto, le storie di Instagram o meglio quei i messaggi subliminali, che solo uno dei followers spesso può capire. Non si sa però di preciso se questo messaggio subliminale lo capisce questo lui, perché mentre lei sta postando la storia con un’immagine, ad esempio la foto di un locale nel quale si sono incontrati, inserendo una canzone con parole mirate, ad esempio “mi vengono i brividi” di Blanco e Mamhood, ecco lui è fuori con gli amici e non la considera proprio.
Quindi la poveretta, data la durata delle stories ha 24 ore di tempo per ottenere una “risposta” da lui. Se nelle 24 ore lui visualizza la storia allora si sono “parlati”, se in più lui commenta, ad esempio, con una faccina che sorride, allora questo rappresenta discorsone tra i due, pieno di complicità e pathos.
Ma, nonostante ciò, Lara o Giulia o chiunque come lei, spera magari di uscire insieme più spesso. Lui attraverso un messaggino le risponde “non lo so, nel caso ti scrivo”. Oppure, all’ultimo minuto, mentre lei sta postando una storia che ritrae tutto il suo entusiasmo, il ragazzo in questione le scrive che “proprio non ce la fa ad incontrarla”.
In tutto questo Lara o Giula o come si chiama, sconsolata riceve un messaggio attraverso Instagram. E’ un ragazzo che conosce di vista e lo trova interessante. Dopo un breve scambio di messaggi lui le chiede il numero di telefono e lei, con il sorriso un po' rassegnato di chi ha male al tunnel carpale ma sa che dovrà ancora sforzare il polso, glielo passa.
Il giorno dopo lei sente squillare il telefono, e no, non è sky che le vuole offrire una nuova promozione (i pochi rimasti che ti chiamano davvero) è lui, il ragazzo che conosce di vista e che trova interessante.
Lui le dice che voleva sentire la sua voce, e fare due chiacchiere con lei.
Lei, un po' stranita ma felice gli racconta la giornata che sta vivendo e lui fa lo stesso. Nei giorni seguenti lui le scrive qualche messaggio e la chiama più volte e poi le chiede di uscire, dicendole che ha fatto di tutto per liberarsi per le 21 apposta per poter stare con lei (un gesto epico, pensa lei).
Così escono, e lui le racconta la sua vita. No, la vita di lui non è per niente facile, ha alle spalle un divorzio difficile, casini con la ex moglie, e purtroppo anche la madre di lui, alla quale è molto legato ha seri problemi di salute. Nonostante la paura di lui di legarsi sentimentalmente, nonostante il dolore per la situazione della madre e nonostante i numerosi impegni di lavoro, l’uomo si presenta davvero all’appuntamento e non le scrive nemmeno che è in ritardo.
L’appuntamento è vero, il suo interesse è vero, e Lara o Giulia o chiunque sia come lei, pensa di avere incontrato un piccolo eroe che nonostante le difficoltà della vita, addirittura “le telefona” e le dà appuntamenti reali.
Lei se ne innamora subito. È grata a Instagram per aver dato loro la possibilità di “incontrarsi” ed è grata al suo piccolo eroe che le da appuntamenti veri, per essersi districato nella vita reale e averla fatta sentire reale.
E, scegliendo una canzone che entrambi capiscono, con semplicità si guardano negli occhi e si sorridono, senza hashtag.
HELAGR HOLDEFÖSS, SCRITTORE ISLANDESE
di Igor Ebuli Poletti
Lo scrittore islandese Helagr Holdeföss aveva intenzione di farsi un caffè ma non aveva voglia di cercare la caffettiera, sapendo da sempre che la caffettiera era necessaria per fare il caffè. Intuiva oscuramente, per uno di quei contorti meccanismi logici che lo caratterizzavano, che da qualche parte doveva essere presente, dopo anni di inutilizzo, una caffettiera con tutte le sue parti ancora intonse, ma non ne era affatto sicuro. Non era mai sicuro di niente, figurarsi di dove potesse essere una caffettiera. Lo scrittore islandese aveva scritto il suo primo, e per ora unico libro, al bar, come aveva letto che facevano i giovani scrittori americani con gli occhiali dalla pesante montatura in acetato. Pur non essendo giovane e americano, dopo essersi procurato un paio di occhiali con la montatura in acetato si era seduto tutti i giorni per un anno intero allo stesso tavolo dello stesso bar di Reijkiavik, Il cigno zoppo, e lí aveva scritto il suo capolavoro “La vita di Stonne Gunnardsson, veterinario.” Il libro aveva avuto uno straordinario successo in tutta l’Islanda, era stato ristampato in edizione economica, e aveva reso lo scrittore islandese un vero scrittore islandese. Nel corso dell’anno che aveva impiegato a scriverlo aveva bevuto 1670 caffè, e solo da poche settimane riusciva a pensare alla coffea arabica senza vomitare. Ora, però, non trovava la sua caffettiera e non era ancora pronto per tornare al bar. lo scrittore islandese doveva portare la macchina in carrozzeria, pare che anche nella brulla e orograficamente inusitata Islanda girare con una Saab azzurrina, non azzurra, proprio azzurrina, senza una portiera fosse motivo di stupore e sorpresa. Questo nonostante non si incontrasse anima viva per centinaia di chilometri ma secondo la polizia islandese non era possibile circolare con una macchina senza una portiera. Lo scrittore islandese, che aveva una passione per le storie strane soprattutto scritte dagli altri, decise di togliere anche la seconda portiera, girando quindi con una Saab azzurrina senza portiere. Fu per lui motivo di grande delusione non essere fermato che dopo 6 mesi di scorribande automobilistiche, con peripli inani di bocche di geysers, da una poliziotta in bicicletta, che ignoró l’assenza di entrambe le portiere e gli chiese l’ora.
Lo scrittore islandese Helagr Holdeföss era indeciso se uscire a cena o mangiare a casa, come faceva di solito. Una cosa veloce, forse del pesce, poco pane, il pane islandese é pessimo ed essendo lui uno scrittore islandese lo sapeva bene, qualche verdurina al vapore di contorno e poco altro. Senza uscire a cena, senza entrare in quei piccoli ristoranti islandesi pieni di islandesi che mangiano cibo islandese parlando islandese. Una noja devastante. Stava per togliere dal suo pacchetto color lichene un robusto pezzo di trota islandese quando si trovó a fissarla negli occhi. Un vecchio detto islandese dice di non fissare mai negli occhi un pesce morto perché pare che all’anima non faccia benissimo ma Helagr detestava i detti, soprattutto quelli vecchi, e i suoi occhi incontarono quelli della trota, morta. In quegli occhi vide quelli di tante altre trote morte, vide anche qualche balena in condizioni fisiche non ottimali, e alla fine si risolse a ordinare una pizza. Senza acciughe. Lo scrittore islandese doveva cucinare una coppia di zucchine ma era incerto su come farlo. Zucchine in umido? Zucchine fritte? Zucchine con patate? Solo dopo aver pensato a come cucinarle si rese conto di non avere zucchine da cucinare. Lo scrittore islandese decise di farsi un tè. Lo scrittore islandese stava scrivendo di vita e di morte. Si stava anche annoiando perchè era stufo di scrivere di gente che prima vive e poi muore, ma pare che a quelli che compravano i suoi libri interessasse solo questo, sapere come e quando morivano i suoi personaggi. Questo era quelli che gli aveva detto l’editore, almeno. Lo scrittore islandese era infastidito dalla luce che entrava dalla finestra, che illuminava subito le parole. Le sue parole, quelle che stava scrivendo: lo scrittore islandese preferiva scrivere in penombra, le parole dovevano affiorare piano piano, non subito, ci voleva una certa preparazione, se no l’effetto finale sarebbe stato peggiore di quello voluto. Ci vorrebbe una quarantena delle parole, pensava, che le facesse maturare con calma, per poterle capire meglio. Lo scrittore islandese era fermo davanti alla porta di una palestra, indeciso se entrare o andarsene. mentre rifletteva sul da farsi fissava con insistenza immotivata gli stipiti della porta, e aveva notato che uno dei due era corroso. Non riusciva a distogliere gli occhi da quella cerniera usata male, gli sembrava un dente cariato (in quanto scrittore islandese aveva diritto a un serbatoio di metafore predeterminato, al quale attingeva senza ritegno), la toccò con l’unghia dell’indice della mano destra e decise di entrare, per verificare, forse, se dentro ci fosse altra roba corrosa. Lo scrittore islandese aveva trovato la caffettiera, una caffettiera giallo pecora. In Islanda il giallo pecora era il colore di elezione degli elettrodomestici, insieme al verde lichene e al rosso folletto. La cromatografia etnica islandese seguiva delle direttrici tonali sconosciute al resto del mondo, ed era praticamente impossibile fare capire a un non islandese che colore fosse il rosso folletto, tonalità che sfuggiva alla mappa neurale di molti islandesi nati nel 2000 che non avevano mai visto dei folletti su YouTube e anche ad alcuni commercialisti tedeschi in vacanza in Islanda, ritrovati esanimi acanto a un fungo rosso in plastica scambiato per un folletto. Lo scrittore islandese osservò con attenzione la caffettiera, vide il forte, abbacinante colore giallo, e la aprí con attenzione. C’era ancora della plastica che proteggeva le pareti della caffettiera e, forse suggestionato dal colore, lo scrittore islandese sentì distintamente odore di pecora. Lo scrittore islandese avrebbe voluto anche dei biscotti ma in Islanda i biscotti si trovano con una certa difficoltà, e il loro sapore è sempre lo stesso, tendenzialmente acidulo, con un retrogusto di sapone, che è forse quello che li fa sembrare aciduli, anche se l’islandese non ha esattamente una parola per scrivere acidulo (anzi, per suprema correttezza lessicografica una parola ci sarebbe, ed è sùr, ma nessuno potrebbe mai pensare di usarla, soprattutto se non riesce a pronunciare la s iniziale, il sigmatismo islandese è ancora dominante). Lo scrittore islandese sapeva però di essere uno scrittore e pensava tra sé e sé, la gente quando è da sola e pensa lo fa sempre tra sé e sé, io sono uno scrittore, posso scrivere io, per primo, acidulo, posso trarne vanto, posso scriverlo dove voglio, anche su un panetto di burro di capre, e questo dovrebbe permettermi di mangiare quei biscotti. Se lo scrivo posso mangiarlo, anche in Islanda. Una piccola euforia si impadronì dello scrittore islandese, che cominciò a scrivere acidulo ovunque, scrisse per 567 volte ACIDULO in maiuscolo su un foglio giallo che aveva usato per spedire delle calze a un amico, erano tornate indietro e lui era rimasto con queste calze blu con disegnati sopra dei piccoli pianetini e questa carta gialla da imballaggio, e allora aveva deciso di scriverci sopra ACIDULO fino a quando gli sembrava di sentire in bocca questo sapore acidulo, e aveva anche pensato che avrebbe potuto mangiare quel foglio di carta al posto dei biscotti, mai poi aveva anche pensato che la voglia di biscotti gli era passata e aveva preso una banana.
LE TRE RAGAZZE
dI Alessandro Schiapparelli
Vivo in campagna. In una vecchia casa. Scrivo e me la sono potuta permettere. Beh, non ho speso molto. È un mezzo rudere. Ma, a me, non me ne frega una cazzo. È quello che volevo: una vecchia casa di campagna. Ho il camino, e, questo, è quello che mi interessava. Che avesse il camino. Da accendere quando fuori fa freddo. Ho un divano di fronte con un bel
tappeto nel mezzo. Sto incantato ad osservare il fuoco dimenarsi, d'inverno. Con la mia birra ghiacciata in mano. E la sigaretta. Ho una specie di giardino. Davanti e intorno. Non taglio mai l'erba. Infatti sarà alta un metro e mezzo. Non sono lontano dalla città. E, ciò, è comodo perché sono senza patente. Giro in bici. Ah, dimenticavo, quando sto seduto davanti al camino,
scrivo. Il fuoco mi da ispirazione. Mi vengono in mente le idee più strampalate. Generalmente sono delle puttanate. Ah,ah... Ma, ogni tanto, mi viene anche qualcosa di buono. E, allora, lo pubblico. E mi rende a sufficienza per continuare a campare. Che bella vita. Mah, non ne sono sicuro. Comunque è così. E, a me, va bene. Non sono solo. Si, non ho né cani né gatti. Ho tre ragazze. Le pago e loro stanno con me. Praticamente non fanno un cazzo. A parte fare da mangiare a turno, fare le pulizie a turno e venire a letto con me a turno. Ah,ah... Già: è così. Non ho voglia di avere una relazione con nessuna. Ho sempre creato dei casini quando l'ho fatto. E non ne voglio più. Basta, chiuso. E, quindi, ho queste tre ragazze. Una mi stufavo. E, allora sono diventate tre. Tre è il numero giusto. Non ti stufi. E nemmeno loro. Prendo
abbastanza per potermele permettere. In più, loro, hanno la patente. E, questa, è una comodità. Si, perché la macchina, ce l'ho. Non ho solo la patente. Anche loro hanno la loro macchina e fanno quello che vogliono. A parte tenermi dietro. Io non sono capace di farlo. E posso permettermi di non farlo. Lavano e stirano anche. Beh, le cose normali da fare. Che, io, non faccio. Quando si sta bene mi metto a scrivere nel giardino. In mezzo alla distesa d'erba alta. Ci sono anche delle grandi piante che si sta bene all'ombra. Ho una specie di gazebo in mezzo. Mi faccio portare la birra fresca dalle ragazze. Da quella che è il suo turno. Le altre non fanno un cazzo quando non è il loro turno. Beh: non hanno molta voglia di lavorare, in effetti.
È per questo che vivono con me. Dimenticavo di dire che sono giovani. Hanno sui ventotto-trent'anni. Io ne ho cinquantuno. Beh: non molto più giovani. E sono belle. Molto. Per questo le ho scelte. Non mi piacciono le brutte fighe. Hanno anche un bel seno. Due una terza/quarta. Un'altra la quinta. Forse è quella che preferisco. Mi piacciono le tette. Come alla maggioranza
degli uomini. Non c'è niente di strano o anormale. Giriamo tutti in slip e, loro, in reggiseno. Quando fa caldo. Tanto, per la mia via, non passa nessuno. Si viene solo a casa mia. E non mi viene mai a trovare nessuno. E, poi, c'è l'erba alta, quindi, dalla strada, non si vede niente. A me piace così. E loro lo fanno. Mi fanno contento. Anche se non sono mai contento. Mi girano
sempre i coglioni. Non so perché. Ma è così. Mah. Bisognerebbe essere contenti di non lavorare per campare e fare quello che si vuole e stare con tre ragazze belle tutto il giorno. L'infelicità è una cosa strana. Ti prende e non ti molla più. Come la depressione. Di cui soffro da vent'anni. O forse da quando sono nato. No, credo di soffrirne da quando mio padre si è suicidato. Forse
è da quel momento. Pazienza. Ha fatto la sua scelta. Non ne aveva un'altra, probabilmente. E ci ha lasciati soli. Ad affrontare la vita. Ora ho cinquantun'anni. E sono solo. Solo le tre ragazze mi fanno compagnia. Ed è una bella compagnia. Mi lavo poco: ho dei problemi con l'acqua.
Preferisco la birra. Ah,ah... Ma il bagno nella birra diventa un po' costoso e poco pratico. Mi lavo le ascelle e mi do persino il deodorante. Mi lavo il culo quando cago e i piedi alla sera. Il resto del corpo lascia un po' a desiderare. Mah: i miei nonni, una volta, avevano le vacche e si lavavano, completamente, una volta alla settimana. Nella stalla, che c'era caldo con il fiato
delle vacche. Una volta, il bagno, lo si faceva lì. Almeno dalle mie parti. Non so qua. Ma credo fosse stata la stessa cosa. Una volta era una volta. E si faceva fatica. Non quella che faccio io a pigiare dei tasti su una tastiera. Bene. Tutto questo va bene. Adoro la mia vita. Da single. Mica le tre ragazze sono le mie
morose. Neanche per sogno. Io non voglio relazioni. Troppo complicate da gestire. E, io, sono pigro. Mi tira il culo fare qualsiasi cosa. Tipo, sabato mattina sono andato a fare la denuncia dei redditi. E mi è tirato il culo farla. Moltissimo. Per fortuna che mi sono portato una birra dietro mentre aspettavo. Sono alcolizzato. E chi dice di no. Non me ne frega un cazzo. Ognuno, nella sua vita, fa quello che vuole. A me piace bere. Birra. Da quattro gradi. Birra chiara. Semplice.
Di quella senza pretese. Le birre strane mi fanno cagare. Quelle al gusto del che cazzo ne so. O di ciliegia. Ma vaffanculo. Raramente bevo del wiskey. E lo accuso, il giorno dopo. Cazzo, se lo accuso. Ma mi piace. Wiskey buono. S'intende. Mica del cazzo. Mi tratto bene. Almeno nel bere. Non ho delle grosse pretese. Non mi interessano i beni di lusso. Anche se potrei
permettermeli. Ho già una casa in campagna. Ed è tutto quello che desideravo. Io sono un agricolo. Sono cresciuto in campagna. In mezzo alle galline, ai conigli e alle vacche. E mi piace. Poi, ho tre vacche a due zampe a casa. Quindi non chiedo di più. Le puttane sono sempre esistite. È o no il mestiere più vecchio del mondo. Uno paga ed è a posto. Fine dei giochi.
Nessuna rottura di coglioni. Nè fiori da regalare. Ah,ah... Non me ne frega proprio un cazzo di queste cose. Bene, ora il mio pezzo è finito. Non so più cosa scrivere. Alla prossima...
ROBBABUONACHECIPIACE
Non si esce vivi dagli anni Ottanta
Non si esce vivi dagli anni Ottanta #2
Melting pot con Luca (il cinese) e il Ricki (il veneto)
Daniel Johnston, che era un genio
Daniel Johnston, che sapeva spezzarci il cuore
LA POESIA (QUESTA VOLTA È UNA SPECIE DI RACCONTINO) DI ZAVATTINI CON CUI CHIUDIAMO MOLLETTE TUTTE LE VOLTE PERCHÉ SÌ
Voglio insegnare ai poveri un gioco molto bello.
Salite le scale con il passo del forestiero (quella volta rincaserete più tardi del solito) e davanti al vostro uscio suonate il campanello.
Vostra moglie correrà ad aprirvi, seguita dai figli. È un po’ seria per il ritardo, tutti hanno fame.
«Come mai?» domanda.
«Buona sera, signora», levatevi il cappello e assumete un’aria dignitosa. «C’è il signor Zavattini?».
«Su, su, il lesso è già freddo».
«Scusi, ho bisogno di parlare con il signor Zavattini».
«Cesare, andiamo, vuoi sempre giocare…».
Non muovetevi e dice: «Evidentemente si tratta di un equivoco. Scusi, signora…».
Vostra moglie si volterà di scatto, vi guarderà con gli occhi spalancati. «Perché fai così?».
Serio, state serio, e ripetete avviandovi giù per le scale: «Io cercavo il signor Zavattini».
Si farà un gran silenzio, udrete solo il rumore dei vostri passi.
Anche i bambini sono restati fermi. Vostra moglie vi raggiunge, vi abbraccia: «Cesare, Cesare…». Ha le lagrime agli occhi, i bambini forse cominceranno a piangere. Scioglietevi con delicatezza dall’abbraccio, allontanatevi mormorando: «È un equivoco, cercavo il signor Zavattini».
Rientrate in casa dopo una ventina di minuti fischiettando.
«Ho tardato tanto perché i capo ufficio…» e raccontate una bugia come nulla fosse avvenuto.
Vi piace? Un mio amico a metà giuoco si mise a piangere.
(da I poveri sono matti)
LEGGETE BENGALA!
ISCRIVETEVI A BENGALA!
Ray Banhoff scrive cose che leggerete solo da lui, nella sua esplosiva newsletter che fa luce nella notte dei giorni tutti uguali. Editoriali umorali, libri, fotografie, scazzi, slanci, musica: tutta roba buona.
Abbiamo deciso che Mollette e Bengala sono cugine, per affinità, per simpatia, perché sì.
Quindi noi, cioè Davide e Jacopo, vi invitiamo a cliccare QUI e a seguire le scintille di Bengala.