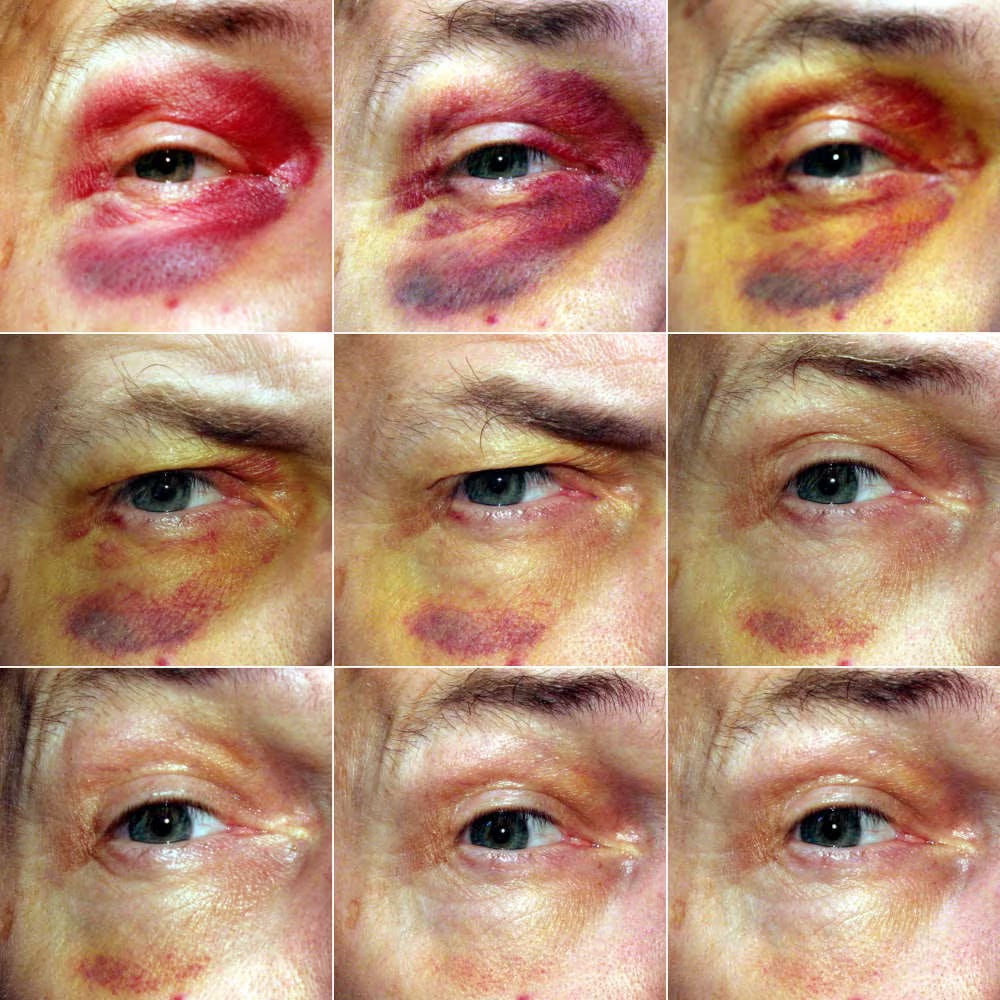MOSTRA DI MOSTRI
di Nicolò Pellizzon
Tre immagini da CULTO
E una tempera
MOSTRI
di Davide Bregola
Mentre torniamo da scuola, mia figlia di tre anni si ferma spesso lungo il tragitto che porta a casa e, passando davanti a ogni grata di ferro che si trova in terra o su un muro dice: “Qui sotto c’è il lupo!”. “Starà dormendo…” le dico. Oppure “Sta sicuramente mangiando una mela…”. Le dico cose del genere perché non voglio dirle che il lupo non esiste. L’abbiamo letto tutti Bruno Bettelheim e il suo Il mondo incantato per cui… Ma non vorrei nemmeno darle l’idea che il “lupo” sia una cosa o un essere dalle connotazioni drammatiche e di cui aver paura. Se il lupo esiste -vorrei farle intendere senza un uso massiccio di parole- probabilmente compie le nostre stesse azioni: mangiare, dormire, guardare un libro coloratissimo, fare puzzette, dire pensieri altisonanti o terra-terra eccetera eccetera. Il lupo esiste eccome, so che è lì dietro le grate, ma chissene, le vorrei fare intuire. Mi pare si sia fatta questa idea del lupo nel pertugio, dentro alle bocche di lupo, negli antri inaccessibili, al buio, nel soppalco di casa, e se l’è fatta in un momento preciso, ad Halloween, nel novembre dell’anno scorso o giù di lì. Ieri però, mentre tornavamo a casa a piedi e lei in braccio, ha iniziato a tuonare forte. In cielo c’erano lampi, nuvoloni imponenti blu e viola, e dopo avermi chiesto un gelato alla fragola mi ha detto: “Andiamo! C’è il mostro!” E’ stata la prima volta che ha detto chiaramente “Mostro”. Anche se è dai tempi di Halloween 2022 che si fa accompagnare con la manina al buio per accendere la luce. Però il mostro è uscito ieri. Tutta l’atmosfera di Halloween, spacciata per una festa e blabla, in realtà per un bimbo può essere inquietante, può fare sorgere una paura, una piccola angoscia. Infatti Halloween con tutta quella paccottiglia di robaccia inutile di plastica, quelle ragnatele di nylon, quelle zucche turpi e quel poliuretano e quelle maschere di gomma, se rappresentate in un certo modo, oltre a fare schifo, fanno paura. E’ una paura debole, indotta da cose artificiali, in cui è tolta tutta la parte importante del rito. Fosse solo questo. Ma è proprio l’estetica orrenda di Halloween che mi infastidisce Ecco, proprio ieri, in primavera conclamata, ha parlato proprio di “mostri” e così le ho chiesto cosa fossero i mostri. Ha fatto una smorfia come quando si prova a fare la “faccia brutta” e ha detto che i mostri sono “Schhhhhh” emettendo un suono palatale dalla bocca e allungando il braccio con la manina artigliata. “E dove sono i mostri?” “Sono sotto le foglie secche e i rami e quando passi fanno Buuuuu!” ha risposto, giustamente. “Si ma fammi un esempio” ho insistito, perché facevo finta di non capire e lei mi fa: “Sono come i draghi…saltano fuori e buuuu”. Siamo entrati in un bar per ripararci dalla pioggia e abbiamo finalmente preso il benedetto gelatino alla fragola. Questo per dire i mostri. Tante volte noi adulti l’abbiamo fatto diventare un modo di dire: “Quello è un mostro”, “Hai visto che mostro?” e gli diamo connotazioni di ordine morale o fisico. E’ un sostantivo a cui diamo spesso un senso figurato, però fin dalla notte dei tempi l’abbiamo raffigurato via via come un prodigio, un mirabilia, un fenomeno da baraccone, ma nella modernità è diventato anche un “mostro di bravura”, “mostro sacro” e così via. Coi mostri ci si fanno i soldi no? Vabbé, non è questo il ragionamento che voglio fare sul “mostro”, bensì vorrei provare a capire cosa c’è, in nuce, nella nostra testa, nella testa di un bambino di tre anni, e penso che bisognerebbe partire dalle emozioni per provare a capire da dove nasce la nostra idea di mostri (scusate che prima ho scritto “in nuce” eh, ma non mi veniva altro). Mia figlia dice che il mostro è “Schhhhhh”, e si nasconde tra i rami e sotto le foglie, ma quando meno te lo aspetti fa “Buuuuu” e sono come i “draghi” che saltano fuori all’improvviso. Stando a questo è come se i mostri fossero la raffigurazione delle paure umane. Come vi diranno a pagina due di un qualsiasi manuale di Psicologia, le emozioni primarie sono sei per alcuni, otto per altri, una miriade per altri ancora. Mi attengo ai classici e l’elenco è presto detto: gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto e sorpresa. Poi ci sono le emozioni secondarie e fanno capo a variazioni e sfumature delle primarie. Sono conseguenze. A me piace il sociologo Kemper che dopo lunghi studi e ricerche disse che le emozioni primarie sono quattro: Rabbia, Paura, Dolore, Piacere. Fine. Secondo la psicologia moderna, quindi, la paura è qualcosa di primigenio, magari uso un termine inappropriato ma direi “innato”, se si considera che dentro di noi abbiamo già un codice, una app preinstallata con dentro le emozioni. I mostri nascono dalla notte dei tempi, nell’immaginario di ognuno di noi e collettivamente perché abbiamo paura. Il ragionamento sembra questo. I mostri quindi, in definitiva, sono le nostre paure. Non lo so se è vero, ma in effetti il nostro secolo pieno di paure sta procedendo a ritmo serrato e produrre mostri di ogni genere. Mostri di bravura nello sport e nella comunicazione, mostri di bellezza con i vari canoni proposti dall’estetica, mostri finanziari, di guerre, mostri rappresentati nelle arti… I mostri alimentano le paure, a loro volta le paure alimentano la nostra capacità a produrre mostri e ne siamo così pervasi da non vedere più la loro chiara dimensione mostruosa. Anche se abbiamo paura. Una paura fottuta. Per cosa? Questo si vedrà. Cosa sono quei virus e batteri che i media ci fanno vedere al microscopio su schermi piatti ad alta definizione? Sono mostri che traduciamo immediatamente e inconsapevolmente in paure di ogni tipo. Sono reali? Spesso no, come quel lupo nelle grate di ferro e nei pertugi. E io? Io sono sicuro di quel che ho detto? Manco per niente. Però al posto del gelato alla fragola ne ho preso uno al cioccolato e pistacchio. Poi ha smesso di piovere e siamo corsi a casa a vedere Bing il coniglietto nero in salopette rossa che in una puntata parla con la sua ombra assieme a Flop, un essere informe di stoffa imbottita e zak!
L’UNIVERSO CINEMATICO DEI MOSTRI UNIVERSAL:
I MOSTRI BELLI
di Jacopo Masini
(nelle vesti del divulgatore di storia del cinema)
Anni fa, per lavoro, ho scritto una serie di articoli sulla storia dell’horror, a partire da quello letterario - il romanzo gotico - per arrivare a quello cinematografico. Cioè a quello che ha preso il sopravvento nello scorso secolo e ha in un certo senso canonizzato il genere.
Lungo quel viaggio, a un certo punto mi soffermavo su uno dei grandi snodi del cinema che fa godere (il cinema che fa godere è un grande contenitore che conosciamo tutti, senza che vada definito meglio): lo Universal Monsters Cinematic Universe, cioè l’universo cinematografico condiviso che raccoglie alcuni dei mostri più iconici della cultura e della narrazione occidentale.
Partiamo per il viaggio. Il primo vero mostro a entrare nell’universo cinematografico della Universal è considerato Il Fantasma dell’Opera, personaggio creato dallo scrittore francese Gaston Leroux e portato sullo schermo nel 1925, per la regia di Rupert Julian e, non accreditati, di Lon Chaney, Edward Sedgwick e Ernest Laemmle. La storia è apparentemente semplice: un geniale musicista di nome Erik, che ha la sciagura di essere sfigurato, di essere un mostro e che vive nascosto nei sotterranei dell’Opera di Parigi, teatro che conosce in ogni suo anfratto e all’interno del quale si muove senza che nessuno si accorga di lui. Il suo unico scopo nella vita è quello di portare al successo la giovane cantante Christine, della quale è segretamente innamorato e dalla quale non osa farsi vedere.
Il film, che fa leva sugli elementi melodrammatici della situazione iniziale e del rapporto impossibile tra Erik e Christine, ha suscitato all’epoca uno straordinario effetto sugli spettatori, letteralmente terrorizzati dall’ambientazione cupa, dalle ragnatele, dalla luce dei candelabri che disegnano sul volto del mostro espressioni da incubo. Il film non suscita la stessa reazione negli spettatori attuali, ma è ancora strabiliante la forza di un personaggio in cui la malvagità e la rabbia si mescolano a sentimenti puri e romantici, resi immortali dall’interpretazione di Lon Cheney, considerata la migliore della sua carriera. La versione muta del 1925 è andata perduta, mentre sopravvive quella sonora del 1929, presentata per la prima volta a New York nel 1930.
E così, con quella seconda edizione di Il fantasma dell’Opera, viene inaugurato un nuovo decennio: gli anni ‘30. Un decennio che inizia con la vera e propria fondazione del mostruoso universo cinematografico della Universal. In soli tre anni vengono prodotti quattro capolavori, quattro pietre miliari del cinema in generale e del cinema horror in particolare. Quattro film che attingono al patrimonio della letteratura di genere ottocentesca, per accompagnare il cinema sonoro nel nuovo secolo. Non va dimenticato, infatti, che il primo film sonoro è stato proiettato nel 1926 a New York – si trattava di Don Giovanni e Lucrezia Borgia – e che in Italia abbiamo dovuto attendere fino al 1930 per sentire gli attori parlare sullo schermo.
I quattro film che hanno fondato il cinema che fa godere di cui sto parlano sono Dracula e Frankenstein, entrambi del 1931, La mummia del 1932 e L'uomo invisibile del 1933. Alcuni attori hanno costruito la loro gloriosa carriera proprio a partire dalle loro interpretazioni in alcuni di questi film, in particolare due leggende come Bela Lugosi e Boris Karloff.
Proprio Bela Lugosi è l’interprete del Conte vampiro protagonista di Dracula, capolavoro diretto da Tod Browning e da Karl Freund. Il film è un adattamento dell'omonimo spettacolo teatrale di Broadway del 1927, ed è tuttora tra le più note trasposizioni cinematografiche dell'omonimo romanzo di Bram Stoker. Il film racconta la storia di Renfield, un agente immobiliare mandato in Transilvania per definire e concludere l'acquisto dell'abbazia di Carfax da parte di un certo Conte Dracula, che prima lo soggioga coi suoi poteri, poi lo porta con sé a Londra come schiavo fino a renderlo folle. Il successivo tentativo del Conte di sedurre Mina, viene ostacolato e compromesso dal professor Van Helsing, che infine uccide Dracula con un paletto nel cuore.
Dracula ha avuto all’epoca un grande successo, così come lo avrà subito dopo Frankenstein, a sua volta uscito nel 1931 e diretto da James Whale. La storia, più che sul romanzo di Mary Shelley, prende spunto dall’'adattamento teatrale del 1823 di Richard Brinsley Peake, intitolato Presumption; or, the Fate of Frankenstein. Proprio considerando il successo di Dracula, la produzione avrebbe voluto che fosse Bela Lugosi a interpretare il ruolo del mostro creato dal dottor Frankenstein, ma l’attore ungherese ha rifiutato con queste parole: ‘Nel mio paese ero una stella, e non sarò certo uno spaventapasseri qui’. Così la scelta è caduta su William Henry Pratt, molto più noto col suo nome d’arte: Boris Karloff.
Il film, dal taglio evidentemente espressionista, è considerato ancora oggi la miglior trasposizione e interpretazione del mostro creato da Mary Shelley, anche grazie alla capacità di turbare il pubblico, nonostante gli anni trascorsi. La preoccupazione che gli spettatori di allora potessero essere troppo spaventati dalla visione della pellicola, ha spinto all’epoca i produttori a inserire un prologo recitato da Edward Van Sloan, che nel film interpreta il Dr. Waldman. Ecco il testo:
‘Buonasera. Il signor Carl Laemmle ritiene che non sia opportuno presentare questo film senza due parole di avvertimento: stiamo per raccontarvi la storia di Frankenstein, un eminente scienziato che cercò di creare un uomo a sua immagine e somiglianza, senza temere il giudizio divino. È una delle storie più strane che siano mai state narrate e tratta dei due grandi misteri della creazione: la vita e la morte. Penso che vi emozionerà, forse vi colpirà, potrebbe anche inorridirvi! Se pensate che non sia il caso di sottoporre i vostri nervi a una simile tensione , allora sarà meglio che voi... be', vi abbiamo avvertito!’.
Come detto, Frankenstein ha ottenuto un successo straordinario, persino superiore a Dracula. Un successo che ha convinto la Universal a proseguire nel proprio progetto, creando un vero e proprio universo.
I due ‘mostri’ successivi su cui ha puntato la Universal nel 1932 e nel 1933 hanno avuto a loro volta – e continuano ad avere – un enorme successo, anche se probabilmente non quanto i due predecessori. Stiamo parlando di La mummia e di L’uomo invisibile.
La mummia è uscito nelle sale, appunto, nel 1932, sull’onda del successo di Frankenstein e Dracula. Al direttore della fotografia di quest’ultimo, cioè a Karl Freund, è stata affidata la regia del nuovo film due giorni prima dell’inizio della riprese e dopo che la storia era stata definitivamente ambientata nell’Antico Egitto. Inizialmente, infatti, il soggetto aveva per protagonista Cagliostro, ma lo sceneggiatore John L. Balderston – già al lavoro sulle prime due pellicole dell’universo horror targato Universal – aveva provveduto a spostare tutta la vicenda in un altro contesto e a individuare un protagonista ancora più spaventoso: Imhotep, personaggio ispirato all’architetto, medico e astronomo egizio vissuto nel corso della III dinastia, cioè nel terzo millennio avanti Cristo.
La storia è ambientata nel 1921. A Tebe, tre archeologi che fanno parte di una spedizione del British Museum scoprono un sarcofago contenente la mummia di un sacerdote che si chiama proprio Imhotep. Uno dei tre uomini trova un papiro vicino alla bara, ne legge alcuni passi e, senza volerlo, riporta in vita il sacerdote, che si impossessa del manoscritto e fugge.
È una premessa che non promette nulla di buono, ovviamente, ma ci avevano già pensato la voce off sui titoli di testa e la didascalia che apre il film a chiarirlo. Voce e testo, infatti, dichiarano quanto segue:
“Antiche leggende e superstizioni popolari dell'Egitto vogliono che i profanatori delle sacre tombe irritino pericolosamente gli dei e che le maledizioni di questi perseguitino i colpevoli per generazioni. Questa credenza, come le altre forze occulte nella reincarnazione, non ha mai trovato alcuna conferma nella realtà. Tuttavia ha suggerito a romanzieri e scrittori opere d'arte di cui questo film, La mummia, è uno degli esempi più caratteristici, come il romanzo al quale si ispira.
Questo è il Papiro di Thoth. Qui sono scritte le parole magiche con cui Iside ha riportato Osiride in vita.
Oh! Amon-Ra / Oh! Dio di tutti i dei / La morte non è che la porta per una nuova vita / Viviamo oggi / Vivremo ancora / In molte forme ritorneremo / Oh, potente!”
Undici anni dopo essere risorta ed essere fuggita, la mummia prende le sembianze di Ardath Bey e ha un unico scopo: riportare in vita Anck-Su-Namun, la donna che amava. Per questo, indica ad alcuni archeologi dove si troverebbe la sua tomba. Mentre Ardath si trova al Cairo, però, crede di riconoscere la sua amata reincarnata nella fidanzata di uno degli archeologi, una donna che si chiama Helen Grosvenor. A quel punto la cattura e organizza un rito che dovrebbe darle la vita eterna, ma la donna invoca la dea Iside, la quale interviene miracolosamente a fermare Imhotep, uccidendolo.
Forse per dare maggior credibilità al film, Freund ha affidato la parte di Helen Grosvenor a Zita Johann, un’attrice che si diceva credesse nella reincarazione. Per il ruolo di Imhotep, invece, è stato scelto di nuovo Boris Karloff, che si era guadagnato una enorme notorietà grazie a Frankenstein. Un altro mostro lo attendeva e un’altra volta si era sottoposto a estenuanti sessioni di trucco, che, nel caso della Mummia, duravano circa otto ore. Il film non ha avuto veri e propri sequel, ma alcuni remake, sino ad alcuni recentissimi, come, ad esempio, quello molto fortunato del 1999.
Nel 1933 ecco il quarto titolo. Si trattava di L’uomo invisibile, tratto dal fortunatissimo romanzo di uno degli scrittori fantastici più importanti di sempre: Herbert George Wells.
Diretto da James Whale, interpretato da Claude Rains e Gloria Stuart – attrice che, a distanza di tanti anni, diventerà molto popolare grazie a Titanic –, racconta la storia di Jack Griffin, un chimico che, mentre sta conducendo una serie di esperimenti di laboratorio, scopre una sostanza che è in grado di rendere invisibile chiunque la ingerisca: la monocaina. Inizia a farne uso, a esserne inebriato, a sperimentare il senso di onnipotenza dovuto alla propria invisibilità. A quel punto, Flora, sua fidanzata e figlia di uno suo collega, cioè il dottor Cranley, inizia a preoccuparsi delle sue frequenti assenze e ne parla col ladro. Il dottor Cranley e i suo assistente Kemp fanno alcune indagini e finalmente arrivano a scoprire la verità. A quel punto, sulla falsariga di ciò che accade in un altro grande classico come Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson, la parte malvagia di Jack Griffin sembra avere il sopravvento. Flora e suo padre cercheranno di salvarlo, prima del tragico finale.
La fortuna ha arriso anche a L’uomo invisibile, tanto che, a partire dagli anni ‘40, il personaggio torna a essere protagonista di sequel e film ispirati alla pellicola originale. Ma l’avventura dello Universal Monsters Cinematic Universe non era ancora conclusa. Mancavano ancora alcuni tasselli fondamentali. In particolare due film che hanno segnato una ulteriore svolta per il cinema horror e, dunque, più in generale, per gli sviluppi di tutto lo strorytelling horror del Novecento.
Con questi due titoli si definisce compiutamente il profilo delle fondamenta horror hollywoodiane, rappresentate appunto dalle creature messe in scena tra gli anni ‘30 e gli anni ‘50 dalla leggendaria casa di produzione statunitense. Si tratta di due film che, usando un termine abusato, si possono definire ‘seminali’, proprio perché, nel caso specifico, hanno gettato semi germogliati a lungo, nel corso del tempo, e anche molto di recente.
Si tratta di Werewolf of London, uscito in italiano col titolo Il segreto del Tibet, e di Creature from the Black Lagoon, cioè di Il mostro della Laguna Nera. Il primo è uscito nel 1935, il secondo nel 1954. Perché li separa un arco temporale tanto vasto, che comprende anche l’inizio e la fine della Seconda Guerra Mondiale? Ne parleremo più avanti. Per il momento, soffermiamoci sulla prima pellicola dedicata dalla Universal a uno degli archetipi del genere horror, cioè il licantropo.
Per provare a capire le ragioni del successo di L’uomo del Tibet e, più in generale della figura dell’uomo-lupo, mi affido a Stephen King, che ne parla diffusamente in Danse Macabre. Per farlo, parte da uno dei più celebri racconti di Robert Louis Stevenson e di tutta la narrativa occidentale: Lo strano caso del dottor Jeckyll e del signor Hyde.
Ecco cosa dice King:
“Stevenson descrive Hyde come uno scimmione, alludendo al fatto che Hyde, come Michael Landon in ‘I was a Teenage Werewolf’, è un gradino indietro nella scala evolutiva, un che di brutale nella costituzione dell’uomo che non è stato ancora soggiogato... E non è proprio questo che ci terrorizza nel mito del Licantropo? È il male che abbiamo dentro per antonomasia, e non c’è da stupirsi se gli uomini di chiesa dell’epoca di Stevenson accolsero con entusiasmo la sua storia. A quanto pare sapevano riconoscere una parabola quando ne leggevano una, e da Hyde che infierisce brutalmente a colpi di bastone su Sir Danvers Carew videro schizzar fuori l’immagine prepotente del vecchio Adamo. Stevenson suggerisce che la faccia del Licantropo è la nostra, e lo fa in un modo che ha un poco dell’umorismo della famosa controbattuta che Lou Costello indirizza a Lon Chaney Jr. in Il cervello di Frankenstein. Chaney, nel ruolo del perseguitato mutante Larry Talbot, biascica a Costello: «Non vuoi capire. Al sorgere della luna, mi trasformerò in lupo». Costello ribatte: «Come no... E insieme a te faranno più o meno lo stesso altri cinque milioni di persone»”.
Il licantropo è il riflesso animale, brutale e ferino della nostra – vera o presunta – umanità. È il feroce mostro che, rispondendo a un semplice e preciso impulso si fa strada tra convenzioni, buone maniera, norme e leggi per scatenare i propri impulsi. I peggiori.
Il segreto del Tibet è il primo film della Universal dedicato all’Uomo Lupo. Anche in questo caso, i produttori avevano pensato di affidare il ruolo di protagonista alla star del momento, cioè a Bela Lugosi, che avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Glendon o, in alternativa, quello di Yogami.
Il film, infatti, racconta la storia di Wilfred Glendon, un botanico inglese, diretto in Tibet per organizzare una spedizione che ha l’obiettivo di trovare una pianta rarissima – la mariphasa lupina lumina –, il cui fiore cresce solo nelle notti di luna piena.
Rintraccia il fiore in una valle desolata, ma durante le ricerche Glendon viene assalito e morso da un essere misterioso dalle sembianze animalesche. Ritornato a Londra, il botanico trascura gli amici e la moglie Lisa, e si concentra su un unico obiettivo: quello di far fiorire la pianta utilizzando la luce artificiale. Viene contattato dal dottor Yogami, che lo prega di fornirgli la rara pianta: è l’unica in grado di curare chi è affetto da licantropia. Glendon non gli dà retta e ha inizio la sua metamorfosi: durante il plenilunio si trasforma in un licantropo che uccide ogni notte una nuova vittima. Yogami, a questo punto, gli ruba i fiori della pianta per servirsene come cura. Quando Glendon scopre il furto uccide il ladro e, perso ogni controllo, aggredisce la moglie Lisa, fino a che viene ucciso a sua volta dalla polizia.
L’uomo del Tibet non è stato il primo film dedicato alla figura del licantropo, né il migliore e neanche il più fortunato. Conteneva, però, un’ottima intuizione: quella di spogliare la figura dell’uomo lupo da tutti gli orpelli folcloristici che l’avevano contraddistinta sino a quel momento, per sterzare in direzione della fantamedicina. Cioè, nella direzione indicata da Stevenson nel suo celebre racconto, così come descritto da King nel pezzo che abbiamo citato prima. Il licantropo diventa vittima di una mutazione che può essere curata con l’uso di una pianta medicamentosa. In altre parole, il licantropo diventa un soggetto malato, sia dal punto di vista psichico che da quello fisico. L’orrore soprannaturale rientra nel recinto della quotidianità e diventa ancora più spaventoso.
Un fiasco, dunque? Affatto, perché è stato fonte d’ispirazione per il famosissimo film del 1941, intitolato molto semplicemente The Wolf Man, cioè L’uomo lupo. Diretto da George Waggner, è stato scritto dallo sceneggiatore ebreo Curt Siodmak – fuggito dalla Germania nazista a Hollywood – che ha disseminato la storia di riferimenti alla religione ebraica (la stella a cinque punte che compare sulla mano delle vittime del licantropo). Il film è diventato così una delle pietre miliari del cinema horror. Grazie allo straordinario trucco ideato da Jack Pierce e dalle musiche tritonali (nel medioevo il tritono era legato alla figura di Satana), è stato più volte ripreso e citato, per esempio da John Landis in Un lupo mannaro americano a Londra.
Come detto, il sesto mostro ‘canonizzato’ dalla Universal è quello che dà il titolo all’omonimo film, cioè Il mostro della Laguna Nera, diretto nel 1954 da Jack Arnold. Uscito in 3D, si è importo come uno dei film di maggior successo degli anni ‘50 e come uno dei grandi classici della storia del cinema. Come accennavamo all’inizio, però, è curioso che sia intercorso così tanto tempo dalle prime pellicole dell’universo cinematografico horror della Universal a quest’ultima. E la ragione, in fondo, è abbastanza semplice: per tutti gli anni ‘40 e i primi anni ‘50 sono usciti i numerosi sequel dei primi cinque film, che sono stati a modo loro serializzati, per dare in pasto agli spettatori nuove avventure dei loro beniamini mostruosi. Oltre venti film in tutto, che hanno generato una vera e propria galassia narrativa e che, in un certo senso, hanno preparato il terreno per un ennesimo successo, quello di Jack Arnold.
I primi germi dell’idea sono nati molto tempo prima della produzione, però. Precisamente nel 1941, grazie al produttore William Alland, che, nel corso di una cena, ha conosciuto il direttore della fotografia messicano Gabriel Figueroa, il quale gli ha raccontato di una leggenda secondo cui in alcune acque dell'Amazzonia esisterebbero mitologici esseri dalle fattezze umanoidi ma con il corpo di pesci. Nel caso ve lo stiate domandando, sì, si tratta della stessa identica creatura che ha ispirato Guillermo Del Toro per la realizzazione di La forma dell’acqua.
Nel 1951, ben dieci anni dopo, Alland conclude una prima versione della sceneggiatura, intitolata The Sea Monster e basata in parte su quel racconto e in parte su alcuni spunti presi da La bella e la bestia. L'anno successivo alcuni sceneggiatori esperti ci rimisero le mani e ne nacque il copione definitivo.
Il plot del film è abbastanza semplice. FilmTv, ad esempio, lo riassume così:
“Una spedizione di biologi americani in Amazzonia si convince dell'esistenza di una specie di uomo-pesce. Seguendo le tracce di una "misteriosa" creatura, i due scienziati del team individuano e catturano un umanoide ricoperto di branchie, praticamente anfibio. Ma il "mostro riesce a fuggire.
Nonostante l'opposizione del finanziatore della spedizione che vede nella sua cattura una possibilità di arricchimento, i componenti la spedizione decidono che la soluzione migliore è quella di fuggire. Ma l'unica uscita dalla laguna è stata bloccata da alcuni tronchi messi dal mostro. Mentre l'equipaggio tenta di rimuovere l'ostacolo, la creatura fa ritorno e rapisce Kay”.
Qual era dunque il punto di forza del film? Perché emana ancora tanto fascino? Uno degli elementi più importanti è senz’altro il rapporto tra il mostro e la ragazza che rapisce nel corso del film. Ancora una volta, cioè, il lato ‘umano’ di una creatura. Una creatura stavolta integralmente mostruosa, anfibia, in cui si mescolano l’essere umano e un’altra razza, cioè un ibrido che rappresenta un vero e proprio incubo (come accadrà, ad esempio, anche in La mosca e, in particolare, nel celebre remake di David Cronenberg). Ma a incidere moltissimo sul successo del film sono state anche alcune scene memorabili, a partire proprio dal rapimento della ragazza e dal nuoto in parallelo con la mostruosa creatura.
Anche questa pellicola ha avuto due sequel e per molti anni si è parlato di un possibile remake, mai realizzato. A patto di non considerare come tale proprio La forma dell’acqua. Che, sotto molti aspetti, è una sorta di remake e uno straordinario sequel.
GYPSY ROSE, COSTRETTA DALLA MADRE A FINGERSI DISABILE
di Roberto Vitale
tratto da Le foto che hanno segnato un’epoca, Becco Giallo
14 giugno 2015, Springfield, Missouri, Stati Uniti.
“That Bitch is dead!”
I vicini di casa di Dee Dee Blanchard segnalano alla polizia questo inquietante post comparso sulla pagina Facebook della figlia della donna. Quando gli agenti entrano nella casa di Dee Dee Blanchard trovano il suo cadavere, ma nessuna traccia della figlia Gypsy Rose. La cosa è sorprendente visto che la ragazza è costretta su una sedia a rotelle perché affetta da distrofia muscolare, oltre che da una leucemia e da un grave ritardo mentale dovuto alla sua nascita prematura.
In un primo momento la polizia pensa a un rapimento, perché i farmaci di Gypsy Rose e la sua sedia a rotelle si trovano all’interno dell’abitazione, tuttavia il giorno dopo gli inquirenti, risalendo all’ip del post su Facebook, rintracciano la ragazza nel Wisconsin, in compagnia del fidanzato Nicholas Godejohn, conosciuto online.
Interrogata per ore, Gypsy Rose decide di raccontare tutta la sua storia. Le sue malattie erano un’invenzione della madre, che faceva di tutto perché la gente credesse a quella finzione. Le radeva la testa per far sembrare che fosse perennemente in chemioterapia o la sottoponeva a continui interventi chirurgici non necessari, come l’espianto delle papille gustative. Quando erano in pubblico la ragazza doveva respirare tramite una bombola d’ossigeno che aveva sempre con sé. Se diceva qualcosa che poteva svelare l’inganno, la madre le stringeva con violenza la mano e una volta a casa la picchiava. Fino a vent’anni la ragazza venne alimentata tramite un sondino e costretta a prendere abbondanti medicine ogni giorno senza alcun motivo. Inoltre la madre sosteneva che il certificato di nascita di sua figlia fosse andato distrutto a causa dell’uragano Katrina e le attribuiva un’età inferiore a quella reale.
La tragica situazione di Gypsy Rose veniva sfruttata dalla madre per accumulare denaro da donazioni private e pubbliche, per ottenere visite mediche gratuite, biglietti per viaggi e concerti, e addirittura una casa con una rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Nel 2011 Gypsy Rose conobbe online un ragazzo, ma sua madre la scoprì e distrusse a martellate il computer, minacciando di fare lo stesso con le dita della ragazza. Per due intere settimane la ragazza fu tenuta al guinzaglio e ammanettata al letto.
Nei mesi successivi Gypsy Rose riprese a usare internet di nascosto e un anno dopo iniziò a chattare con Nicholas Godejohn, un ragazzo di Big Bend, in Wisconsin, che aveva un precedente per esibizionismo e problemi psichiatrici. La loro relazione a distanza sfociò in un incontro in un cinema. Dopo quell’occasione, i due continuarono a chattare iniziando a sviluppare il loro piano per uccidere Dee Dee.
Il 14 giugno del 2015 Godejohn si apposta all’interno di casa Blanchard aspettando il ritorno della donna e della figlia dall’ennesima visita medica. Nicholas attende che Dee Dee vada a dormire e poi la pugnala varie volte con un coltello. I due ragazzi poi fanno sesso, rubano tutti i soldi che trovano e scappano verso il Wisconsin. Durante il viaggio alcune telecamere riprendono la ragazza con una parrucca che cammina autonomamente. Una volta arrivati a casa di Godejohn, i due decidono di scrivere un post sull’account Facebook che la ragazza ha insieme alla madre per fare in modo che il corpo venga trovato e ne sia data sepoltura. Il post permette alla polizia di rintracciarli e arrestarli. Gypsy Rose viene condannata a dieci anni di carcere, una pena ridotta visti i tanti anni di abusi subiti. Nicholas invece viene condannato all’ergastolo.
disegno di Roby il Pettirosso
MOSTRI
di Carlo Moretti
IL MOSTRO
di Alessandro Schiapparelli
La paura di essere gay. Ecco il mio mostro. Che attanaglia la mia mente. Io non lo so, ma mi attraggono terribilmente le donne. Le belle donne. Ma sono di bocca buona. Mi piacciono quasi tutte. Quando, poi, vedo un seno prosperoso, molto prosperoso, non capisco letteralmente più niente. Eppure faccio sempre fantasie a sfondo omosessuale. Tempo fa mi sono comprato tutto l'occorrente per agghindarmi da donna.
Avevo anche fatto la ceretta alle gambe. Si, perché avevo comprato un tubino nero che le lasciava scoperte. E non sarebbe stato bello metterselo con i peli nelle gambe. Beh, dopo averlo fatto tante volte tra le quattro mura di casa mia, una sera ho trovato il coraggio di uscire in pubblico. In una birreria di un paese vicino. Fortuna che non c'era quasi nessuno. Ero ubriaco fradicio. Non ci sarei mai riuscito senza esserlo. Sono entrato e ho salutato il proprietario. Lui mi ha risposto con un: "Oh!". E io: " Lascia perdere". E mi sono seduto sullo sgabello di fronte al bancone. Mi sono fatto fare l'ennesima birra e, intanto, osservavo le mie gambe. Che finivano in un paio di sandali neri col tacco. Mi sentivo proprio bene. In quelle vesti. Questo, cosa significa. Che sono gay per davvero? Non so, non ci capisco un cazzo. Non capisco niente, della mia vita. Continuo ad osservare le tette e non ho quasi mai provato attrazione per un uomo. Tranne per un ragazzo parigino in metrò per il capodanno del 2000. Era veramente bellissimo. Un fascino particolare. Che hanno i ragazzi francesi. Ma devo fare chiarezza dentro di me. Non posso continuare a nascondere tutte queste paure sotto il tappeto. Per questo, sabato, voglio andare in un locale gay di Bologna. Ho il dovere di andarci. È un posticino tranquillo. Molto ruspante. Agricolo, oserei dire. Non mi interessano le discoteche. Gay, intendo. Non me ne frega un cazzo. Non sono mai stato uno a cui piacesse la discoteca. Tranne quelle con musica rock. Si, adoro il rock. E basta. Nessun' altra musica. All'incirca. Poi, ascolto tanta roba. Ma non la commerciale da discoteca. Appunto. La detesto. Secondo me è da mongoloidi ignoranti. Per esempio, adesso, sto ascoltando i Jesus and Mary Chain. Per chi li conosce. Pochissimi, credo. Ma non mi interessa. Piacciono, molto, a me. E, questo, è sufficiente. Comunque, per gli abitanti del paese in cui vivevo, sono gay. Per i frequentatori dei bar dove passo il tempo, anche. Forse non lo sono solo per me. Possibile che lo sappiano tutti tranne me? Questa cosa mi ossessiona. Va bè che, nel paese dove abitavo, i giovani, sono tutti dei fascisti bifolchi di merda. Ignorantoni. Una brutta specie, insomma. Comunque non vedo l'ora di ripetere l'esperienza di vestirmi da donna. Ma non ho più la patente. E non posso cambiarmi, come ho fatto quella volta, in un tranquillo posto di campagna. Dovrei uscire direttamente da casa così. E non posso. Va bene sputtanarsi ma, a tutto c'è un limite. C'è anche da cautelarsi un po'. Non voglio mica fare la fine di quella povera ragazza di giù. Si è suicidata. Ne ho già abbastanza del suicidio di mio padre, nella mia famiglia. C'ho pensato tante volte al suicidio. Ma sono troppo codardo. Un mio grande amico m'ha detto che, la notte che ci penso, di chiamarlo che viene con una bottiglia di Lambrusco da bere assieme. E, adesso, devo smettere di bere. Che cazzata. Eppure, è così. Mi diventerà, la vita, impossibile. E ricomincerò a riprendere antidepressivi. Probabilmente. Ah, affanculo. Sono amico di una puttana cinese su Facebook. Una figa incredibile. Prima o poi li troverò 100 euro da spenderci. Per il momento, no. Non ce li ho. Come al solito ho scritto di tutto e di niente. Sono un inconcludente. Infatti non ho concluso un cazzo nella vita. So solo che ho da pagare l'appartamento in cui vivo fino a 77 anni. Cioè, molto dopo che sono morto. Ma ho l'assicurazione sulla vita. Quindi, lo erediterà mio fratello. Bene: qualcosa di buono, nella mia vita, l'avrò fatto. Comunque, sto pezzo, è venuto una merda. Non so, voi che leggete, cosa ne pensate. Sarei curioso di saperlo. Ma non ne ho il modo. Io scrivo perché, per me, è libertà. Forse è l'unico ambito in cui sono libero. Per il resto, la vita è una merda. Adieu...schiappa71@gmail.com per chi volesse gradire!
VOLGOLO
di Elisa Baldini
Era un giorno come gli altri senza niente da fare. La primavera era appena avviata, e di quei fiorellini viola senza nome erano pieni i campi. Giordano s’era svegliato come sempre all’alba e aveva preso la via del fiume. Rischiando il femore come faceva ogni mattina, era sceso sul greto limaccioso ma solido, con steli d’erba grassi come foglie di ninfee fatte a spaghetto. Di girini non ce n’era uno. Era ancora troppo freddo per riprodursi. Le rane erano tutte a letto, come Celestino, il suo vicino di casa. Quando lo vedeva ritornare dal fiume con il sacchettino biodegradabile del Penny che gli penzolava dalla tasca, spesso vuoto, qualche volta mezzo pieno, Celestino, da poco sveglio, gli diceva sempre: “Che tu ci andrai a fare al Settola tutti i giorni! Vai a finire che tu ci ribalti dentro, e chi s’è visto s’è visto. Ti ritrovano insieme a quelle trote sudicie tutto maciullato.” “Grazie, Celestino, te tu dormi fino alle dieci tutte le mattine. Io mi sveglio presto, e vado a cercare rapacelli.” Questa cosa di raccogliere i rapacelli gliela aveva messa in testa il suo povero babbo, che ci si finiva la schiena a depredare i cigli, perché, diceva, i rapacelli “fanno bono.” A cosa, non si è mai capito. A Giordano piaceva salutare tutte le bestie che incontrava. Non lo avrebbe mai detto a nessuno, ma anche i topi gli stavano simpatici. Del resto son bestie anche loro. E di girini, quando era il tempo di girini, ce n’erano tanti, quindi a stare a guardare i loro movimenti di spermatozoi cechi ci stava anche di tirar tardi fino alle 09.15, e portare un po’ avanti la mattinata in direzione della pastina all’olio delle 12.00. “Com’è bona la pastina all’olio” pensava Giordano, “mi ci andrebbe già ora, anche se son le sei….Orca troia!” Giordano stava davvero per ribaltare. Guardò in basso e vide ai suoi piedi un ammasso confuso di rametti, terra, pezzetti di plastica scoloriti al sole, brandelli di tessuto, frammenti di ferraglia informe, tutto compattato insieme da una pasta di sudicio nero. “Bada che volgolo di roba. Ha ragione Celestino. Raccatta un bel sudicio questo fiume.” Pensò Giordano. Il volgolo era muto e fermo, ma a guardarlo bene acquistava una fisionomia. Quel tappino di Acqua Ferrarelle rosso era un occhio, quel pezzo di vetro verdognolo era l’altro occhio. Il filo di rame che svettata sul nero sudicio rilucendo nel sole tenero delle sei e trenta era un sorriso increspato dall’imbarazzo. Ora sì, ne era certo: quel volgolo aveva un’espressione. L’occhio Ferrarelle e quello di vetro lo stavano guardando, supplicanti. Giordano sentì la spina sottile dell’empatia su un fianco.
“Hai trovato qualcosa di bono, Giordano?” “Du rapacelli, ma proprio due.” “Insomma, t’hai la borsina piena!” Puntualizzò la Liliana, che sembrava sempre distratta dalle faccende, ma ci vedeva ancora come una lince. “Se me ne avanzano te ne porto un po’, dopo. Ah no, li ho promessi a Celestino.” “Bono quello, sarà ancora a letto! Quel pelandrone.”
Da quando aveva portato Volgolo a casa, Giordano metteva 200 grammi di stelline a cuocere, invece di 100, a mezzogiorno. All’inizio gli era sembrata un’idea scema, ma poi, si disse, era a casa sua e non doveva rendere conto a nessuno. Volgolo, in qualche oscura maniera che Giordano non osava indagare, aveva apprezzato. La prima volta gli aveva lasciato il piatto vicino al cassetto aperto del comò dove riposava. Quando era tornato, dopo il TG delle 13, il piatto era vuoto. A Giordano tanto bastò per avere ancora una volta in più conferma della loro sintonia. Volgolo, però, non mangiava solo la pastina. Dalle sue incursioni giornaliere al fiume, Giordano aveva preso l’abitudine di portargli sempre un regalino: una cannuccia masticata di estathé, un pezzetto di palloncino bucato, un rametto dalla forma curiosa. Volgolo dimostrava gratitudine incorporando l’elemento tra le sue maglie sempre più corpose di sudicio e ciarpame, tanto che, dopo solo un mese di co-abitazione, un cassetto del comò non fu più sufficiente ad ospitarlo, ed egli si allargò bellamente anche agli altri. Tanto Giordano aveva poca roba, e la teneva tutta nel comodino. A Celestino qualcosa non tornava: “Qui gatta ci cova. Tu sei troppo allegro. Non tu avrai mica trovato qualche sposina alla Grinza? Va a finire che tu mi dici che tu vai a letto presto, non mi dai mai la rivincita a briscola, e poi tu vai a ballare.” “Ma che ballare e ballare. Mi fanno male le anche!” Si smarcava Giodano, ma era vero, che sorrideva di più. Arrivò l’estate. Sul greto del fiume gli steli d’erba grassa erano diventati stecchi, e la terra era umida solo alle sei del mattino. Giordano raccoglieva ancora più souvenir, perché l’acqua bassa disseppelliva tesori, e Volgolo incorporava, felice. La Liliana era a Gabicce con la Marisa, e Celestino l’avevano portato i suoi figlioli a Castiglion dei Pepoli, perché in piana, dal caldo, non ci si campava. Gli altri anni Giordano, zitto e orgoglioso, ci aveva sofferto, solo e al caldo, a tirare flebili bacchettate al greto del fiume secco. Quest’anno no. C’era Volgolo. A volte, dopo mangiato, quando non sentiva volare una mosca ed il caldo, anche con il ventilatore a tre, era davvero insopportabile, si sorprendeva a chiedersi: “Sarò ingrullito?” Allora si alzava e andava a vedere Volgolo, oramai una piovra di sudicio che pendeva come un salice dai cassetti del comò, con qualche difficoltà ritrovava l’occhio Ferrarelle e quello di vetro verde, e interpretava il filetto di rame torto come un sorriso docile, comprensivo. Quindi tornava a fare le parole crociate della Nazione. Era mercoledì quando suonò il campanello mentre stava mangiando la pastina all’olio. Giordano non aspettava nessuno, e soprattutto, non c’era nessuno: erano tutti in villeggiatura. “Salve, sono il tecnico dell’Enel. Dovrebbe essergli arrivata una raccomandata 15 giorni fa. Vede, questo è il tesserino. Devo cambiarle il contatore, è qui? È qui?” Un ragazzotto tarchiato con una t-shirt nera sdrucita e un cartellino attaccato di sghimbescio stava già spalancando porte: Giordano non aveva nemmeno fatto in tempo a replicare. “Io non ho ricevuto nulla.” “Come no? Forse se ne sarà scordato? Mi faccia vedere un po’ dov’è il contatore.” Giordano lo vide fermare lo sguardo sulla Smart TV Samsung che aveva preso con i punti della Coop + 300 euro. Fu un attimo che il ragazzotto tirò fuori un coltellaccio svizzero e disse: “Zitto vecchio o t’ammazzo” e mentre a Giordano lampeggiava nella mente la civetta di qualche giorno prima “ANZIANI ATTENTI ALLE TRUFFE”, un rumore sordo rotolò dai cassetti e si fece passo pesante, anzi pesantissimo. Giordano impietrito vide il volto del falso operatore Enel contorcersi in una smorfia di orrore stupito prima che una pioggia di proiettili di regalini e sudicio lo travolgesse. “Ma che merda è?” Urlò il ragazzotto mentre quasi batteva il muso sugli scalini dell’ingresso e volava fuori, ad inforcare un’Ape scalcagnata che lo aspettava, in moto, poco più avanti. “Scappa, quello vive con un mostro.” “Quante Ceres hai bevuto stamattina? Sarai scemo!” E l’Ape ripartì. Giordano aveva le mani sudate. Con una difficile rotazione sulle anche si voltò: Volgolo era in piedi, un muro alto 2 metri di filamenti neri, sudicio misto e regalini di fiume, l’occhio Ferrarelle e quello di vetro verde appuntati in alto, poco più sotto il filo di rame disegnava uno spicchio felice. “Madonna come tu sei cresciuto, Volgolo. Bisognerà andare a Mondo Convenienza a vedere i cassettoni in offerta.”
I MIEI MOSTRI E LA VERSIONE DI BIGIO
di Jacopo Masini e Bigio
Un giorno del 2017, mentre ero in pausa pranzo - lavoravo in casa editrice - mi sono messo a disegnare dei mostri su un bloc notes. Così, perché ne avevo voglia.
Per lo stesso motivo, ho iniziato a fotografare i miei piccoli disegni e a postarli sul mio profilo Facebook.
Per lo stesso motivo, cioè perché ne aveva voglia, Bigio, cioè Luigi Cecchi, cioè Luigi Bigio Cecchi - che è un fumettista, un narratore, ma soprattutto un abilissimo disegnatore - ha iniziato a rielaborare i miei disegni e a postarli sulla sua pagina Facebook.
Lui è del mestiere dei disegnatori e io no. Quindi, i miei erano schizzi, i suoi disegni veri e propri, e ne è nata una galleria di coppie di mostri, i miei e i suoi.
Eccoli qui. Spero vi piacciano.
Almeno i suoi.
IL MOSTRO SONO IO (E SCUSATE SE È POCO)
di Elisa Rovesta
Lara è una giovane donna, bella, non troppo alta, con grandi occhi azzurri e capelli castani perfettamente stirati che le arrivano sotto le spalle. Lara lavora come interprete, conosce e parla quattro lingue. Oltre all’italiano sa l’inglese, il francese, lo spagnolo e il cinese. Ed è proprio in Cina che a breve deve andare, dopo essere rientrata da New Tork in cui ha partecipato a una conferenza nella quale c’erano importanti ingeneri e fisici di fama internazionale. Questa giovane donna sale e scende dagli aerei almeno due volte al mese senza battere ciglio, ma il giorno prima della partenza per la Cina sente dentro al petto una strana sensazione. Il cuore le batte più forte del solito, e quando pensa al momento in cui salirà la scaletta per imbacarsi, si accorge che le sue mani sudano. Non fa troppo caso a queste sensazioni e, da professionista quale è, la mattina arriva puntuale in aeroporto. Mentre fa il check-in le gambe tremano, senza che lei ne capisca il motivo. Il respiro si fa sempre più affannato e, stupita, pensa di avere la pressione bassa. In fondo ne soffre, ma sente che c’è qualcosa di diverso. Dopo circa un’ora Lara sale sull’aereo e prende posto sul sedile assegnato a lei. Fa sempre più fatica a respirare, e mentre il pilota comincia le manovre per il decollo, viene travolta dall’impressione di avere un fazzoletto in bocca che le impedisce di parlare, respirare, urlare, imprecare e capisce che sta perdendo il controllo. Stringe forte le mani, fino a ficcarsi le unghie nella carne, “è un mostro!” pensa. E continua “è un mostro che si è impossessato di me!” continua a ripetersi. Nel frattempo la hostess si accorge del pallore della ragazza, e le chiede se va tutto bene. “No”, risponde Lara, aggiungendo: “non va bene per niente, voglio scendere!” La hostess allora si siede nel posto vuoto al suo fianco, le prende la mano, alza gli occhi al cielo e sussurra: “Ci risiamo, è qui un’altra volta”.
Lara le chiede a chi si stia riferendo e la hostess le risponde che è vero, è un mostro quello che si è impossessato di lei. Aggiunge che lo ha incontrato tante volte nei passeggeri, e che sì, è un mostro con un nome e un cognome. La informa che la cosa che le sta dominando la mente si chiama “claustro” di nome, e “fobia” di cognome”, “claustrofobia” insomma. “Ma io non ne ho mai sofferto!” “Oh, cara mia, arriva quando meno te l’aspetti.” E continua: “E nemmeno arriva sola…”, aggiungendo che Claustrofobia si muove in coppia con Panico. Le racconta che i due sono veri mostri, e che tra loro c’è una relazione particolare; potrebbero sembrare amanti, quantomeno Panico è il trombamico di Claustrofobia, ma ciò che conta è che una non si muove senza l’altro. Lara guarda la sua interlocutrice con gli occhi del terrore e la hostess le dice: “Vedi, è arrivato proprio ora Panico”. “Posso mandarlo via?” “Si” afferma la hostess. E avvisa la giovane donna che se non prende atto di avere dentro di sé questi due mostri, è probabile che ne arriveranno altri, fatti proprio della stessa pasta. Si riferisce infatti ad “agorafobia”, “fobia sociale”, “aracnofobia” e tante, tantissime altre fobie, che sono però tutte figlie della stessa mamma. “E chi è la mamma?” chiede Lara. “La mamma si chiama Ansia. Spesso va a braccetto con sua cugina depressione”. Lara si fa sempre più pallida, piange e implora la hostess di aiutarla. La hostess, le dice che si può usare l’artiglieria pesante per combattere questi mostri. Le racconta che esiste un vero e proprio esercito di soldatini addestrati per combatterli, e si chiamano: Xanax, En, Tavor e tanti altri. La informa che però al momento non c’è nulla di questi prodotti disponibile, e quindi deve farcela da sola. Deve combatterli da sola i suoi mostri. Lara smette per un secondo di piangere, guarda la hostess e le chiede: “Dove abitano questi mostri?” La hostess le sorride, le accarezza una guancia e le dice piano: “Stanno conficcati nella tua testa”. Lara guarda in basso, i pensieri le scorrono così velocemente da poterne sentire il rumore. Poi si rivolge alla hostess e ricomincia a piangere mentre pronuncia a malapena alcune parole: “…ma quindi…” domanda Lara sgranando gli occhi: “se abitano nella mia testa, il mostro sono io?” “Esatto”, risponde la hostess, prendendole la mano. “Il mostro sono io, e scusate se è poco!” incalza Lara con un sospiro che lascia intendere un misto di rassegnazione e coraggio. “Esatto” ribadisce la hostess. La stessa le dice che esiste un solo soldatino capace di battere davvero questo mostro. E alla domanda di Lara, su chi sia questo soldatino, la hostess risponde: “Te stessa. Il miglior soldato”.
MOSTRI IN SALOTTO
di Giulio Girondi
Uno, nessuno e centomila. Di Rinascimenti però. L’idea è un po’ âge in realtà, ma non smette di stupire (almeno me). Un giovane Girondi – quindici o sedicenne, ma già nerd dell’architettura – ne rimase folgorato alla presentazione mantovana del monumentale tomo dedicato al Quattrocento della collana Electa Storia dell’architettura italiana. Sarà stato il 1998 o forse il 1999, da qui il dubbio sulla mia età di allora, e faceva freddino; era autunno o primavera, ma sicuramente una mezza stagione, di quelle che oggi non esistono più, come pensavamo fino a quest’anno, quando ancora ad aprile andiamo in giro col cappotto: più un quarto di primavera che una vera mezza stagione. Comunque faceva freddo, era sera, c’era buio. Quel giorno là alla presentazione del libro intendo. Ma io ero tutto un fuoco, e non perché ci fosse qualche ragazzina che mi piaceva, rigorosamente non ricambiato come era di norma – per me – durante tutto il liceo, ma perché qualche pezzo grosso del gotha della storia dell’architettura mi stava rivelando una verità, anzi in quel momento mi pareva La verità, manco fosse Mosé giù dal Sinai con le tavole della legge. Però mi ricordo che aveva la faccia (o più prosaicamente l’aura) del vecchio saggio, un po’ come ci hanno fatto immaginare Mosé nel film I dieci comandamenti. Solo che, al posto di due pietre, portava un mattone. Di libro. E che mattone! Di quelli che possono cambiarti la vita, o almeno indirizzartela, ma non perché ti è caduto su un piede, t’ha fratturato il metatarso e ti stai indirizzando al pronto soccorso, ma perché sei nel pieno dell’adolescenza, al mattino hai preso un 4 o un 5 in matematica o in inglese, la famigerata ragazzina che sogni come amore della tua vita non ti guarda manco di striscio e in tutto questo mare di schifo – che per te che non hai ancora iniziato a lavorare e a entrare nell’età adulta sembra lo schifo, ma che un giorno rimpiangerai (si stava meglio quando si stava peggio!) – l’architettura è la terra promessa di una felicità futura. Un sogno che ti porterà via dalla tua alienazione da liceale.
Ebbene, qual è La verità che mi venne rivelata quella sera? Quid est veritas? Così chiese Pilato a Gesù (Pasqua è passata da poco e quindi ho il Vangelo fresco in mente). Ma se Cristo non proferì risposta, quel professorone invece sì. E che risposta. Mi ammutolì dicendo che non esiste un solo Rinascimento, ma che ogni territorio ha avuto il suo, con tempi e modi diversi. E che, anzi, ogni territorio, a ben vedere, ne ha avuto più di uno, frutto di intersezioni tra novità e influssi culturali di avanguardie artistiche e inerzie o ritardi figli di un gusto, quello cortese del gotico internazionale, duro – anzi durissimo – a morire. Novità, rifiuto di novità, ibridazioni. E così, almeno per tutto il Quattrocento, fare parallelismi tra cronologie di contesti lontani, ma anche vicini, diventa difficile, se non impossibile. Tutto d’un tratto, una pagina da manuale di storia dell’arte si animava; da statica e assoluta, diventava piena di se e di ma. E improssivamente per la tua giovane mente diventa più accettabile che, alle soglie del Cinquecento di Michelangelo e del nuovo San Pietro, in area padana potessero ancora sorgere chiese o cappelle che sembrano sbucare dal medioevo più profondo. Del resto, anche oggi qualche stilista continua a proporre o riproporre soluzioni di venti, trenta o quarant’anni fa.
L’impatto di quella sera sulla mia mente fu devastante, e la reale portata nella mia vita di quel momento lo capisco solo oggi. Perché, in fin dei conti, il Rinascimento – ma col tempo capii che funzionava così praticamente per ogni aspetto del sapere – smetteva di essere un concetto astratto, un dicesi Rinascimento… di fantozziana memoria, qualcosa che potevi conoscere e afferrare. Quella sera fu la prima volta che mi veniva rivelato come la realtà non sia un monolite bidimensionale e conoscibile in modo semplice. Semmai è il monolite di 2001 odissea nello spazio, inconoscibile e inafferrabile. Ecco che allora capisci che le cose che pensiamo vere tout court possono invece essere frutto di modelli interpretativi. Che non stai studiando la realtà in sé, ma le interpretazioni che di essa ne ha dato questo o quello studioso. Cogli così che tu non vedi o studi il mondo che ti sta attorno con degli occhi che vedono la verità, ma semmai con tanti occhiali diversi che ti lasciano intravedere frammenti di verità, intersezioni di verità di cui tu, se va bene, capirai sempre poco o nulla. Quella sera imparai che, accanto alla storia, esiste la storiografia, cioè la storia di come si è letta la storia. E lo scioglilingua è dietro l’angolo!
Il Rinascimento è un campo di indagine straordinario per tastare il terreno e verificare come le cose stiano proprio così. Già il termine, Rinascimento, è un’invenzione abbastanza recente, mediata dal francese Renaissance. Che delusione: il nostro momento di vertice artistico massimo lo chiamiamo scopiazzando i cugini d’oltralpe! Semmai gli intellettuali del Cinquecento usavano la parola Rinascita per esprimere il rinnovamento culturale loro, dei loro genitori e dei loro nonni del secolo precedente. Invece, nel Quattrocento, chi aveva la percezione del cambiamento usava la contrapposizione tra moderno, cioè quello che per noi è l’arte gotica, e antico. Roma, in primis, ma anche un po’ Grecia e Gerusalemme. Insomma, la modernità era l’antico. Il vecchio era la modernità. Che cortocircuito!
Ma era veramente così? A leggere Filarete e il suo trattato in forma di dialogo parrebbe di sì. Almeno quando a parlare è quel “talebano dell’antica” Ludovico II Gonzaga Marchese di Mantova. Anche lui, però, nei fatti cade nel trappolone della mescolanza. Oggi diremmo sincretismo. Io preferisco minestrone, anzi, dato che sono parecchio goloso, risotto: perché la voglia di antico di Ludovico II è in realtà costellata anche di torri e di merli, eredità del mondo castellano e feudale di cui egli stesso era un emblema vivente, in quanto principe del Sacro romano impero. Quello di Carlo Magno, alleggerito però della parte francese e all’epoca decisamente più teutonico. In soldoni: Mantegna e Alberti – nomi altisonanti che fanno tremare le gambe ancora oggi – conditi nel burro della società cortese di allora.
Se già l’arte di corte, a parole dura e pura, era nei fatti molto più politicamente corretta, cosa accadeva nelle case dei ricchi signorotti di città o di compagna che ruotavano attorno al principe? Cortigiani, vil razza dannata urlava Rigoletto. In effetti, fino alla fine del Quattrocento, è facile trovare elementi di cultura prettamente medioevale nelle case private. Elementi che possono convivere serenamente con ornati all’antica, oggi diremmo rinascimentali, scopiazzati da Mantegna o dagli altri pittori di corte delle mille signorie padane di allora. Già, padane, perché stiamo parlando di un territorio abbastanza preciso, quanto vago nei suoi confini, eterogeneo, ma con pure caratteri comuni fortissimi, quale è la valle del Po. Se oggi la Padania ha smesso di essere, o quasi, una pseudo-identità politica, la Padanìa – vedi come basta un accento e cambia tutto! – continua a significare qualcosa. Basti un breve esempio gastronomico: l’avevo già detto che sono goloso. Se vi dicessi che nella mia città si mangiano tortelli di zucca e sbrisolona, capireste di dove sono? Mantova, Ferrara o Cremona? O ancora: agnolini, tortellini, marubini, cappelletti. Riso, salame, maiale. Basso Veronese, Piacentino, Modenese. Un’area che sfuma nel mare col delta del Po e parte, almeno per me, dalla valle del Taro, antica porta della via Francigena per scavallare gli Appennini e scendere da Parma a Roma: non a caso avvenne qui, nel 1495, la mitica battaglia di Fornovo tra la lega antifrancese capitanata da Francesco II Gonzaga (impresa del Sole) e re Carlo VIII, con il suo generale Gian Giacomo Trivulzio (anche lui impresa del Sole! Perché tutto il mondo è paese e i simboli, quando sono archetipici, piacciono a tutti).
Questa valle del Po e dintorni, centrata nell’Emilia paranoica dei CCCP, ha caratteri comuni da secoli. C’è una storia che viene da lontano, quindi, anche per quanto riguarda l’architettura e l’arte del costruire. Pensiamo (così entriamo nel vivo di quello che volevo dire prima di prendere la tangente) ai muri in mattoni – rossi o chiari, a seconda se nell’argilla ci sia più o meno ferro – e ai soffitti di legno. Si costruisce così, soprattutto con solai di legno “a doppia orditura”, cioè con una o più travi principali che reggono file di travetti su cui si poggia l’assito, dal Piemonte alla Lombardia, all’Emilia-Romagna, al Veneto e fino anche al Friuli. In quest’area, non proprio piccolina quindi, di solito gli spazi tra i travetti dell’orditura secondaria venivano chiusi da tavolette, sempre in legno. Non c’è un termine in italiano per chiamarle. Nel dialetto di Mantova sono le lattole, mentre in Veneto diventano le cantinelle. Nella maggior parte dei casi sono strette e lunghe, ma se i travetti poggiano su mensoline possono invece cambiare radicalmente forma e diventare dei pannelli veri e propri. Soprattutto tra Cremona e Brescia ne troviamo di bellissime, per esempio quando all’interno sono dipinti busti di personaggi. Ma queste sono una minima parte: una minoranza qualificata, ma pur sempre una minoranza. Il più delle volte abbiamo invece motivi decorativi, magari con stemmi o imprese. Nel secondo Quattrocento il gusto all’antica portato nel nord Italia dalle avanguardie fiorentine – Brunelleschi viaggia sopra il Po già negli anni ’30 del XV secolo, mentre Donatello visse e lavorò a Padova: suo è l’altare del Santo, ad esempio – la fa da padrone, soprattutto grazie ad artisti di corte come appunto Mantegna che elaborarono un vero e proprio alfabeto per coprire, con ornati desunti o rielaborati dalle glorie archeologiche, ogni centimetro quadrato dei palazzi delle vecchie o nuove classi dirigenti. Perché allora l’ascensore sociale funzionava e poteva anche capitare che un macellaio o un bottegaio diventasse tra i più ricchi della città, facesse studiare i figli all’università – che c’erano già, è bene ricordarlo – e magari riuscisse introdurli a corte, trasformandoli da garzoni a funzionari di palazzo e lavando via il puzzo di sugna dalle loro vesti. Storia quasi vera, perché i Valenti di Mantova – quelli del cardinale quasipapa Silvio Valenti Gonzaga – erano partiti da una botteguccia sotto i portici.
Tuttavia, visto che – lo abbiamo già detto – non esiste un Rinascimento, ma tanti gusti che si sovrappongono in un medesimo spazio temporale, capita di trovare, accanto a fregi affrescati che sembrano presi dalla Camera degli Sposi, anche ornati che proprio non c’entrano nulla. Almeno per noi. Ecco che sulle nostre lattole compaiono ad esempio cicli con animali, veri o finti. Reali o d’immaginazione. Che poi, per loro, uomini del XV secolo, chissà dove finiva la realtà e iniziava l’immaginazione.
Gli animali finti, i fake, o i freak, sono quasi la norma. Mostri, un po’ uomini, un po’ bestie, sono dipinti direttamente sul legno, spesso senza fondo o disegno preparatorio, con un tratto rapido e sapiente. Convivono con animali reali, stemmi e verzure. Gli esempi meglio conservati sono a Cremona, Crema, Mantova e – udite udite – Viadana. Già, una cittadina tra Mantova e Parma che poi ospiterà anche un giovane Francesco Mazzola, cioè il Parmigianino, e dove visse suo cugino, Girolamo “Mazzola” (cognome rubato perché più famoso, un po’ come accade nel mondo del circo, dove si chiamano tutti Orfei) Bedoli. Qui, nel museo Parazzi, ma anche in tante case private, abbiamo una miriade di tavolette con animali e altrettante con mostri, che lette insieme dovevano avere, in origine, intenti moraleggianti, allora immediatamente comprensibili per i richiami ai Bestiari, ma che per noi oggi non sono sempre facili da capire. Almeno quando non compaiono scritte ultraesplicite come il «Bene facite» di casa Cavatorta a Viadana. Comportati bene. In dialetto fa bel. (vedi immagini allegate nel mio scritto)
È interessantissimo cogliere come, mostri di questo tipo, accomunino il nostro contesto padano a territori lontani, come il sud della Francia. E qui la studiosa di riferimento è la giovane e bravissima Roberta Aglio, che sta dedicando la vita allo studio dei soffitti con tavolette dipinte. Nell’area della Linguadoca e della Provenza, tra Carcassonne, Tarascona, Capestang, Avignone e, più a nord, Fréjus e Metz, troviamo soffitti come quelli di Mantova e Viadana. Come questi mostriciattoli valicarono le Alpi ancora non si sa. Viaggi di intellettuali, artisti e artigiani? Fonti comuni, come miniature o libri? Tutto può essere.
Oggi il più antico bestiario su soffitto giunto fino a noi sembra essere quello del museo di Metz, con cassettoni realizzati tra il 1240 e il 1275, su cui prende vita un mondo fantastico. Qui, come a Viadana, troviamo creature dal corpo animale e volti femminili, uccelli dal collo attorcigliato, zampe massicce e piccole ali. Ma anche mezzi busti umani con doppie code, quasi delle sirene. Sono mostri che paiono presi in prestito dai senmurv dei tessuti sassanidi, i cui prototipi stanno nell’arte tardoantica, nelle illustrazioni dei testi cristiani più antichi, poi nei Phisiologus e nei Bestiari, fino alle silografie dei primi incunaboli. Una storia che viene da lontano, quindi, di cui abbiamo capito ancora pochissimo e che dalla nostra valle padana porta in Francia e, ancora più in là, in Medioriente, magari passando per il nostro Sud. Sempre Roberta Aglio, infatti, nota come il motivo della coda curiosamente avvolta attorno alla zampa posteriore di animali e ibridi, che all’origine doveva essere un chiaro segno di sottomissione, enfatizzato ad esempio nei leoni stilofori delle cattedrali romaniche e che in seguito diventa quasi un vezzo nelle nostre tavolette, compaia in una formella del duomo di Cefalù, dove un leone sbrana un’antilope, secondo un gusto che dichiara con forza l’ascendenza islamica del soggetto. E ancora, il capo volto all’indietro che animali e mostri immaginari presentano con insistenza, non solo a Viadana, riporta ancora a tessuti sassanidi e siriani, giunti nell’Europa medioevale con la mediazione delle conquiste arabe del nostro Meridione. Basta un attimo di distrazione e ti trovi un mostro franco/arabo in salotto.
VECCHI RAGAZZI X
di Lorenzo Mercatanti
-1-
Vecchia ragazza
Mi racconta di un paio di compagne che, secondo lei, avevano una cotta per me. Mi dice dei tremila lavori che ha fatto fino a oggi. Mi dice ogni tanto esce con un collega, “mi invita ad uscire quando ha voglia di andare in un locale dove, per farti entrare, ogni quattro uomini, deve esserci almeno una donna. Ci andiamo io, lui e tre suoi amici.”
-2-
Chi l’avrà mai visto?
“L’abbiamo ritrovato.”
“Siete sicuri?”
“Guardi queste foto.”
“Non è lui.”
“È sicura? Eppure ci sono tutti i riscontri, è proprio sicura?”
“Non vedete come sorride in questa foto, non l’ho visto mai così felice, no non
è lui.”
-3-
X
“È vero che X sta andando male, che la sua azienda fallisce?”
“È la voce che sto mettendo in giro io, non lo so se è davvero così.”
“Già, sta sul cazzo a tutti X.”
-4-
Poe
Una volta ci aveva provato, uno dei ragazzi dementi della mia adolescenza, aveva tentato il colpo a sorpresa.
Aveva preso a scrivere racconti, li faceva leggere a tutti, a me, che non facevo leggere i miei.
Il padre lo iscrisse alla FENALC e lì organizzavano concorsi per Autori in erba, si riunivano a leggersi i racconti, il padre sperava così non si rendesse più ridicolo con noi. Ma lui no, voleva metterci a parte, ci voleva alle letture, alle cene della FENALC dove leggeva le sue storie, alle premiazioni dei concorsi.
Ad un concorso, dove ricevette un attestato molto dopo la premiazione dei vincitori, mi si avvicinò, “hai visto?” mi fece, “Vedi come mi guardano le giurie! Fanno sempre così tutte le volte, ma l’ho capito perché.”
Io glielo chiesi cosa avesse capito.
“Ieri ho passato la giornata in biblioteca, a cercare, ho cercato tanto e sono finito ai racconti dell’orrore, guarda caso quelli come scrivo io, e a vedere i vari scrittori in fotografia ho capito perché mi guardano sempre così alle premiazioni.
Sono spiccicato a Edgar Allan Poe.”
Peccato.
Mi manca molto adesso.
-5-
Incontri
Incontri:
Il diavolo.
incontro il diavolo, invece di vendergli l’anima gli consegno i miei oggetti personali, come quando si è messi in carcere, quindi un documento, come quando si arriva in un albergo, quindi la carta d’identità valida per l’espatrio, come prima dell’Europa unita.
La scrittura.
Il mio incontro con la scrittura ascoltando uno scrittore che parlava del suo incontro con la scrittura (l’evangelo nell’evangelo).
-6-
Un bambino
Una vita fa, all’ambulatorio pediatrico accompagnato da mia madre; il pediatra, un vecchio compagno d’infanzia di mio padre, per tutto il tempo mi chiama debosciato, dormiglione e mia madre in silenzio: ricordo come si era già fatto buio una volta terminata la visita, fino a casa fino alla luce del cucinotto, dove, nascosto dietro la porta, ascoltavo mia madre riferire a mio padre della visita dal pediatra, di quando il medico l’aveva presa in disparte per confidarle di avere grossi problemi con i figli, in particolare con la figlia femmina, o era il maschio, non lo ricordo più.
Qualche anno fa, dalla cronaca locale venni a conoscenza del suicido della figlia (o figlio, non mi è mai rimasto in testa se maschio o femmina) di quell’ormai vecchio medico.
-7-
Vecchio ragazzo
Di lui dicono che è cambiato: è diventato buono, non è più la merda che ricordo.
“Non doveva farsi sotto,” mi disse una volta, dopo aver spaccato la faccia a un ragazzo grosso il doppio di lui, mi ricordo le labbra spaccate e l’apparecchio per i denti che penzolava fuori della bocca; lui, vestito di tutto punto come al suo solito, aveva il sangue dell’altro sui pantaloni chiari.
L’ho visto di recente, un saluto veloce, io ero in macchina, lui stava aiutando suo padre a salire sopra un’ambulanza. Il padre e la madre sono anziani e malati, li accudisce lui, ha una sorella, ma dei genitori si disinteressa, lui una volta mi disse, “non rimprovero niente a mia sorella. Cosa gli dovei rimproverare, di non sentirsela di passare tutto il giorno in mezzo al piscio e alla merda di due vecchi malati?”
Di lui penso che è lo stesso di sempre.
Robbabuonachecipiace
LEGGETE BENGALA!
ISCRIVETEVI A BENGALA!
Ray Banhoff scrive cose che leggerete solo da lui, nella sua esplosiva newsletter che fa luce nella notte dei giorni tutti uguali. Editoriali umorali, libri, fotografie, scazzi, slanci, musica: tutta roba buona.
Abbiamo deciso che Mollette e Bengala sono cugine, per affinità, per simpatia, perché sì.
Quindi noi, cioè Davide e Jacopo, vi invitiamo a cliccare QUI e a seguire le scintille di Bengala.