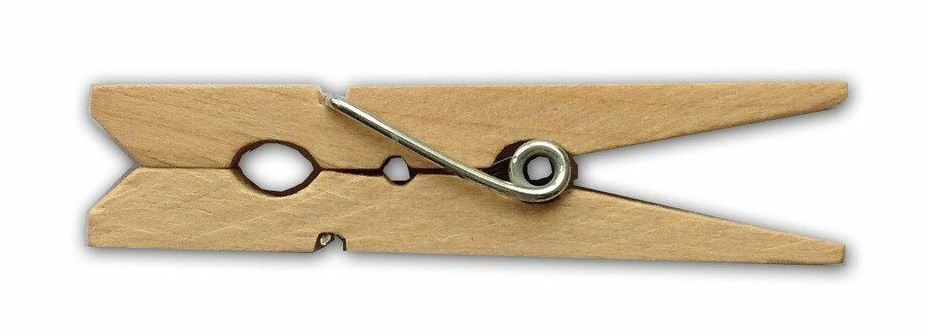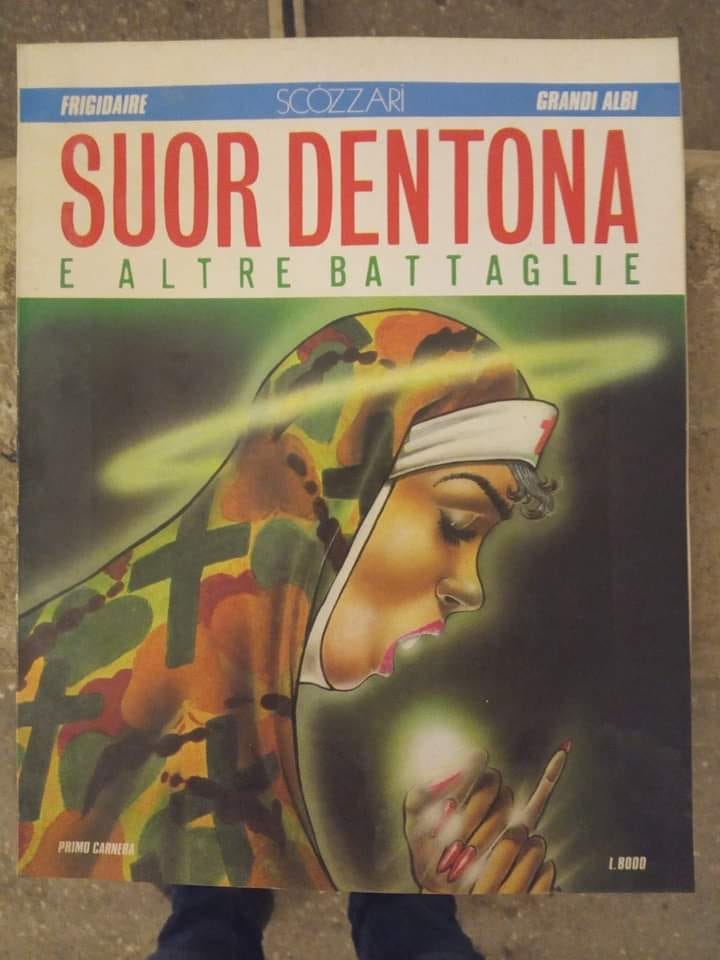COS’È MOLLETTE RACCONTINI?
Facile.
Uno speciale dedicato a brevi racconti che ci piacciono.
Racconti stesi qui a prendere aria. Se avete voglia e tempo, si fanno leggere volentieri.
CAMERE D’ARIA
di Davide Bregola
Si aprì la finestra di sopra, quella in cui abitava Arcadio il biciclettaio. Si affacciò la moglie. Guardammo in alto. “Ecco”, “pensai, “Ci ha beccato.”
“Giovanni, Simone, venite su per favore…”
Immaginai ci avesse visto entrare. Non ci voleva proprio, non avevo voglia di prenderle.
A fare?” chiese Simone.
“Per favore. Venite ad aiutarmi.”
“Per cosa?”
“Venite a darmi una mano. C’è il portone aperto.”
“No ma come facciamo a entrare. C’è buio.” Quel budello scuro e puzzolente penetrava chissà quale anfratto.
In Via XX settembre passò un’ambulanza a sirene spiegate. Fu un baleno, ma intanto lei parlava e la sirena coprì le sue parole.
“V… acc… il n… nite…”
Non so cosa accadde, però io e Simone ci guardammo e, quasi per sfida, o forse per curiosità di vedere per la prima volta la casa di Arcadio, aprimmo di nuovo il portone dove poco prima eravamo entrati a vedere le donne nude del calendario.
“Dopo accostatelo. Non vorrei entrassero i ladri…”
Mi feci coraggio. Spalancai il portone. Ci investì l’odore di gomma dei copertoni e delle camere d’aria. Era tutto fermo. Una luce vibrava sopra le nostre teste. Il calendario con la donna nuda dai capelli ricci voluminosi mi attraeva come una calamita, ma già si sentiva la voce della moglie di Arcadio.
“Venite di qua…c’è la luce…”
In quella caverna non c’erano altro che attrezzi da meccanico: un banco da lavoro, una serie di chiavi e cacciaviti, una morsa. Il secchio pieno d’acqua a lato della sedia. In terra, fino al primo gradino, c’era terra battuta. Stavolta ero davanti a Simone. Mi seguiva senza parlare.
La moglie di Arcadio mi prese la mano. Era come se vivessi in un sogno. Aveva un vestito lungo nero, il grembiule bianco e una strana espressione negli occhi.
“Qui, venite…”
Entrammo. C’era un tappeto color amaranto e odore di pasta al ragù. Sbirciai, c’era la cucina.
“Aiutatemi. E’ qui da poco.”
Entrammo nella camera da letto. C’era un baule a destra, con un paio di ciabatte tra il letto e la specchiera. Sopra al letto la Madonna con bambino sembrava fissarci.
“Dobbiamo vestirlo, ma da sola non riesco…”
Arcadio era lì steso a letto con la sua salopette blu da operaio. Sembrava dormisse, ma la sua faccia era marrone. Soprattutto le labbra. Sembrava avesse provato a ingoiarle.
La vecchia prese una giacca dall’armadio.
“Tienimela stretta.” La passò a Simone.
Facevamo tutto quello che diceva lei.
Era andata a prendere delle scarpe in una scatola di cartone sopra all’armadio.
Una camicia, un paio di pantaloni neri.
Arcadio era lì fermo.
“Vai in bagno a prendere un asciugamano. Bagnamelo un po’, strizza l’acqua e portalo qui.
“Dobbiamo fare in fretta. Tra un po’ diventa duro e non riusciamo più a piegarlo.” Disse.
Gli togliemmo il toni da lavoro. Aveva una canottiera gialla in lana, sembrava sporca, e le mutande bianche.
Io gli tenevo le gambe in alto perché la moglie provava a infilargli i pantaloni. Una gamba era pelosa e muscolosa. L’altra sembrava un ramo secco senza foglie. Sarà stata almeno una spanna più corta. Mi accorsi che a lato della mutanda bianca usciva una palla spelacchiata di Arcadio, ma nessun altro lì dentro ci fece caso.
Simone frizionava l’asciugamano su collo e ascelle. Aveva del pelo bianco sulle spalle.
“Pulisci bene, così poi gli metto la camicia.”
Gli infilò i pantaloni, alzò la cerniera e abbottonò. Mi scappò quasi da ridere per via della palla spelacchiata.
Tolse la camicia bianca dalla gruccia. Tirammo su il busto prendendolo per le braccia.
Simone saltò sul letto per tenerlo dritto in modo tale da potergli infilare la camicia e abbottonarla. Lasciò sulle lenzuola l’impronta nera della suola.
“Devo chiamare Don Alfio. Aspetta che gli mettiamo la giacca e lo chiamo…”
Gli infilammo giacca e scarpe, lo posammo sul letto alla bell’e meglio. La vecchia gli prese le mani e le unì. Gli mise in mezzo un rosario che estrasse dalla tasca del grembiule.
“Grazie, venite di là…”
La seguimmo. Entrò in cucina, aprì il frigorifero.
“Volete della gassosa?”
Io non avevo né fame né sete.
“A me un bicchiere.” Disse Simone.
La vecchia prese un bicchiere dal secchiaio e versò.
Mentre beveva ci guardavamo. Non avevamo paura, non sentivamo niente. Almeno io non provavo nulla di particolare. Simone beveva.
Si sentiva dire dal corridoio: “Sì, Don Alfio. Quando ha tempo di venire…”. Era la donna che telefonava.
Noi uscimmo alla luce. Simone aveva rubato il calendario e ci guardammo l’anno intero, però la mia preferita rimase per lungo tempo la mora ricciolona.
UDINÌ
di Jacopo Masini
“Venga nel mio ufficio, Udinì” disse al telefono il direttore del personale con una specie di allegra concitazione nella voce.
“Proprio io?” disse Udinì.
“Proprio lei. Devo darle una bella notizia”. Questo spiegava quella vena di allegria: una buona notizia. Udinì non si era sbagliato.
Udinì lavorava come redattore nell’Ufficio Stampa della Incom Soluzioni, un nome che non c’entrava nulla con le attività dell’azienda. Incom Soluzioni faceva pensare a qualcosa che avesse a che fare con l’informatica, oppure con la gestione del personale, al limite, ma proprio al limite, con l’organizzazione del comparto turistico, ma non certo a quello di cui si occupava davvero l’azienda: vendita al dettaglio di piante e arredamenti da giardino.
Non era chiaro perché i due soci, Marzali e Pianoro avessero deciso per quel nome. Non importava. Uno dei suoi compiti, di Udinì, era quello di raccontare ai giornali, ai blog, a chiunque fosse il destinatario di uno dei suoi comunicati, quale fosse l’origine ufficiosa di quel nome. Insomma, inventava, adattando Soluzioni Incoming alla partecipazione dell’azienda a una importante fiera internazionale, a un premio vinto nel campo della decorazione e del vivaismo contemporaneo, all’invenzione di un nuovo taglio per le piante da esterni, ecc.. ecc…
Da lui, da Udinì, pretendevano solo che desse ogni giorno, per quasi nove ore al giorno, sfogo alla propria impiegatizia creatività.
“Buongiorno” disse Udinì. Era arrivato al quarto piano, interamente occupato dall’ufficio del direttore del personale e dalla scrivania della segretaria. “Mi chiamo Udinì, il dirett…”
“La sta aspettando nel suo ufficio. Entri pure”
“Grazie”
“E”, aggiunse la segretaria, Udinì si voltò, “complimenti. La invidio, sa?”
Udinì rimase impalato. “Grazie” disse confuso. Quasi gratificato. Senza sapere perché.
L’ufficio del direttore era enorme, arredato da una falange di piante d’arredamento che a stento lasciavano intravedere le pareti.
“Udinì. Che piacere rivederla. Si sieda, prego”. Il direttore stava indicando una enorme poltrona di vimini, di fronte alla scrivania.
“Buongiorno direttore”
“Vado subito al sodo: lei è stato scelto dall’azienda come nostro rappresentante in una gara internazionale”. Il direttore sorrideva. E aspettava. “Lei, Udinì. Proprio lei”, e continuava a sorridere.
“Oh” disse Udinì, “grazie infinite”
“È davvero fortunato”
“Grazie ancora”.
“Dovrà rimanere chiuso in azienda per una settimana e lavorare per almeno 18 ore al giorno. Anche 19 o 20, se vuole. Dormirà comunque qui in azienda, nel suo ufficio. Potrà usare i bagni della dirigenza. Sarà lei a dimostrare quanto sono zelanti i nostri collaboratori. Quanto capaci. In grado di sostenere senza fatica grandi carichi di lavoro. È felice, Udinì?”
Le poltrone di vimini avevano sempre fatto venire in mente a Udinì le feste in campagna. Grandi tavolate, gente vestita di bianco. Cose così.
“Udinì? Non è felice?”
“Ne sono onoratissimo, direttore. Farò del mio meglio”. Una banda che suona, la luce del tramonto che dilaga sui campi.
La gara consisteva precisamente in quello: una settimana in ufficio, 24 ore su 24. Ognuno dei partecipanti, un rappresentante per ognuna delle trenta aziende che erano state sorteggiate, avrebbe dovuto produrre il triplo del lavoro giornaliero previsto da un comitato composto dai dirigenti delle stesse aziende. Il settore prescelto era quello del Marketing e della Comunicazione.
Per questo avevano scelto Udinì. Da dieci anni era lui a occuparsi dell’Ufficio Stampa della Incoming Soluzioni, a comunicare le attività, i progetti, la storia di un’azienda che da due soci era passata ad avere oltre duecento dipendenti. Lui solo.
La gara iniziò il lunedì mattina alle 8 e sarebbe terminata alle 8 del lunedì successivo. Il lavoro previsto sarebbe stato comunicato ai partecipanti in una busta chiusa all’avvio della competizione.
Così, alle 8 di lunedì, Udinì entrò in ufficio. Ad attenderlo sulla porta c’erano i due soci fondatori. Gli strinsero la mano. Sorridevano. “Complimenti, Udinì” dicevano. Entrò.
Sulla scrivania trovò la busta. La aprì. Conteneva sette fogli, su ognuno dei quali erano scritti il numero di comunicati che avrebbe dovuto produrre in un giorno, il numero di battute complessive per ognuno dei comunicati, il numero di telefonate da effettuare e la cifra dei comunicati che i giornali, i siti web, le tv avrebbero dovuto riprendere grazie al suo lavoro. Udinì lesse. Poi sedette al tavolo e iniziò. Nell’angolo alla destra della scrivania vide il letto fatto. Ricordò sua nonna che gli rimboccava le coperte. Una volta che aveva avuto l’influenza e aveva sognato che un gruppo di indiani Comanche gli facevano lo scalpo. E poi la colonia, d’estate. Le bambine in pigiama della camerata accanto. E iniziò a lavorare.
Per prima cosa avrebbe dovuto scrivere due lungi comunicati: sulla storia dei due soci. Ormai la sapeva a memoria la storia inventata di quei due. Via, poteva iniziare.
Alle cinque del pomeriggio aveva finito di svolgere le mansioni previste nel primo foglio. Lesse, rilesse di nuovo. Le aveva svolte tutte. Ma doveva passare ancora tutta la sera e la notte in ufficio. Così si mise avanti e cominciò il foglio del giorno dopo.
La notte trascorse tranquilla. In ufficio faceva caldo. Lesse un libro, mandò un sms a casa per dire che stava andando tutto bene e si addormentò.
La sera del secondo giorno aveva concluso il lavoro dei primi quattro giorni. “Cosa faccio? Chiamo il direttore?” si chiese. Chiamò il direttore.
“Buonasera direttore”
“Buonasera Udinì. Non mi dica che è già stanco”
“No, si figuri. La chiamo per dirle che il lavoro che mi avete affidato è, sì, insomma, ecco, sono molto avanti. È quello che di solito svolgo in un paio di giorni. Di questo passo domani avrò terminato”
Silenzio.
“Direttore”
“Ma, Udinì, lei è un prodigio. Io non lavoro così tanto nemmeno in due settimane”
“Grazie direttore”. Udinì pensava.
“Chiamo subito il Comitato e le faccio avere un’altra busta. Sapevo che era l’uomo giusto”.
Udinì pensava. Aveva visto il direttore quattro volte negli ultimi due anni, più o meno.
Il terzo giorno arrivò la seconda busta. Il quinto la terza e il sesto la quarta.
Il direttore, ogni volta, non faceva che elogiarlo, dirgli quanto era sorpreso, che ammirazione nutriva nei suoi confronti. Davvero non immaginava che lui fosse così tenace, capace fino a quel punto di triplicare, quadruplicare i carichi di lavoro.
Udinì si fermò ancora a pensare. Il sesto giorno stava per confessare al direttore che quelli erano i suoi carichi di lavoro consueti. Ma qualcosa gli impedì di farlo. Pensò non fosse il caso.
Così, trascorse la domenica senza fare nulla e la notte dormì benissimo. Il lunedì sarebbe stato libero.
E il lunedì mattina alle otto, in effetti, poté uscire dall’azienda. Il giorno dopo sarebbero stati comunicati i risultati della competizione.
Il martedì andò in ufficio. Verso metà mattina il direttore lo fece chiamare. Entrò di nuovo in ufficio. Sedette di nuovo sulla poltrona di vimini e guardò il direttore. Sorrideva.
“Due settimane, Udinì. Le diamo due settimane. È contento? Non è mai successo”
La poltrona di vimini, adesso che la toccava meglio, gli ricordava Sara Costa, il mare, quella volta che l’aveva vista scendere le scale dei Bagni Onda: era cambiata tantissimo, da un anno all’altro. Lui era seduto al bar dei Bagni, con i suoi amici, e quasi non l’aveva riconosciuta. Se ne stava seduto là, sulla poltrona di vimini del bar e pensava “Non può essere diventata così bella”.
“Udinì. Mi sente? Altre due settimane in ufficio. Lei ha vinto. Dovrà fare anche il nostro lavoro, mio e dei due soci. È contento? Le abbiamo concesso anche un letto matrimoniale e un ufficio più grande. Io la invidio, sa?”
Gli sembrava di sentire tutto il mare costringersi tra le sua labbra, la sua lingua e le labbra di Simona, la lingua di lei, morbidissima e dolce, la prima volta che l’aveva baciata. Come aveva fatto a dimenticarsene?
“Grazie, direttore”, disse Udinì. “Farò del mio meglio”.
ANGELO FILIPPO TREVISI
di Chiara Stival
All'età di 7 anni, Angelo Filippo Trevisi raggiunse la sua prima consapevolezza.
Una sera di ottobre, durante la cena, proprio non riusciva a mangiare, allora sua mamma gli chiese: com'è che non mangi? Stai male?
Angelo Filippo rispose che era preoccupato. E la mamma incalzò: e di che, a sette anni? Allora lui si confidò: se fossi nato a Sparta, sarei morto lanciato giù dentro un buco, l'ha spiegato la maestra. La mamma rispose che il difetto alla sua gamba non era tale da provocare una scelta del genere, e comunque: non era nato a Sparta, era nato negli anni '70 e quel difetto lo avevano risolto, a parte qualche piccola limitazione, o no?
Allora la faccia di Angelo Filippo si allargò in un grande sorriso e pensò di essere un bambino fortunato. Poi mangiò.
Qualche anno dopo, Angelo Filippo fu di nuovo rattristato dalla storia dell'umanità e di nuovo si confidò con la sua mamma: se fossi nato in Africa nel XVII, sarei stato uno schiavo e non avrei potuto studiare. Allora lei rispose che il colore della sua pelle lo avrebbe preservato da quel terribile destino, e comunque non era nato in Africa, era nato in Italia e oggigiorno la tratta degli schiavi era stata abolita, o no?
Di nuovo la faccia di Angelo Filippo si allargò in un grande sorriso e pensò per la seconda volta di essere un bambino fortunato.
Episodi di questo tipo si presentarono anche negli anni seguenti e rafforzarono in lui l'idea di essere nato sotto una buona stella. All'età di 36 anni, però, cambiò prospettiva.
Era andato a vivere in un piccolo paese nell'appennino umbro-toscano, vicino a una comunità new-age in stile buddhista, che aveva iniziato a frequentare anni prima. Stanco di prendere il treno, aveva traslocato dopo aver ottenuto un trasferimento nella piccola banca di un paese limitrofo, così di giorno vestiva in giacca e cravatta, la sera si trasformava e metteva le vesti monacali, cantava litanie, consumava incensi a iosa e disegnava mandala nel pavimento del soggiorno.
Un sabato mattina, alle 11.30, sentì il suono del campanello e ne rimase meravigliato: non frequentava nessuno, non aveva fatto ordini online, chi poteva essere?
Si presentò l'appuntato Servodidio, e chiese di parlare col Sig. Narayana. Angelo Filippo rispose: sono io. L'appuntato lo invitò a mostrare i documenti e constatò che non era lui. Domandò nuovamente di parlare col Sig. Narayana, quindi Angelo Filippo rispose che quello era il nome che gli aveva dato il suo maestro, e che compariva nella targhetta del campanello perché glielo avevano consigliato quelli dell'ufficio postale, altrimenti non potevano consegnare la corrispondenza dal Nepal indirizzata a quel nome.
L'appuntato Servodidio non era convinto. Lo invitò a farlo entrare per provare che non stesse ospitando abusivamente uno straniero, per giunta senza documenti. Mentre l'appuntato verificava l'assenza del Sig. Narayana, constatando la presenza di un solo spazzolino da denti e altri minori dettagli, Angelo Filippo ricordò le lamentele alle riunioni condominiali (a cui non aveva dato peso), i sacchetti dell'umido rotti proprio a fianco alla sua macchina e certi sguardi ostili, a cui la sua via spirituale si era imposta di non badare.
Poi l'appuntato Servodidio si congedò.
Tre giorni dopo, Angelo Filippo Trevisi entrava nell'ufficio postale per ritirare un atto giudiziario: era il verbale in cui si dava atto che non vi era presenza di alcun straniero nella sua abitazione, ma veniva sanzionato per sdoppiamento d'identità.
Fu in quell’istante che Angelo Filippo e Narayana giunsero alla medesima, nuova e inconfutabile consapevolezza: ovunque nasci, in ogni tempo, ci sarà qualcuno che vuole romperti i coglioni.
CIAO
di Chiara Stival
Ti ricordi quando venivi a prendermi in ciao e mi portavi a mangiare il gelato?
Un pomeriggio, seduto sulla panchina, mi hai dato il nostro primo bacio.
Aristide, il gelataio, ci vide, chiamò Angelina, la moglie, la cinse con il braccio e la baciò. Si voltò a guardarti e disse: così si fa!
In quell'istante abbiamo sognato entrambi di vivere d'amore e di gelati per tutta la vita.
THELONIOUS MONK O DI COME SMISI DI AVERE PAURA DEL JAZZ
di Igor Ebuli Poletti
Era già sera molto avanzata, le sere avanzano senza che noi possiamo farci niente per diventare notti, quando il piccolo sognato corpo di Thelonious Monk che ballava seguendo una musica tutta sua che nessuno poteva ascoltare attraccò e prese possesso della mia mente, che fino a quel momento era stata sgombra e quieta. Quel giorno non era successo niente che potesse farmi solo pensare che la notte mi avrebbe portato Thelonious Monk in sogno, io mi sarei aspettato qualcosa di più semplice, una ballerina ipercinetica, una campagna assolata o con la pioggia, uno di quegli arabeschi di pensieri che di solito vengono sognati dalle persone che sognano, una mandria di trichechi e di balene, non Monk che vestito di grigio ballava su un palco illuminato. Inizialmente pensai al palco, pensando come si può pensare quando si sogna, in modo intermittente e casuale, pensai che quel palco era troppo grande per un uomo solo, e che era strano che questo uomo fosse da solo su un palco, che era ancora più strano che fosse vestito di grigio chiaro, che avesse una cravatta e che avesse in testa un colbacco. Era però un sogno nel quale stavo sognando di sognare quindi feci finta di ignorare la questione spinosa del colbacco e quella meno spinosa del completo grigio, nei sogni le spine sono stondate e si sentono meno. Quello che continuava a farmi divisare inquietudini era il ballo, questa danza solitaria che seguiva una musica che io non sentivo, ma che con ogni evidenza sentiva lui, Thelonious Monk. Girava le spalle a destra e a sinistra, alzava le mani disegnando qualcosa nell’aria, disegnare nell’aria è una attività molto complicata perché se sbagli non puoi correggerti, è già volato via tutto, muoveva il bacino come se dovesse cacciare via, allontanare con grazia indomita qualcuno o qualcosa che gli stava troppo vicino, e teneva gli occhi rivolti verso l’alto, guardava il colbacco, probabilmente, faceva molta attenzione al colbacco, sembrava più interessato al colbacco che alla musica ma io non potevo saperlo, perchè non sentivo nessuna musica, all’inizio del sogno, ma ero anche caritatevole con me stesso e con Thelonious che aveva deciso di visitarmi, e decisi di aprire bene le orecchie, per cercare di sentire quello che stava sentendo lui, e qualcosa cominciò ad arrivare, da lontano, un suono, due suoni, cinque suoni, all’inizio tenui e poi più sfolgoranti, bassi e poi alti, angolosi e strani, avvolti da una bellezza appariscente ma nascosta, nei sogni si può essere nascosti ma anche appariscenti, e cominciai, sempre nel sogno, ad elaborare un codice, una curiosa esegesi onirica che mi aiutava a capire quello che stava succedendo: quando alzava le braccia andava in alto, quando girava il bacino andava in basso, quando si spostava di lato con dei graziosi, piccoli e leziosi passetti da gufo stava per dare l’attacco a un nuovo pezzo, e andando avanti a sognare mentre Thelonious danzava divenne tutto più chiaro, quello non era un palco ma era il ponte di una nave e io mi stavo avvicinando sempre di più alla parte centrale del ponte e cominciavo a vederne le vele, che si stavano gonfiando, sempre di più, mentre la danza di Monk continuava sotto di esse e diventava quasi frenetica e la musica aumentava, di intensità e bellezza, e spingeva sempre più aria verso le vele, che erano diventate gonfie ed enormi, e le vele erano delle braccia aggiuntive a quelle che avevo visto mulinare fino a poco tempo prima, e in fondo al ponte apparve un pianoforte, aperto, dal quale si alzò un altro Monk, che mi salutò. Dopo poco mi svegliai e cominciai a ballare anch’io, senza colbacco.
MICRORACCONTI
di Alfredo Goffredi
DENTI
Stava lavando i denti quando si rese conto che qualcuno era appena sfrecciato davanti alla finestra, nel suo cortile.
Corse fuori per seguirlo.
All'altezza del bagno, scorse uno che si lavava i denti.
Stupito, tornò indietro a vedere chi fosse, ma quello stava già correndo fuori.
MINOTAURO
Ad anni di offerte, sacrifici, presunti eroi, seguirono mesi di stasi assoluta: niente frutta, fanciulle o pivelli con la loro spadine.
Ci furono settimane di ira, di smanie, di tristezza.
Il giorno in cui il Minotauro decise di uscire dal labirinto scoprì di essere rimasto solo.
RACCOLTO
Come ogni mercoledì, è giorno di raccolto.
L'uomo prende la grossa roncola dal muro e apre la porta.
I dieci si svegliano di soprassalto, nudi e legati alle sedie.
Lo guardano con terrore mentre entra nella stanza e chiude la porta.
Come ogni mercoledì, è giorno di raccolto.
TROLL
Tornando alla Capitale, Sir Reginald notò un troll sotto al ponte di Suttonford. Sguainò la spada e caricò, ma una volta scesa la riva vide che con lui c'erano sei operai.
"Il pilastro va rinforzato" lo sentì dire "e poi controllate i tiranti".
Allora girò il cavallo e ripartì.
DROIDE
Il droide gli si aggrappò saldamente alla schiena.
- Cosa?
- Autodistruzione. Avviata. Esplosione. Imminente.
I suoi occhi lampeggiavano.
- Input: sovrascrivi autodistruzione.
- Impossibile.
- Ma questo viola tutte le leggi della robotica!
- Ah! Ah! Quella. È. Fantascienza!
NONNA
- Nonna, che occhi grandi hai! - disse Cappuccetto Rosso.
- È perché, quando ero nei Ranger Imperiali, un leone mannaro mi accecò con un'artigliata. Dopo avergli fatto esplodere la gola con un pugno, chiesi ai medici di trapiantarmi i suoi occhi - rispose lei.
- Ah.
- ...
- Wow!
PULMINO
di Elisa Baldini
Della mia vita io mi ricordo per lo più della mia infanzia, che sembrerà strano visto che questa è successa prima della mia adolescenza e della mia giovinezza e, secondo una crono-logica, dovrebbe essermi più astratta e vana nell’animo. In realtà non mi ricordo tutto, ma ci sono dei quadretti che stanno come sogliole occhiute insabbiate sul fondo, e basta poggiarvisi sopra perché si riformino esatti e mi cali dentro l’uggia e lo stupore di riessere lì, col suo annesso gusto un po’ démodé. Potrei raccontare di quando all’età di sei anni feci fagotto, e avvolsi in un fazzoletto di stoffa tre pastine (tegolini mulino bianco, per la precisione) e, convinta di avere riserve per almeno un mesetto di vagabondaggi scalzi, uscii di casa, ma, visto il fallimento di questa operazione che si concluse sul marciapiede di fronte al cancello di casa, lascerò cadere la sua menzione per vantarmi di un colpo, meno trasgressivo, messo a punto qualche anno più tardi.
Ero ormai in quinta elementare, in quel periodo in cui, innegabilmente ancora bambini, si sentono i primi pruriti dell’adolescenza, ci si leva il grembiule bianco perché ci rovina il look e ci si fa bravi di fronte a quelli di prima per il solo fatto di essergli antecedenti. Ma c’era una cosa che mi teneva senza scampo legata al mondo dei minori-accompagnati, ed era il pulmino giallo della scuola che, con tutta la sua noiosa previdenza, attendeva i più proletari di noi all’uscita, quelli a cui mancava il privilegio delle mamme a casa di pomeriggio, e, a seconda di dove stavi, prima o dopo ti scaricava a destinazione. E lì sopra, che si fosse matricole o cadetti, si diventava tutti uguali, straniti dalla promiscuità dell’abbandono.
Io e la mia compagna di classe e pulmino Samantha Calcaterra (in realtà ci univa più l’esperienza del pulmino, frustrante oltremisura, che quella della classe) avevamo deciso, non so bene come e quando, che era proprio il caso di dimostrare a tutti che quel pulmino giallo lì si poteva anche perdere. È un concetto che, ripensandoci col suggello degli anni, mal si adatta al pulmino della scuola, visto che costui, traslato nella figura dell’autista, aspetta fino all’ultimo che i soliti noti raggiungano le loro scombinate postazioni, prima di darsi per vinto e iniziare il circuito giornaliero. Ma c’è sempre la scappatoia più tipica delle scappatoie: darsi per malati, e fu contando su questa intuizione tacita che io e la mia compagna Samatha Calcaterra rimanemmo nell’atrio della scuola, occhieggiando dal portone incaute e saltellanti, il giorno che decidemmo di perdere il pulmino. E il pulmino caracollò via, dopo un lasso di tempo allungato dallo spasimo, e mi sembra di rivedere il suo culone giallo e riavvertire l’ebbrezza mitica, il balzo all’ugola, il senso di vuoto e libertà e il brivido che m’arpeggiò tra le costole, che mi rese informicolita come un piede sotto il sedere. E fu quasi spaventoso rendersi conto che nessuna di noi due aveva preso minimamente in considerazione il fatto che il mondo non sarebbe finito, che il tempo non si sarebbe fermato, ma che puntuale come la campanella ci sarebbe stato un dopo aver perso il pulmino. Ma è ovvio: è come se il suicida prima di schiantarsi giù dal viadotto pensasse a cosa lo aspetta, dopo morto: pensa che finisce tutto, e basta. Ma qui siamo in un roseo racconto d’infanzia, che deve continuare, e io e la mia amica Samantha Calcaterra ci guardammo basite e mi piace pensare che il rifrullo della coscienza ci abbia colpite nello stesso istante, che il pensiero della nonna con la merenda sul tavolo sia stato biunivoco come il brusio della rivolta che avevamo covato insieme, sopra al pulmino, ogni pomeriggio dopo le quattro.
Ho sempre avuto una buona dose di senso pratico, e lo scoprii quel giorno, quando dissi alla mia amica che saremmo andate a piedi, che tanto la casa di mia nonna era dopo poco, dietro la curva, in fondo alla discesa, e che ci saremmo arrivate in cinque minuti, 'gnamo. Ebbe fiducia e mi seguì ma, dietro la curva, la strada si stendeva lesta e non c’erano case delle nonne con la merenda sul tavolo in vista. Mi ricordai che c’era almeno un’altra curva prima di arrivare, o forse due, e Samantha Calcaterra titubava sempre più, correndo (perché correvamo, con la cartella abnorme che ci fracassava, ad ogni calcio nell’aria, la schiena) e guardava dietro di sé la curva che s’allontanava e me che le dicevo “manca poco”, mentendo per necessità supplicante. Il pomeriggio era mite, era quasi estate, ma fu un momento come un altro per capire una delle verità più acute dell’amicizia provvisoria come quella dei pulmini, e cioè che bisogna essere in due per avere il coraggio di perderlo, ma che dallo sgomento della perdita ci si salva da soli. Fu un attimo, e Samantha Calcaterra disse “è troppo lontano, casa mia è dall’altra parte” e già la traiettoria era invertita, il frusciare dei suoi capelli nocciola deviato di spalle. Io dovevo andare avanti, anche se la sua defezione m’aveva increspato le labbra, ma non c’era tempo per concentrarsi in un pianto, seppur consolatorio. Continuai a correre, mentre potevo avvertire la consistenza plastica del mio stomaco che si contraeva, il nodo alla gola colloso che diventava più risoluto. Solo allora mi schiaffeggiò l’ampiezza abominevole degli spazi che avevo intorno: i campi granulosi, la strada grigia bianco-nastrata, le macchine in corsa nella loro velocità da ultimo decennio del secolo; mi acchiappò il panico e fu brusco l’attrito, ricordo, ma eccitato, anche. Durò poco, perché una macchina si fermò e alla guida c’era la mamma di Marco Bini, compagno di classe, bionda riccioluta e stopposa, con la bocca spalancata e gli occhi spippati e:
“Cosa ci fai Elisa da sola per strada?”
“Ho perso il pulmino.”
E suonava strano e Marco Bini spuntava dai sedili posteriori con un sorriso mezzo e strafottente, del tipo “ti s’è beccato, scema.” Il tragitto mi sembrò lunghissimo e fu silenzioso, di quel silenzio consapevole in cui tutti sanno ma nessuno commenta, guai. Dopo una curva c’era davvero la casa della nonna e io scesi, e la mamma di Marco Bini ebbe la discrezione di ripartire subito, lasciatami davanti alla porta. Mia nonna mi credette tornata col pulmino, un po’ in anticipo, ma può capitare. La merenda era buona come tutti i giorni: panino al prosciutto crudo ed estathé, e c’era anche Non è la rai mentre me l’ingurgitavo. Questo bastò a farmi dimenticare il tutto come un siero miracoloso. La nonna m’accompagnò come sempre a pattinaggio: prendemmo l’autobus. Dopo poco ero a sfrecciare dotata di ruote, immemore e felice.
Mi ritornò in mente la faccia tonda della mia amica Samantha Calcaterra solo quando vidi quella aguzza d’ansia di sua madre ed ebbi come un lapsus al contrario, e già mi incalzava con:
“Elisa, sapevo che eri qui! Ma la Samantha non ha preso il pulmino con te, oggi? Non è tornata a casa! Ma dov’è? ”
“S’è perso il pulmino.”
E suonava storto, il cappio della colpa mi s’annodò e, in due minuti, da pattinatrice indomita ero sopravvissuta clandestina. E spia, per lo più. Raccontai tutto, sua madre se ne andò e io non avevo più voglia di pattinare. Mi prese un fastidio sordo che mi passò solo quando seppi, telefonando la sera, che la Samantha s’era trovata a casa della Martina Tredici in fondo alla discesa della scuola e il misfatto, a parte un ceffone, non aveva avuto altre conseguenze.
Io mi credetti scampata fin dall’inizio a ire parentali, confidando non so come nella discrezione delle mamme altrui. Ma, col senno di poi, mi rimprovero di non aver capito subito che il filo della responsabilità familiare rende tutti associati. Qualcuno lo disse al mio babbo, che però m’accennò solo all’evento, facendomi sapere che sapeva, e questa acquiescenza lieve mi parve ancora più sospetta. Prospettai punizioni future e provvedimenti da processo dell’Inquisizione, dileggi pubblici davanti a cento Marco Bini mezzo-sorridenti, ghignanti direi, ma fu un pensiero fugace, capitolò tra gli eventi: non ho mai pagato niente per quel pulmino perso, a oggi.
STARS
di Marco Galli
Su il sipario.
Siryl! Si chiamava Siryl. Era una donna bellissima, un’attrice. Che entrasse in
una stanza o passeggiasse in qualsiasi punto della terra, il mondo si fermava a
guardarla, come in una ripresa al rallentatore. Era davvero impossibile non
soffermarsi sulla sua bellezza, che non era per nulla artificiosa, ma anzi solare,
con quella sottile ombra di “tocco del demonio”: lo sguardo era nero e
penetrante, le forme di carne liscia e rotonda, ogni parte fremente e irresistibile.
Tutti volevano recitare e flirtare con Siryl, soprattutto quei giovani attori che
speravano in una scena d’amore con lei: non potendo entrare nel suo cuore, si
accontentavano di appoggiarsi sulle sue labbra e di sfiorarne le forme perfette, pur sapendola finzione. Però, Siryl, aveva un segreto. Un maledetto segreto,che si manifestava solo con lo starle vicino: il demonio l’aveva toccata in ogni parte e, fedele alla sua natura, oltre a darle dono di una bellezza folgorante leaveva dato anche un alito pestilenziale!
A un metro da lei già si iniziava a sentire un fetore pungente, a mezzo metro ci
si domandava chi era morto e a pochi centimetri il morto era chi le stava di
fronte. Non c’erano rimedi, ne chimici, ne naturali: spray, mentine, collutorio;
nulla funzionava. Con il demonio non si scherza. All’inizio molti, i più resistenti, facevano finta di nulla, finché era possibile; d’altronde alla perfezione di una bellezza divina si concede più di un’indulgenza, ma poi, anche i più innamorati o le più incantate, cedevano vergognandosi di rinunciare alla fortuna di essere arrivati fin lì, a quei pochi centimetri dalla gloria!
Raramente ho visto un tale spreco, disse un produttore navigato. Come
capirete la sua carriera d’attrice durò il tempo di un lampo, ma la sua storia non finì male, anzi: terminò con il classico lieto fine. Su un set, in verità l’unico set che calcò nella sua avventura da attrice, conobbe un famoso regista. Non era il regista del film: quella pellicola a cui partecipava come coprotagonista era una commediola sentimentale di poco valore; ma il “famoso regista” venne in visita, invitato dall’amico produttore. Sta di fatto che, nel disorientamento della troupe che non capiva come quel “maestro” abituato ad avere ogni sorta di starlette ai suoi piedi potesse flirtare così da vicino con Siryl, la loro relazione prese avvio.
Si sposarono da lì a poco e la relazione, con alti e bassi – si sa come sono i
registi – durò per molti anni. Il perché è presto detto. Si fecero molte congetture su un probabile difetto di olfatto dell’artista, ma in verità, fonti certe, che lo conoscevano bene, confermarono che il regista era uno di quelli con “la puzza sotto il naso”: quelli famosi per il loro intelletto e soprattutto per frequentare i salotti che contano. Certo che Siryl, per questo motivo, dovette mettersi un po’ in secondo piano, ma non le dispiaceva: era innamorata! Ebbero anche due figli e caso vuole, o forse ancora lo zampino del satanasso, uno era muto.
Naturalmente rinunciarono alla vita mondana, anche se pare che adesso, in
questi giorni di mascherine e distanza, si senta più tranquilla e abbia ripreso
quel poco di vita sociale che è concessa a tutti noi.
Giù il sipario.
NASTRO
di Marco Galli
Su il sipario.
Non sopporto molto i riti, se non hanno natura mistica. Tipo quella cosa del
caffè al bar fatto in un certo modo se no non sei italiano e che diavolo lo bevi a
fare se non lo sei? Intanto me lo bevo come voglio io il caffè, che son
maggiorenne e poi manco è tutta sta roba. Pensate pure che ci sia qualcosa diimportante dietro o addirittura qualcosa che vi distingue come popolo. Non stavo
più parlando (solo) di caffè.
Anassimandro diceva, pressapoco, che tutto è fatto di cose limitate, ma se le
cose limitate continuano, nascono e poi muoiono, senza interrompere mai il
ciclo, se da un positivo si stacca un negativo che si attacca a un nuovo positivo, si ha il divenire perpetuo, cioè l’eternità. Almeno così l’ho capito io. Non so se è giusto, ma mi pare affascinante che ogni cosa nasca dalla fine di un’altra e che tutto sia continuo. Bisogna accettare che il nostro è solo un eco che rimbalza all’infinito.
Sono mediamente simpatico, credo. Di sicuro non sono un mattatore. Qualche
volta, se sono a mio agio, mi viene qualche battuta buona. Forse è la natura
bresciana, sempre un po’ schiva. Oggi sono tutti simpatici, molto, troppo! Non
parlo di questioni precise, dico nella normalità quotidiana. Non lo sopporto più: troppa simpatia fa rima con gigionerìa e diventa asfissiante. Si usa l’ossimoro: “Ti do un cazzottone di fiorellini”. Anni fa, avevo vent’anni circa, uno mi dice: “Togli la mano di lì! Ti taglio la gola e ci cago dentro!”... Era un amico e si trattava di cosa futile.
Tanta passione per la natura e amore per gli animali, mi si presentava una
volta una ragazza. Diceva che gli animali, e la natura, sono migliori degli uomini. Io le dissi che “migliore”, o il suo contrario “peggiore”, sono giudizi dati dall’etica o comunque dalla coscienza e che la natura, e a quanto pare nemmeno gli animali, o almeno la maggior parte di loro, la coscienza non ce l’anno; dunque gli animali, e la natura, non possono essere ne migliori ne peggiori degli uomini.
Non ci vedemmo più molto spesso.
Ritorna il problema “simpatici piacioni”. Guardo fra i colleghi farsi i complimenti, sempre, manco fossimo tutti dei geni bravissimi, comunque, uno dice all’altro: “Mi è caduta la mascella” per sottolineare la bellezza del disegno dell’amico. Ma che complimento è? Se ti cade la mascella è una tragedia! Ed è pure colpa mia!
Perché non tornare a dire “bello”, o aggettivi simili? Ho anche deciso che userò il cuoricino solo per le femmine e il pollicione solo per i maschi.
Odio i delatori, a meno che non si tratti di crimini gravi, ma quelli si chiamano
testimoni e sono doverosi. Girando per il mio paesello ho visto gente, di tutte le età compresi i vecchi, fuori dai bar a fare l’aperitivo: mascherato, un po’ di
nascosto, ma comunque aperitivo. Io ci vivo nel bar, il bancone mi saluta quando mi siedo e non mi interessa farvi sapere se per me sia stupido farlo con l’emergenza ancora in corso, però mi da da pensare il fatto che siamo una
società basata sull’aperitivo. Il vero segno della libertà personale: l’aperitivo! Ci
sono dei dementi che parlano di “guerra”, di “gente alla fame”, fuori da un bar,
con il bere camuffato e lo sguardo complice, urlano “me ne frego!” E poi si
lamentano che lo stato non fa nulla.
Giù il sipario.
CAMPISANTI
di Donato Novellini
Don Enos, pretone grande e grosso, giunto trafelato in bicicletta s’attacca al campanello con modi spicci da curato di campagna quale è, il dito grassoccio pigiato sul pulsante e l’altra mano a menar pacche gagliarde sul legno della porta di casa: driiiiin e toc toc toc e sbam sbam, “aprite è urgente! È morto il vecchio maestro” baccaglia all’uscio. Primo pomeriggio tetraggine padana, eterno ritorno del buio precoce, doppio velato grigio il corso principale là fuori, osservato dalla condensa interna della cucina; gocce colanti della finestra, cornice lignea marcita d’umido, gommapiuma zuppa negli interstizi. Umidificatori in ceramica, dipinti a mano con su i girasoli, agganciati a termosifoni beige, torpore quaderni a righe matite colorate, quiete di merendine marca Balconi, il minestrone per la cena sul fuoco, odore di legumi che pervade la stanza, alla tivù danno cartoni animati giapponesi, robot volanti. “Vecchio maestro?” Guardo fuori dall’imposta, mettendomi cavalcioni sulla sedia e scorgendo solo un lembo di stoffa nera mi domando che potrà mai essere di così urgente. Suona ancora in sovrapposizione, campana da morto in paese e contemporaneamente il campanello alla porta, riverbero di cornacchia, difatti si tratta di un funerale a metà settimana, gelido fine novembre del 1983; storpio letargo generalizzato dei parrocchiani, vecchi rinserrati nei rispettivi focolari, fanciulli con la febbre influenza collettiva, figli di madri apprensive e conseguente esigenza liturgica di recuperare al volo almeno due chierichetti in buona salute, volontari dalle guance rosee per la mesta funzione. Uno pigliato a casa sono certamente io, vittima predestinata, putto decenne debitore dei passatempi d’oratorio: quelli infatti, con la scusa del calcetto e delle biondine con gli occhi blu ti fanno prigioniero fin da piccolo, educato vezzeggiato a ceffoni e confessato, per poi magari sacrificarti sull’altare diaconale quale bianca pecorella da immolare in seminario; difatti il prete sa bene dove bussare, chiromante d’interni privati, spia melliflua, detective degli animi avvolto in mantello pece persevera al civico 49 certo di trovare qui il suo ubbidiente servo. Accolto in salotto con le piccole cerimonie destinate alle autorità locali - caffè canestrelli con zucchero a velo, offerta per la parrocchia in cambio del ciclostilato Il Mantello, sorta di bollettino evangelico – il sacerdote ruffiano si spende in frettolose bonomie, quindi fissandomi mentre resto né di qua né di là, impalato a spiare dalla porta socchiusa, mette nell’occhiata una diabolica sfumatura d’intesa. Meglio i funerali con mancia – anche diecimila lire se va bene - dei compiti di matematica, penso, mentre l’accondiscendente madre m’infagotta in un paltò troppo largo appartenuto a un cugino benestante ormai cresciuto. O deceduto? Lasciti fuori moda, scozzeserie di flanella e flosci berretti in tartan, rigidi cenci all’attaccapanni, equipaggiamenti infeltriti provenienti da chissà quale cassapanca puzzolente di naftalina a cubetti; mi sento goffo, occhiali da vista montatura a goccia, primi brufoli, turgori inopportuni riconducibili a segreti giornaletti ficcati sotto il letto e per penitenza rigidi mocassini violacei che mi squartano i piedi. Vesciche, vergogne – perché i miei amici hanno tutti le scarpe da ginnastica dell’Adidas, mentre io sembro un pastorello in attesa del presepio - e obbedienti silenzi. Mi lascio infagottare pur di uscire da quel collegio da primogenito, imbragato di velluti a larghe coste, guanti e cuffia rossa di lana con pon-pon. Mi accompagna Rita, anch’essa recluta funebre, ufficialmente almeno per l’Inps materassaia in pensione, in realtà violinista pianista organista fisarmonicista autodidatta dall’orecchio assoluto, zitella Beethoven coi capelli fulvi che in casa m’hanno abituato a chiamare zia. Pur non essendoci parentela, vive da sempre appollaiata in famiglia coi suoi gatti guerci. Siamo nati lo stesso giorno, 45 anni di differenza; lei ha poca pazienza, talvolta manesca forse ascendente Capricorno, soventi scappellotti mentre io cresco nell’indolenza come l’ennesimo idiota del luogo. Fuori dall’uscio una folata d’aria gelida proveniente da qualche siberia lontana fende la nebbia argentata punzecchiandomi il volto, passi forzati a testa bassa d’un piccolo lord demodé, utili per diagnosticare scrupolosamente piaghe di marciapiedi e metafisica sotterranea dei tombini, griglie di ghisa firmate dalla fonderia tal dei tali, il buio mefitico delle fognature, gli scoli dove immagino viaggi tra i topi giganti la merda dei bravi cittadini; a un certo punto del tragitto, che conosco a memoria, c’è una moneta verdognola conficcata nel cemento, Vittorio Emanuele III, accanto ad un rattoppo che assomiglia alla forma geografica dell’Italia ma con la Sicilia a destra. Vabbè, ad est. Più in là ferri di cavallo cementati in prossimità della casa dove un tempo stava il maniscalco, proprio accanto alla macelleria equina gestita dal fratello superstite: un omino silenzioso quello, tutto bianco, capelli colorito epidermico e grembiale cerato ma con schizzi di sangue, gambali di gomma. Intrecci di crini, utilitarismo di carcasse gocciolanti, forse si sposano ancora tra cugini qui per fare viaggiare gli affari tenendo così il capitale in famiglia, d’altronde è risaputo che la persistente intimità col sangue animale rende folli. Non mi va d’alzare lo sguardo, nulla da vedere nel cinereo orizzonte, meglio il suolo con le sue mappe immaginarie: elucubrazioni cartografiche adattate ai guasti della pavimentazione, cunette dove stagnano pozze d’acqua sporca nelle quali scorgo rassomiglianze ghiacciate con animali e persone, minuscole trasfigurazioni di pezze di bitume destinate a imprimersi nella memoria ben più delle cartine geografiche a brandelli osservate distrattamente a scuola, sovrapposizioni a ritroso nei calpestii di quando era piccolo mio padre, mio nonno, il bisnonno, di quando pedone era un altro, marmocchio dell’800.
Laggiù a metà del paese c’è la chiesa, romanico rimaneggiato fatto di nudi mattoni arancioni, casermone di frati divenuto col tempo presidio di spossati catechisti, comunicatori all’oggi vieppiù progressisti invasati di francescanesimo, apprendisti missionari in sandali di cuoio anche d’inverno e damine pallide con le scarpe da tennis, laiche emulatrici di sante. La domenica a messa, accompagnati dalle chitarre, cantano enfaticamente quella canzone di Bob Dylan: “Quando dal mare un’onda verrà che i monti lavare potrà? Quante volte un uomo dovrà litigar sapendo che è inutile odiar? E poi quante persone dovranno morir perché siano troppe a morir? Risposta non c’è o forse chi lo sa, caduta nel vento sarà”. Le vecchie con gli scialli in testa scuotono il capo in segno di disapprovazione, mentre a noi giovinetti degli anni ‘80 abituati al pop elettronico del jukebox annoia sufficientemente tale nenia: per stare al passo con le mode, quelli della parrocchia, dovrebbero passare agli altoparlanti i dischi dei Depeche Mode, mica quelle solfe cantautorali del decennio precedente. Oppure, a mio avviso, tornare risolutamente al latino, che non conosco, così si resta ignoranti al cospetto di Dio e del mondo. Don Enos – demagogo, finto tonto molto amato dalle persone semplici - per assecondare lo spirito del tempo ha rivoluzionato l’impianto interno della chiesa, spostando l’altare maggiore dall’abside, rialzata di tre gradini, al lato ribassato sinistro della navata posizionando di conseguenza le panche a semicerchio. “Per tornare allo spirito comunitario dei primi cristiani”, sostiene assieme al suo seguito di sincretisti capelloni. Mia nonna invece ritiene che l’operazione di svuotamento del catino absidale sia stata un atto sacrilego, “una porcheria!”, i pochi fedeli conservatori la pensano come lei, agli altri poco importa, d’altronde come dicono in casa questo è sempre stato un paese di comunisti, di gretti materialisti.
Giunti davanti alla chiesa Rita mi lascia per accomodarsi all’organo per le prove. Oltre la porticina sul retro della sagrestia, dopo un attimo d’ombra muffosa si manifesta tutto il vecchio potere scenografico, polveroso dietro le quinte del dismesso teatro di Cristo: dorati lacerti tarlati, suppellettili barocche impolverate, smobilitate pale d’altare – Santa Cecilia geme all’organo ferita da tagli spazialisti -, cornici rosicchiate dai topi, ragnatele, accumuli d’aspersori turiboli e acquasantiere crepate ori incensi e mirre, fallici reperti anneriti paraffina d’antica fabbriceria, corrosi angioletti mani giunte, croci in mogano lacrimanti sangue da mani e piedi. Sacro cuore ricamato sulla porpora e spine conficcate nella carne, erotismo cremisi affumicato, accatastato, segregato. Sacre macellerie obsolete, serpi schiacciate da bianchi piedini, emorragie di rose mistiche che torneranno utili quando svanirà l’incantesimo pauperista, il menabò minimalista e alquanto didattico del Concilio Vaticano II: aggiornamento ai tempi che nel sacro tempio ha preso la forma di un pannello in moquette verde, dove affiggere con le puntine da disegno motti sociali per i poveri del mondo, sempre più lontani, sempre più africani. Se il vestibolo del prete, con quell’enorme armadio in noce scuro dove riposano i ricchi paramenti viola e verdi merlati zecchino, somiglia alla bottega del rigattiere, la camera dei chierici ricorda vagamente lo spogliatoio di una squadra di calcio, categoria dilettanti. Panche basse e grucce in fila, grigi archetti a sesto acuto, una nicchia con madonna biancazzurra di gesso - fiori finti al cospetto - spoglio sentore di cantina, freddo sotto luce fioca, lampadina penzolante da non si sa dove. Penombra e due intemperanti fanciulli in divisa, ovvero in sottana. Stefano, l’altro celebrante, s’infila tunica e cotta direttamente sopra gli abiti, borbottante lo imito in tutto e per tutto, perché è di un anno più grande e ne sono intimorito. Anche quando, approfittando della momentanea assenza del prete apre l’armadio proibito per bere il vino (vinum debet esse naturale ex genimine vitis et non corruptum) e rubare da un sacchetto di plastica una dozzina di particole: me ne porge la metà, poi si strafoga dando in blasfema escandescenza; “tanto non sono consacrate, beviamo e mangiamone tutti porco dio!” fa il figlio del messo comunale, un comunista quell’altro, suo padre, che in spregio al clero avrebbe voluto finire al camposanto accompagnato dalla banda con le marcette di partito e la bandiera rossa. Altroché “Io credo risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore! Prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci: ricordati, Signore, che l'uomo è come l'erba come il fiore ...”. Stefano viene in chiesa solo per volontà della madre, preoccupata per la sua predestinazione alla teppa. Già fuma e beve birra, fu lui a passarmi il primo giornaletto a fumetti porno.
Si parte noi due e il prete dalla falcata doppia rispetto alla nostra, in pellegrinaggio silenzioso tra case dalle facciate cadenti coi campanelli guasti e i balconi arrugginiti, piccoli vortici di foglie secche, vento freddo che innesca flebili mulinelli di cartacce offerta speciale del minimarket e pagine del gazzettino locale del giorno prima, sbriciolii d’intonaci sotto i piedi in direzione casa del morto. Il morto sta sdraiato al villaggio nuovo, quartierino di villette triangolari (scaleno, isoscele equilatero, comunque a punta), parapetto con ringhiera due galletti di cemento svettanti sui pilastri del cancello, cassetta della posta tardo-monarchica anfore etrusche levriero in porcellana fontanella granito con delfino, quadrelli di gres nel prato miniatura Biancaneve coi nani, altalena ossidata per nipoti ormai cresciuti. Un pallone da basket sgonfio cadeau del vicinato, tapparelle beige abbassate. Carro da morto parcheggiato sul marciapiede esterno, lì davanti come un pescecane spiaggiato, Mercedes oblunga specchiata pece, nero di seppia col forno aperto sulla cuccia imbottita di raso bianco, astronave presidiata da certi giannizzeri incravattati e dall’autista con occhiali scuri, oziosi corazzieri del lutto, indolenti come vecchi parastatali fuori a fumare stretti nei loro cappotti color cornacchia. Oblò di corone di fiori, “i tuoi cari”. Don Enos amico del popolo, paonazzo gigante crociato, titano in piviale e stola viola sotto la mantella nera, fende senza indugio il capannello di finti parenti ed ex scolari assiepatosi tra il giardino e l’atrio, con modi spicci e l’aura per lui innaturale dell’autorità. Schiattato come una mosca ai primi freddi il vecchio Guglielmo, scapolo, fu maestro alle scuole elementari, giace ora dinnanzi a noi disteso: epidermide ocra ravvivata dall’ombretto rosa, secco merluzzo agghindato in giacca cravatta camicia bianca sotto l’orologio a pendolo, tra quadri di paesaggi alpini con vacche al pascolo, attestati e diplomi incorniciati, filari d’enciclopedie ricamate sul dorso, accanto a una vetrinetta stracolma di bomboniere e souvenir turistici: gondole, carretti siciliani, torri di Pisa eccetera. Odore di fiori nauseante dentro la serra-salotto, camera appesantita da carta da parati rosa a fantasia di rose anticate e sproporzionato lampadario arricciato con lacrime bataviche, vapori attorno alla salma come se fosse in procinto di sciogliersi, grinze e rughe piallate dal cerone, caldo dai termosifoni al massimo, vampate sui nostri volti arrossati. Mi alzo leggermente sulle punte dei piedi al fine di scorgere meglio quel volto dalle palpebre chiuse, attratto e al contempo intimorito, incuriosito dai baffi che sembrano finti: mai visto un morto così d’appresso. Invero nemmeno pervenuto da vivo, il maestro, in società, che ne so al mercato oppure al bar, eppure somiglia a qualcuno di già visto, qualcuno morto prima. Difatti s’era rintanato, per lui il piccolo mondo paesano che snobbava era già avulso da tempo. Avulsione reciproca, nessuno lo cercava più. Banchi di legno coi buchi per inchiostri e calamai in tempi di biro, interrogazione, gessetto, cancellino in feltro a spirale, poesia imparata a memoria, il dovere d’insegnare a generazioni di zucche dure è spirato sulla lavagna, nettato via con l’ultima campanella di fine lezione. Poi venne il vuoto cosmico della pensione, vecchiaia solitaria, e a quanto ne pettegolano a bassa voce i presenti la morsa della depressione stretta ad un’esistenza già marcatamente asociale. “Assai stimato, benvoluto, conosciuto anche fuori paese, lascia i fratelli Evaristo e Giulio, gli adorati nipoti Guido, Angela con Martino, Clotilde con Giancarlo, i cari pronipoti…”. Ne danno il triste annuncio eccetera. Bisbigli in salotto ammutoliti al nostro arrivo, riusciti tentativi di contegno dei presenti, decoroso silenzio; gli intimi messisi a corona attorno al catafalco col capo chino si fanno il segno della croce, difficoltà di movimento tra paramenti e omaggi floreali al suolo – i Coscritti della classe 1902 – lumini elettrici sul tappeto persiano, mentre la fedele domestica singhiozza sommessamente, lamento ovattato che sembra provenire da un’altra dimensione o da altra stanza, come un’eco spiritata. Gli addetti alla triste pratica coprono la cassa, sigillano metallurgici la bara, tastano la resistenza delle maniglie e quindi la sollevano di peso. Rosario e poi s’esce fuori tutti, aria fredda finalmente, abbia inizio la mesta processione.
Avanti il prete pioniere col turibolo, incenso evaso nella nebbia e quel ripetitivo tuonare di gagliarde preghiere, “per Cristo nostro Signore” risponde un coro remoto, io e Stefano ai lati procediamo come equilibristi tremanti intirizziti dal freddo, con grandi candelabri dorati tra le mani, la cera che cade in gocce bollenti sulle nostre teste facendosi grumo tra i capelli; qualche passo addietro il carro funebre lento scarafaggio gigante e a seguire lo sparuto corteo, s’ode solo il rumore dei passi sfasati tra due ali di case mute e chiuse. Dietro le finestre, imposte e tende lievemente scostate, brillano però occhi scrutatori di coloro che moriranno posdomani, il giudizio del pubblico a casa: “Si c’era poca gente al funerale del maestro, peccato in fondo era un brav’uomo”, come se il successo della luttuosa celebrazione dipendesse dal numero dei presenti e dal fasto infiorato dei violacei paraventi. O paramenti. Come se poi Successo fosse la parola giusta da mettere sulla bilancia del peso sociale, conferimento d’un prestigio tribale sancito dall’ossessione per la partecipazione - Dio stramaledica quella canzone di Gaber sulla libertà! - eppure qua lo sapevano tutti che Guglielmo era diventato matto, che dava i numeri, chiuso nelle sue elucubrazioni storiografiche, etnologiche, ufologiche, alieno agli affari sempre più veloci dei tempi nuovi così come alle ottusità terragne, ancora medievali, del paese agricolo. Il maestro da tempo s’assottigliava nella criptica senilità, le squame cadenti del serpente, cavità sdentata ridotta a deglutire omogeneizzati e frullati di mele cotte, com’è di quando la bocca del rettile accoglie la coda in cerchio. Aveva fatto il suo giro terreno.
Adrenalina fanciullesca e freddo nelle ossa, perché l’attesa della celebrazione trattiene qualcosa di simile all’uscita dell’attore dai camerini, del circense diretto al trapezio, mentre il diacono secco e pallido aiuta il prete nella vestizione, pratica cerimoniosa anche quando la mesta funzione infrasettimanale vede la partecipazione di pochi fedeli. Anzi a maggior ragione, senza strimpellatori folk e coreografie animiste il rito retrocede alle consone atmosfere catacombali: freddo ancestrale, candele di cera dalle lacrimanti fiammelle tremolanti, l’organo tetro e abissale suonato da Rita annunciante il commiato terreno della salma, peste bucherellata sulle alte pareti da dove riemergono affreschi di ossa e teschi, fuliggine tra gli stucchi barocchi. Io e Stefano, dandoci di gomito, spiamo dalla fessura della sacrestia: Sono di là che aspettano gli spettatori, lontani parenti formalmente contriti, annoiati più probabilmente interessati all’eredità, del resto tra i banchi stanno sparpagliati immortali abbonati ai funerali altrui e curiosi, dopolavoristi necrofili, nullafacenti, veggenti di esequie prossime venture, vecchie donne pie tessitrici di rosari. Un fantasma della chiesa suona la campanella, così la porta del retroscena si apre da sé, spalancandosi il telo scarlatto agevola il nostro ingresso nella Casa del Signore accompagnati dalle note dell’organo sempre più grevi. Guardo a sinistra, piante grasse al cospetto di una cappella chiusa da ringhiera fatta di lance acuminate, oltre le quali si erge nera la statua di un santo sanguinante, qualcosa di verde scuro attorno, fogliame opulento tipo giardino botanico, amazzonia maggiormente consona ai matrimoni. O ai divorzi. Ai salotti dei set televisivi. Noi chierichetti ci accomodiamo ai lati dello scranno maggiore dove siede Don Enos, pasciuto guance rosse di prosciutto: silenzio studiato del parolaio. In chiesa tutto tace per un attimo breve e lunghissimo. “Preghiamo”, quindi la messa prende forma, seguendo il suo doloroso rituale. Io e Stefano ci affaccendiamo nelle operazioni di servizio, pane e vino da portare dal tabernacolo all’altare, Libro e microfono, piattini d’oro per non far cadere le ostie durante la comunione, incenso e turibolo, due alte candele da portare in giro goffamente, di qua e di là, coreografia talvolta improvvisata.
Si apre il grande portale ligneo che dà sulla strada principale del paese, tutti defluiscono oltre il sipario purpureo e così lentamente la piccola processione si dirige verso il cimitero fuori paese, distante poco più di un chilometro. Fuori dalla chiesa buio e nebbia fattasi nel frattempo più spessa, dall’alto la fioca luce biancastra dell’illuminazione pubblica, scodelle di vetro Enel, si rifrange vanamente nell’atmosfera lattiginosa, rendendo la visuale ancora più incerta, ipotetica, spettrale. Lo stradello dritto del camposanto, stretto da due filari di cipressi - nere sagome ritte senza cima messe a guardia del viatico, intagliate nella tenebra eppure percepibili nella loro regolarità tra pieni lignei e vuoti nebbiosi - termina in uno spiazzo presidiato da un solitario abete. Oltre il cancello d’ingresso, nell’evanescente tetraggine, centinaia di lucciole gialle e rosse punteggiano magicamente il perimetro cintato. Qui i sensi si acuiscono, lo scalpiccio nervoso dei presenti sulla ghiaia sembra amplificarsi, cristallizzarsi in tonalità all’orecchio metalliche, poi la preghiera del parroco bruscamente interrotta diviene riverbero gracchiante tra turgide aiuole gocciolanti e freddi vapori salenti ai lati. Fine della parola consolatoria ripetuta a memoria e subito dopo parte il sibilo stridulo del microfono portatile, interferenza elettromagnetica che si perde nei paraggi, eco dispersa tra i bui campi di barbabietole del circondario. Varcata la soglia, oltre qualche sbilenca croce arrugginita, ficcata direttamente nel terreno a testimonianza di sepolture antiche in fase di dissotterramento, si ergono gli imponenti mausolei moderni – torri rotonde o cuboidali, razionaliste architetture di marmo nero rosa avorio, fortilizi dalle porte vetrate serigrafate con piccole croci d’oro - piramidi, palazzine/sarcofago vanto delle famiglie arricchitesi nel dopoguerra, le altre invece di più antico lignaggio sono collocate in cappelle appuntite, si direbbe di gusto gotico, più discretamente lungo il perimetro cimiteriale.
Il catafalco in ferro battuto sta in una zona franca oltre l’ingresso, di fronte al camminamento centrale che fende le campiture di lapidi a destra e a manca. Cala il freddo, ancora più pungente nella foschia. Ci si raccoglie attorno alla cassa di legno lucidata a modo, caramellata miele, tanto da sembrare un pasticcino oppure un accessorio da salotto, mentre il prete asperge e, di quei venti o trenta partiti dalla chiesa ora ridotti a cinque, resta lo sparuto biascicare di preghiere incomprensibili; sì, effettivamente è molto meno il pubblico giunto a destinazione, blandamente sofferente al cospetto della cara salma; forse qualcuno s’è perso nel buio, pigra deviazione per un caffè al calduccio del bar, aperitivo strategico, il tal pronipote probabilmente aveva altro da fare e se n’è tornato in città con la sua mediocre autovettura da impiegato bancario. Stando all’orologio è ancora pomeriggio, pur tuttavia indistinguibile dalla notte incombente, tenebre fumose, angeli di granito corrosi dalle intemperie e ricoperti di muschio svettano oscuri tra basse lapidi screpolate, lugubri aie cinte da catenelle annerite e fissate a cippi, negli ovali istoriati metallo ossidato foto di baffuti contadini col cappello in testa, taluni addirittura morti nel secolo scorso. Eredi di longobardi, cimbri, selvaggi coperti di pellami divenuti nel tempo latifondisti con la tuba in capo e l’orologio da taschino, commendatori cavalieri del lavoro, padroni di molte vacche e campi, con lo schioppo difensori di casolari, asini poi trattori a vapore, cani da guardia, d’inverno squartamento maiali, galline uova, vino con zucchero. Accanto riposano le devote mogli, macchine da cucire Singer, guarda questa ad esempio: antichissima, capelli elettrici covi di ragni raccolti malamente in chignon, rughe profonde segnate col carbone, lo sguardo fisso e nero, incredulo al cospetto del rudimentale apparecchio fotografico. Volti che sembrano impastati di terra velati fuliggine, umanità d’altra materia, pelle fieno e letame, golem. Mentre la bara del maestro viene portata nella cappella di famiglia, attratto da fuochi fatui e dal tintinnio di una campanella in lontananza mi divincolo, prendendo un corridoio sul lato sinistro, tra lastre sempre più strette e alti cippi dalle incisioni smussate, nomi quasi illeggibili, crisantemi appassiti lumini fiochi, croci dritte e storte d’ogni foggia. Sensazione di smarrimento accentuata dalla sempre più fitta bruma, frenesia esplorativa che si trasforma in inebetito spavento una volta giunto al termine del percorso, precisamente dalla parte opposta all’ingresso: posta a lato di un lungo loggiato gotico di pietra rossa si erge monolitica una bianca statua mariana, enorme incombente abbacinante in quanto illuminata da sotto con un potente faretto che ne altera l’espressione e le reali dimensioni. Posizionata su un basamento di cemento la scultura moderna mi scruta severamente dall’alto, mostrando più dappresso il piede nudo sotto la caduta di rigide vesti; ne resto profondamente inquietato. Similmente alla precedente visione del volto del maestro defunto, provo quel morboso, contraddittorio, desiderio di scrutare avvicinandomi ulteriormente, e al contempo di coprirmi gli occhi con le mani fuggendo via. Indugio nel quartiere dei morti. Persa la cognizione del tempo oltre a quella dello spazio, mi rendo conto d’essermi attardato più del lecito, tant’è che laggiù rumori lontani di chiavistelli e un ovattato chiacchiericcio al commiato mi ridestano dalla visione paralizzante della Vergine. Così prendo a correre, istintivamente nella direzione opposta, guadagnando il decumano filo via come una lepre tra piatte geometrie marmoree e siepi, infine giungendo al cancello ansimante e con la tunica lercia di fanghiglia mi rendo conto d’essere rimasto chiuso dentro. Terrorizzato, dopo aver sbattuto con forza ma vanamente il cancello in ferro battuto serrato, infreddolito sotto l’illuminazione smorta del grande lucernario appeso al soffitto dell’ingresso, altro non posso fare che gridare, versi tipo oh, frammisti a scomposte richieste d’aiuto: “C’è nessuno là fuori? Aprite!” dopo alcuni secondi sento lo scricchiolio della ghiaia, una bicicletta avvicinarsi alla chetichella, ne scorgo a stento il fanale giallastro ondeggiare fra le tenebre dei doppi cipressi. “Pensavo fossero usciti tutti, fila a casa marmocchio che è tardi”, bofonchia il burbero custode tornato sui suoi passi, armeggiando con un mazzo di chiavi. Fattomi uscire in modi spiccio il baffuto vegliardo mi scruta con bonaria severità lasciando andare un mugugno di rimprovero; per tutta risposta alzo lo sguardo penitente e, stupendomene, m’imbatto in una somiglianza fisiognomica impressionante, ma si certo quella col maestro defunto, sono proprio uguali. Uno spettro? Di già risorto? Allucinazione? Autosuggestione. Anticipando congetture e domande che la timidezza mi cuce in bocca, il custode tira fuori una banconota da diecimila lire dal borsello e me la porge: “Grazie per il tuo servizio di oggi, anche se non ci parlavamo più da anni era pur sempre mio fratello”.
IL PELO OLISTICO
di Alan Poloni
Emilio aveva sto peletto sul naso che gli piaceva tanto, anzi, a voler essere più precisi, gli rendeva la vita migliore. Risalendo il dorso dal lobulo, la cosiddetta punta, più o meno a metà crinale, appena a sinistra, spuntava uno di quei peli che si sentono ma non si vedono. Accarezzarselo gli dava una sensazione di pace che lo rimportava all’infanzia, possibilmente l’infanzia di un altro, perché la sua non era stata granché. L’infanzia degli altri doveva essere stata questo bel peletto da lisciare nei momenti difficili.
Quando era a casa, ma anche in giro, in faccende affaccendato o in faccende non affaccendato, e gli saltava addosso quel nonsoché di malinconico o quel pochetto di inquietudine, gli bastava una sfioratina con l’indice e tutto passava. La vita è difficile, sentenziava, ma una toccatina al peletto mette tutto a posto. Un miracolo.
Un giorno, proprio nel bel mezzo di un momento voluttuoso, si accorse che il pelo doveva essersi allungato: prima, infatti, pungeva solamente, ora si fletteva proprio. Quanto si notava, adesso? Emilio si mise lì, facendo convergere le pupille verso il bulbo pilifero fino ad incrociare gli occhi, e lo vide: effettivamente era proprio lunghetto, nero e lunghetto. Andò in bagno e si specchiò per vederlo meglio: eccola lì, la fonte del suo inesauribile piacere! Non che si vedesse poi così bene, eh… diciamo che… da una certa angolazione… e con una certa luce…
Da quel giorno si sforzò di capire se gli altri lo notassero: in ufficio, in mensa, nel bel mezzo di una discussione, fissava con attenzione le persone intorno a lui, avvicinandosi a loro il più possibile, quasi vis à vis, e si inclinava lievemente per mettere controluce il pelo, quasi porgendolo allo sguardo altrui. Ed effettivamente qualcuno lo notava, lo si capiva dal lieve ribrezzo che si leggeva negli occhi, ma erano più quelli che non ci facevano caso. Era un mondo di distratti, ma ad ogni buon conto, di fronte a quella presenza sempre più visibile, cominciò a prendere in considerazione l’idea di tagliarselo. Ma dentro di sé era molto combattuto: in fin dei conti che importanza poteva avere il lato estetico, raffrontato al benessere che gli derivava tenendoselo? Era un pelo olistico! Che poi, come avrebbe potuto riabituarsi a farne senza? No: senza quel pelo la sua vita sarebbe diventata un cielo sovraccarico di elettricità. Il pelo era l’albero in mezzo alla radura, e il suo indice il fulmine.
Ma alla fine prevalse l’estetica: stava cominciando ad uscire con una donna, una vedova con un’attenzione maniacale per l’aspetto fisico, una di quelle signore di mezza età che scialacquano in creme rigeneranti e trattamenti anti-aging tre quarti della reversibilità: di certo avrebbe notato il pelo, provandone ripugnanza, e siccome poteva anche essere l’ultima occasione femminile che gli capitava, Emilio si disse che non c’erano alternative. Così, proprio durante un momento di intimità pilifera, staccò risolutamente il dito dal naso, andò in bagno e se lo rasò.
Pur sapendo che nulla di definitivo era stato compiuto e che il pelo sarebbe ricresciuto, Emilio cadde nello sconforto, in una specie di torpore esistenziale mai provato prima. Si mise in mutua e per diversi giorni, è proprio il caso di dirlo, non mise il naso fuori di casa. Annullò persino un appuntamento con la vedova, che reputava responsabile dell’accaduto.
Poi, il terzo o quarto giorno, decise di farsi una passeggiata al parco sotto casa. Mentre se ne stava seduto su una panchina, vide un bimbo adagiato nella sabbiera. Altri bambini intorno a lui erano tutti presi dai giochi, indaffarati con formine e piccole escavatrici, chi litigava, chi piagnucolava, come dire, tutti trascinati dal vortice della vita, mentre lui, il bambino su cui Emilio aveva fermato lo sguardo, il piccolo budda della sabbiera, se ne stava solitario, placido e pacifico con un dito nel naso, incurante di tutto quello che gli succedeva intorno, a scavare e ravanare con intenso piacere olistico. A quella visione, un sorriso eloquente ravvivò il volto di Emilio: si alzò dalla panchina e si diresse verso casa pregustando il piacere.
IL RAGAZZO
di Vincenzo Trama
Per me non fa differenza. Basta un po’ di sole, una panchina, due o tre amici, poi il pomeriggio fa da sé. Sì, a volte viene Gloria coi suoi occhi di giada e ci imbambola un po’ tutti, ma è giusto. Possiamo anche smetterla di fare gli idioti, passarci un paio di svuotini e fare finta di essere seri, se tramonta. Sai, quelle cose tipo guardare l’orizzonte, stare zitti e “godersi il momento”. Quando ce lo dice Gloria ci crediamo davvero, come se con lei anche questa periferia di cemento e merda fosse solo un brutto disegno su cui scarabocchiare fiorellini coi pastelli a cera. Pure Carlo, che suo padre non l’ha mai visto, accenna a un sorriso sghembo e sembra credere di avere un futuro, forse lontano da qui. Io magari spezzo l’atmosfera con lo skate, provando qualche trick, ma tutti mi dicono di smetterla: c’è Gloria e bisogna ammutolire, fare pratica di bellezza quando questa arriva, che per gente come noi non è mai scontata.
Hanno ragione, solo che sono così stordito dal midwest emo che per me lei è solo uno scream appena diverso da quello che ho nelle cuffie; mi piace la musica, scappo da qui con lei appena posso, così. Certe mattine esco di casa che la nebbia è una densa cuticola di bagnato che ti entra sottopelle passandoti dalle palpebre: quando chiudi gli occhi la senti che ti dà il buongiorno, umida e gravida. Allora accendo il walkman e le canzoni mi scaldano un po’, assieme alla prima sigaretta della giornata; non ho trovato ancora momento migliore per fumare, finora. Alla fermata del mezzo spesso trovo gli altri, raramente Gloria. Anche lei ascolta qualcosa, gli occhi socchiusi e la testa appoggiata al palo degli orari; non gliel’ho detto mai, ma per me lei è più bella così che quando finge di salvare il paese nei pomeriggi di fine aprile. E anche la periferia mi sembra più bella così, o forse solo più autentica. Con questo perenne odore di ferro e pioggia addosso, le risaie percorse dai binari come un’appendicite curata male, i lampioni fiochi che non hanno idea di cosa dovrebbero illuminare, gli occhi acquosi di quelli come noi, anfibi coi Dc. Martens finti, le campane a morto fra questi finti viventi, la città come miraggio lontano e ubriaco.
«Che cielo» ci dice Gloria scrutando il sole sparire dietro l’ultimo quarto di orizzonte, stasera. Paolo le ha passato lo svuotino, forse più tardi si baceranno. Io sorrido, pensando che è il solito cielo del cazzo. E mi allontano, sfilando il piede sopra la tavola. Perché ho 16 anni ma di parole ne ho già sentite troppe. E se anche capisco Gloria, che vorrebbe tingere di rosa anche la sua stessa merda, e se anche capisco i miei amici, che da qualche parte si devono pure aggrappare, foss’anche alle sottane di Gloria, devo pure capire me stesso: che non mi frega niente di dire quanto qui sia bello, fra anime di cemento e speranze nate morte.
Vi siete mai resi conto di quanto siate stati criminali, voialtri?
A PESCA
di Cristina Pasqua
L’aria si infilava tra i raggi della bicicletta e tra fili d’erba di capelli. Sentivo il sellino sobbalzare, il manubrio saldo tra le mani, il freno di dietro pronto a essere tirato, la breccetta che crepitava e polvere e moschini e odore d’estate che si rincorrevano nell’aria ferma.
«Gira qua, Storpio! Infilati dentro a quella fratta.»
«Solito posto?» avevo strillato io tirando la ‘o’ e un poco di freno. Solo allora mi ero accorto di avere la bocca arida come i campi di erba medica che ci sfilavano di lato.
«No, Storpio. Oggi niente pesci gatto. Ti porto dai cavedani. Ho trovato un posto.»
Spreco avrà avuto sedici anni. Lo chiamavano così perché non era stato buono neanche a finire la scuola media, anche se tutti lo portavano in palmo di mano. Era scaltro, furbo, ma iniziava e non concludeva mai nulla, e proprio quell’estate aveva mollato il cantiere dove suo padre a fatica era riuscito a piazzarlo per una stagione.
Io ero Storpio, perché due anni prima ero finito sotto la mietitrebbia di mio zio. Non ci avevo rimesso la gamba come Persichetti, ma poco c’era mancato. Fatto sta che ora il piede destro non toccava terra, lo tenevo a fatica sui pedali, ma pedalavo. E chi ci rinunciava alla bici a quattordici anni in quello spurgo di campi e capannoni della zona industriale?
Lo conoscevo, quel posto, ci avevo portato Zina. E pure la Bice, ma volevo dare soddisfazione a Spreco. Era la prima volta che si andava insieme a pescare, mi aveva sempre evitato fino a quel giorno.
Smontammo dalle bici e le appoggiammo ai pioppi del filare.
«Pare neve» aveva detto Spreco scalciando e alzando una nuvola di piumini. Se eri allergico, lì rischiavi di restarci stecchito, quasi non si respirava. «È bello qui» avevo detto io, sfilando davanti a un televisore sfondato, al cestello di una lavatrice, tra i rovi un tot di preservativi e buste di plastica. Di acqua, ce ne era rimasta poca, era una fogna a cielo aperto. I connettori arancioni scaricavano i liquami della fabbrica di profilati di Cesare Bormida, me l’aveva detto mio padre che era iscritto a uno di quei comitati per salvare il fiume.
Spreco si tolse le scarpe e le scalciò tra i ciottoli.
«Le tieni, tu?» aveva detto ghignando.
Avevo abbassato gli occhi fino a leccare il greto del fiume. Certo che le tenevo, non avrebbe fatto piacere a nessuno mostrare un piede deforme.
«Le canne?»
«Stanno lì» aveva detto Spreco indicando una frasca di rovi.
Erano canne rudimentali, niente a che vedere con la mia, erano senza mulinello, niente esche. Meglio così, quel posto era una cloaca, avrei dovuto cambiare filo e tutto, una volta tornato a casa. Mi ero arrotolato i pantaloni alle caviglie. Si vedeva la cicatrice, ma Storpio era preso a scavare buche per cavare un verme. Aveva tirato fuori pure due bastoni belli grossi. «Che ci facciamo con questi?» avevo chiesto indicandoli.
«Ci ammazziamo i pesci, che altro? Pensavi alle vipere?»
Ero rimasto in silenzio, mentre con uno zeppetto lavoravo il terreno, mi faceva schifo toccarlo, era scuro, sgranato e mandava un odore nauseabondo.
Ci eravamo seduti su una pietra dilavata in mezzo al fiume per avere almeno un metro d’acqua in cui immergere filo e vermi.
«Madonna cara, se l’ho preso» aveva gridato a un certo punto Spreco.
Si era alzato in piedi, aveva perso il baricentro e per poco non era finito in acqua, tanto ero contento. Aveva tirato su un cavedano, le squame dorate, il sottomento bianco come i polpacci squamati di mia nonna. L’aveva tirato a riva, slamato e, tra urla e strepiti, l’aveva finito col bastone. I ciottoli si erano venati di rosso, a me veniva da vomitare.
Fu proprio in quel momento che sentii che aveva abboccato. Sembrava grosso, avevo preso a indietreggiare, per paura di finire con il culo a mollo nella melma. Non riuscivo a tirarlo fuori dall’acqua per quanto pesava. «Pesca d’altura» aveva detto Spreco e si era fatto una risata untuosa come la pelle del pesce che aveva ributtato in acqua e che ora galleggiava trasportato dalla corrente.
A riva, una volta che mi ero sentito saldo sulle gambe, avevo dato uno strattone ed era venuto fuori dall’acqua. Non era un cavedano.
«Porca schifa» aveva detto Spreco tra i denti.
Avevo mollato la canna e mi ero messo a correre come meglio potevo trascinando la gamba offesa, poggiando tutto il peso su quella buona.
«Dove cazzo corri, non mozzica mica» mi aveva urlato dietro quello, ma io avevo già raggiunto la bici, era montato in sella e ripercorso il sentiero a tutta birra.
Da quel giorno Spreco non mi aveva più degnato di uno sguardo. Se ci si incontrava al bar di Ferruccio, mi lanciava dietro dei nomi. Fifone, merda al culo, cacasotto e altre robe simili. Io facevo finta di niente, tiravo dritto. Quello che restava della mano era poca carne e unghie nere. Il braccio era stato tagliato al gomito, era bianco, corrotto dal fiume, trascinato dalla corrente.
LA PACE NEL MONDO
Gabriele Picco
La pace nel mondo vinse il premio Nobel per la letteratura. Il giorno della cerimonia a Stoccolma la pace nel mondo apparì molto nervosa, indossava un abito lungo e scuro. Quando si accinse a leggere il discorso divenne tutta rossa in viso, balbettò tremolante e poi disse: “Scusate, avevo preparato il discorso convinta di aver vinto il Nobel per la pace e non quello per la letteratura”. E qui scattò un applauso infinito che la tranquillizzò e le consentì di improvvisare un dignitosissimo discorso. Appena la cerimonia si concluse, la Svezia dichiarò guerra alla Cina.
LEGGETE BENGALA!
ISCRIVETEVI A BENGALA!
Ray Banhoff scrive cose che leggerete solo da lui, nella sua esplosiva newsletter che fa luce nella notte dei giorni tutti uguali. Editoriali umorali, libri, fotografie, scazzi, slanci, musica: tutta roba buona.
Abbiamo deciso che Mollette e Bengala sono cugine, per affinità, per simpatia, perché sì.
Quindi noi, cioè Davide e Jacopo, vi invitiamo a cliccare QUI e a seguire le scintille di Bengala.